Morte e redenzione del letterato occidentale

È nato in Ucraina e vive negli Stati Uniti: eppure Adam Zagajewski è quasi il prototipo dell’intellettuale europeo. Colto e raffinato, i suoi versi (Dalla vita degli oggetti, Adelphi 2012) ospitano volentieri riferimenti ai filosofi e artisti dei quali si è nutrito. Apprendiamo così che molto ama la musica – rigorosamente classica: Schumann, Bruckner, Bach, Sostakovic, soprattutto i languidi Chopin e Mahler – ma nomina spesso il silenzio. Temuto, amato.
Ama guardare. Non saprebbe decidersi, tra un quadro e una veduta alla finestra. Quindi venera l’Italia, ci si trova a casa, l’ha percorsa a lungo: Siena, Cefalù, Pisa, Montepulciano, Torino, l’Umbria e la Liguria. Adora le città d’arte e girovaga per musei scherzando su custodi che strillano «No flash!» e aggeggi che esigono una moneta per illuminare absidi o pale d’altare. Passeggia spesso tra i boschi; nei parchi, ammira le foglie dei castagni «stirate da un ferro invisibile». Ed è un paesaggista non meno virtuoso dei suoi prediletti pittori fiamminghi (straordinario l’incipit di Mattina a Vicenza). Eppure.
Eppure, leggendo le sue poesie così levigate – le immagini esatte, le elencazioni piane e concrete, l’andamento alto senza essere sostenuto – si avverte persistente il senso di una sconfitta. Natura e cultura fanno baluginare grandi promesse che non mantengono. I loro cammini s’interrompono, all’improvviso. Per la consapevolezza della finitezza universale. Del tempo che non si ferma, dell’infanzia che è irrimediabilmente perduta. Una patina di malinconia vela lo sguardo, le tele a olio e il volo delle rondini. «Abitiamo nella nostalgia. Nei sogni si aprono / serrature e chiavistelli». Sì, nostalgia per ciò che ancora (r)esiste e tuttavia, ineluttabilmente destinato a scomparire, già quasi non è più. Il mondo sopravvive al suo futuro.
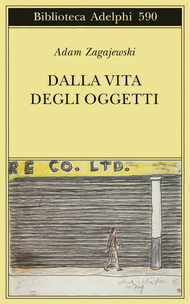 La cultura è insufficiente; quella contemporanea, poi, autoreferenziale fino all’alienazione: «I nostri saggi, / le nostre guide sono tristi e folli / e forse sanno anche meno di noi, / persone usuali». Perfino gli intellettuali più sagaci non possono ambire a essere qualcosa più di «benedettini di un’epoca atea, missionari di una facile disperazione». E in fondo, non è neppure questione di un secolo o un altro. Perché è la bellezza stessa a non bastarsi. La bellezza, «mistica per principianti, / un corso introduttivo, prolegomeni / di un esame rimandato / a più tardi». L’estetica implode, se non diventa estasi. Tertium non datur.
La cultura è insufficiente; quella contemporanea, poi, autoreferenziale fino all’alienazione: «I nostri saggi, / le nostre guide sono tristi e folli / e forse sanno anche meno di noi, / persone usuali». Perfino gli intellettuali più sagaci non possono ambire a essere qualcosa più di «benedettini di un’epoca atea, missionari di una facile disperazione». E in fondo, non è neppure questione di un secolo o un altro. Perché è la bellezza stessa a non bastarsi. La bellezza, «mistica per principianti, / un corso introduttivo, prolegomeni / di un esame rimandato / a più tardi». L’estetica implode, se non diventa estasi. Tertium non datur.
Zagajewski confessa. Fragile, indebolito, si scopre soprattutto solo, estromesso dalla vita proprio per colpa di quell’occhio ironico che tutto «vede senza penetrare». Autoesiliatosi in un punto di osservazione inattaccabile e siderale, l’intellettuale rischia l’imbalsamazione interiore, lo svuotamento da ogni passione, il verso ben tornito eppure muto. Perché se «nessuna forza / salda tra loro gli elementi, / che cosa sono le parole, da dove viene / quella luce interiore?».
Rendersene conto è già scuotimento salutare dal tepore, rassicurante quanto mortifero, di uno sguardo autosufficiente, appagato, onanistico. Serve la contemplazione, un tacere che non è afasia, ma penetrazione «nel cuore silente del raccoglimento», apertura all’ignoto, spazio per l’altro, aneliti a un pur vago brivido metafisico: «Senza nome, invisibile, silente, / salvami dall’analgesia, / portami nella Terra del fuoco, / portami là dove i fiumi / scorrono in verticale».
Rinasce l’esigenza di un’arte capace di riscuotere il cuore «nascosto sotto il cotone ben stirato», arte che non è più godimento museale-mummificante, ma sferzata vitale – come quella che Zagajewski riceve dal Risorto «quasi folle» di Piero della Francesca. E infine, sì, osiamo: una certezza. La certezza che vi è salvezza solo negli altri, come recita la poesia qui sotto.
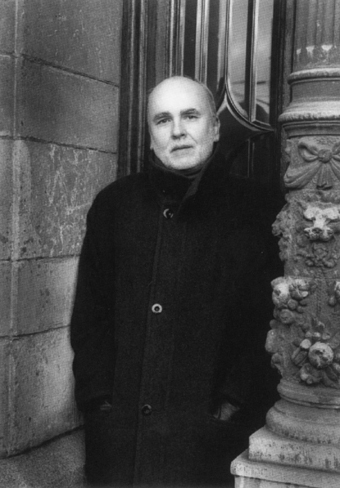
E dunque scendere in strada.
Incontrare i passanti.
«Ognuno tiene in mano / un pugno di infinito».
NELLA BELLEZZA ALTRUI
Solo nella bellezza altrui
vi è consolazione, nella musica
altrui e in versi stranieri.
Solo negli altri vi è salvezza,
anche se la solitudine avesse sapore
d’oppio. Non sono un inferno gli altri,
a guardarli il mattino, quando
la fronte è pulita, lavata dai sogni.
Per questo a lungo penso quale
parola usare: se lui o tu.
Ogni lui tradisce un tu, ma
in cambio nella poesia di un altro
è in fedele attesa un dialogo pacato.
Questo articolo è apparso su RomaSette il 20 Novembre 2012

Paolo mi sto innamorando del tuo modo di scrivere :D
E grazie per avermi fatto scoprire questo autore, mi ha colpito molto la frase “Ognuno tiene in mano un pugno di infinito”.
a patto che non scivoli pure io nel verso ben tornito eppure muto : D