Senza l’odore dei poeti
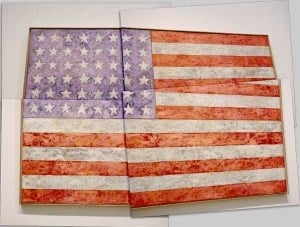 Negli ultimi anni l’interesse per la nuova poesia statunitense è cresciuto costantemente. Se ci è possibile generalizzare, forse un po’ troppo sommariamente, proprio questo colpisce maggiormente: essa vive su una soglia. Non porta con sé sentimenti accesi, visioni talmente folgoranti da esaurire l’immaginazione, storie che hanno un senso definito. Le poesie dei «ultimi americani» d’oggi non sono prive di sentimento, immagini e storie. Tutt’altro. Tuttavia, in un linguaggio ordinario, comune, che ha già vinto ogni tentazione d’ermetismo, esse si dimostrano essenziali sia nel loro realismo sia nel loro procedere meditativo.
Negli ultimi anni l’interesse per la nuova poesia statunitense è cresciuto costantemente. Se ci è possibile generalizzare, forse un po’ troppo sommariamente, proprio questo colpisce maggiormente: essa vive su una soglia. Non porta con sé sentimenti accesi, visioni talmente folgoranti da esaurire l’immaginazione, storie che hanno un senso definito. Le poesie dei «ultimi americani» d’oggi non sono prive di sentimento, immagini e storie. Tutt’altro. Tuttavia, in un linguaggio ordinario, comune, che ha già vinto ogni tentazione d’ermetismo, esse si dimostrano essenziali sia nel loro realismo sia nel loro procedere meditativo.
I cosiddetti «poeti beat» sembrano morti e sepolti in una riserva archeologica. I nuovi poeti non hanno l’«odore dei poeti»: non si danno arie da artista. Scriveva in una sua lettera la grande scrittrice statunitense Flannery O’Connor proprio a proposito dei beat: «Non sono credibili nemmeno come poeti, troppo presi come sono a recitare la parte. Il vero poeta è anonimo in fatto di abitudini personali, mentre questi ragazzotti devono a tutti i costi avere l’aspetto, l’atteggiamento, per non dire l’odore del poeta». Non troviamo «pose» né «odori» nella poesia statunitense approdata in Italia (che ovviamente è solo una piccola parte di quella realmente composta e pubblicata). Questi poeti «vivono» e la poesia diventa esperienza, modalità non «alternativa», ma «ulteriore» di conoscenza del mondo. Scrive John Koethe: «[…] le poesie sono solo un pretesto/ per una condizione a cui non so dar nome, che fluttua oltre il linguaggio/ come il pensiero del paradiso, ma meno definita». E conclude così: «Non so dove nella penombra cominciò una preghiera. Alzai gli occhi/ alla cupola per l’ultima volta, poi uscii verso il sole,/ verso l’anonimato e la libertà della piazza affollata» (In Italia). Gli fa implicitamente eco Mark Strand: «E’ vero, come ha detto qualcuno, che/ in un mondo senza paradiso tutto è addio» (Porto oscuro, XVI).
Il paradiso non è «sesso, droga e rock’n’roll», ma è fondato su rapporto solido col mondo, un corpo a corpo per nulla ingenuo o sprovveduto, ma meditato, sofferto e goduto nella sua intensità. Questa conoscenza «ulteriore» può avvenire in forma visionaria e fluviale, come nel caso di Charles Wright, noto traduttore di Montale, che si ispira a San Giovanni della Croce: «le nostre preghiere – come vestiti, come scaglie di cenere – che prendono il volo senza di noi/ in un sempiterno,/ che continua senza di noi,/ azzurro dentro azzurro dentro azzurro –/ le nostre preghiere, come schegge di vetro esauste d’acqua,/ vorticanti nella risacca, levigate e indistruttibili e lucenti,/ le nostre vite un graffio nel cielo, indolori, impossibili da rievocare» (Via negativa). Oppure può avvenire nella maniera asciutta, abbottonata e spaesata di Charles Simic: «Sto a un incrocio/ dove non dovrei stare./ Solo e senza cappotto/ sono uscito a cercare/ un cane nero che riconosce il mio fischio» (Impero dei sogni).
Una poesia di «potenza»
I risultati migliori si hanno quando il dettaglio realistico asciutto mette in azione la potenza percettiva del lettore. Come avviene in alcuni versi di Robert Pinsky, traduttore di Dante: «Soffiava il vento. Certi giorni, gocce/ di pioggia grandi come monetine/ esplodevano sul marciapiedi» (La generazione prima). Una goccia di pioggia «esplode» nella percezione nel cadere tintinnante di monete su un marciapiede. L’immagine è impoetica (almeno rispetto ai canoni tradizionali), non «sublime», ordinaria (come il riferimento al marciapiede), ma proprio per questo vivissima. Un altro esempio, questa volta di Mark Strand: «Questo è il luogo. Le sedie sono bianche. Il tavolo splende./ La persona che vi siede fissa la cerea incandescenza» (La veduta). La percezione potenziata, resa ulteriore forse è debitrice della poesia di Williams Carlos Williams, il quale a sua volta si era lasciato ispirare dall’intensità e dalla concisione della poesia cinese. Pinsky invita a «sentire i sollievi della Grazia/ immeritata, come una strada di valli,/ alture e laghi inesplicabili, trovati/ in una pianura che non ha laghi – o sentire/ i sensi: formaggio, pane, mele/ aspre e vino, ettari infuocati/ di girasoli in Spagna, mansarde/ nel Vermont, un calesse e un leopardo dipinti» (Tristezza e felicità). La presenza della Grazia assume il volto di una mela, del pane, degli oggetti quotidiani e di un paesaggio ordinario. I dettagli della vita, anche i più crudi, i più sensuali, i più banali, allora «esplodono» in maniera non aulica e non enfatica.
Accanto a Pinsky e Mark Strand occorre segnalare almeno Robert Hass. Musica sommessa si apre col verso: «Forse dovresti scrivere una poesia sulla grazia» e prosegue, qualche verso dopo: «[…] forse allora, una luce normale,/ una musica sommessa sotto le cose, un che di incombente come la grazia appare». E la grazia appare in varie forme, se la si sa cercare, come in Frammento di tempesta di Strand, dove un fiocco di neve impalpabile entra in una camera, facendosi spazio fino al bracciolo della poltrona, dove c’è chi si accorge dell’attimo in cui si posa: «[…] Tutto/ qui. Null’altro che un solenne destarsi/ alla brevità, al sollevarsi e cadere dell’attenzione, rapido,/ un tempo fra tempi, funerale senza fiori: Null’altro/ tranne la sensazione che questo frammento di tempesta,/ dissoltosi davanti ai tuoi occhi, possa tornare,/ che qualcuno negli anni a venire, seduto come adesso sei tu, possa dire:/ “E’ ora. L’aria è pronta. C’è uno spiraglio nel cielo”». Un piccolo dettaglio diventa una finestra spalancata sul mistero.
Questa potenza si applica al mistero biblico in Lucille Clifton (1936), che in alcune sue arcolte sceglie personagi chiave dell’Antico e del Nuovo Testamento (Adamo, Eva, Mosè Davide, Lucifero, Betsabea, Giobbe, Giovanni, Maria, Lazzaro,…) o giorni liturgicamente significativi come il triduo pasquale, e ad essi si accosta con la sintesi epigrammatica e folgorante dei suoi versi. La prima cosa che colpisce aprendo questo libro è ciò che manca: punti e virgole, maiuscole, versi pieni e non continuamente spezzati. La sua espressione appare minimalista, contratta, franta. Eppure non le servono molte parole. Ogni sua composizione è un «colpo d’occhio» fulmineo espresso in una lingua difficilmente traducibile perché costellata di espressioni slang, di termini ebonics, una sorta di dialetto usato nella comunità afroamericana. Come giustamente commenta la sua traduttrice, Elisa Bigini, le figure di riferimento di questa poesia sono due: Walt Withman, per la sua capacità di identificazione con gli ambienti e i personaggi, ed Emily Dickinson, per la capacità di parlare delle intime e quotidiane esperienze, nella quale si incarnano i misteri della salvezza. Certamente il suo è un verso del tutto antisentimentale e fortemente e densamente intuitivo. Di Mosè scrive: «la mia casa sta bruciando in me/ come un cespuglio/ che Dio tiene d’occhio. E così nella poesia pasquale canto di primavera: «il verde di Gesù/ sta aprendo la terra/ e il dolce/ odore del delizioso Gesù/ dischiude la casa e/ la danza della musica di Gesù/ trattiene l’aria e/ il mondo si muta/ nel corpo di Gesù e/ il futuro è possibile».
Una poesia di attesa
Forse un’acuta percezione dell’attesa – cioè di una situazione liminare, di «soglia» – la chiave di volta di questi versi. La misura del verso è dunque quella della domanda sbilanciata verso una risposta, come Koethe afferma splendidamente: «Qualcosa era sospeso nell’aria, s’è posato nella mia mente/ e vi è rimasto. A volte mi chiedo/ cosa mi sono messo a cercare» (In Italia). La domanda non è guidata da una logica consecutiva, ma da un evento che accade o che resta «sospeso nell’aria». L’immagine rinvia istintivamente a una ulteriorità, a una trascendenza. La forza della poesia è quella dell’essenzialità espressiva che innesca un’esplosione di immagini e storie, per cui ogni realtà si carica talmente di significati che vive in un equilibrio instabile, sbilanciato verso il simbolo (e viceversa).
E questo è vero per Ruth Fainlight (1931), la cui poesia Visitazione sembra raccogliere in un’unica immagine la tensione fondamentale che abbiamo rintracciato fin qui: «Un’onda crespa di spuma chiara e silente / come un foglio di vetro che scivola attraverso / la ghiaia che bagna i tuoi piedi prima / che tu te ne accorga e si smorza e svanisce / o a un sospiro di vento sotto la porta / che solleva l’angolo del tappeto soltanto / un momento e poi lo lascia posarsi come se niente fosse, / sebbene tu sappia che invece qualcosa è avvenuto». Un altro nome da tener presente è quello di Mary Oliver (1935), premio Pulitzer, che ancora attende una traduzione nella nostra lingua. Nella sua Oche selvatiche comunica il senso della potenza dell’immaginazione, capace di far esplodere il dettaglio realistico in direzione di un senso e di una vocazione: «Chiunque tu sia, non importa quanto solo, / il mondo si offre alla tua immaginazione / ti chiama, come le oche selvatiche, austere ed eccitanti / ancora e ancora proclamando il tuo posto / nella famiglia delle cose».
Che senso ha per noi leggere la recente poesia statunitense, dunque? Sì, certo, avere una prova del fatto che essa sia è viva e vegeta. Ma soprattutto serve a tenere desta l’attenzione sul senso della poesia intesa come forma di comunicazione ordinaria, di esperienza onesta e di conoscenza ulteriore della realtà quotidiana, dell’esistenza senza pose, di una attesa di grazia e di senso. Si tratta forse, a suo modo, di una forma virtuosa di declinare del «sogno americano».

Prima di inserire un commento, assicurati di aver letto la nostra policy sui commenti.