Quasi un rap
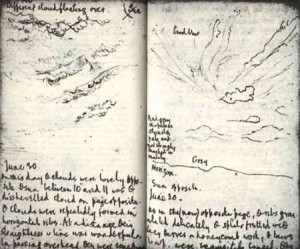 Le ha lette anche ai suoi studenti, quando insegnava al liceo. «E piacevano molto, i ragazzi apprezzavano soprattutto il loro ritmo, quasi rap». Padre Antonio Spadaro, gesuita originario di Messina, è redattore di Civiltà Cattolica. Si occupa fondamentalmente di letteratura, ma anche di arte e di musica rock, di cinema e di nuove tecnologie; ha scritto su Proust e su Jovanotti, sulla pedagogia di sant’Ignazio e sulle “forme del religioso in internet”. Gerald Manley Hopkins è una presenza antica e costante nella sua vita, al punto da avere usato le poesie del grande autore inglese per i suoi esercizi spirituali e addirittura a scuola.
Le ha lette anche ai suoi studenti, quando insegnava al liceo. «E piacevano molto, i ragazzi apprezzavano soprattutto il loro ritmo, quasi rap». Padre Antonio Spadaro, gesuita originario di Messina, è redattore di Civiltà Cattolica. Si occupa fondamentalmente di letteratura, ma anche di arte e di musica rock, di cinema e di nuove tecnologie; ha scritto su Proust e su Jovanotti, sulla pedagogia di sant’Ignazio e sulle “forme del religioso in internet”. Gerald Manley Hopkins è una presenza antica e costante nella sua vita, al punto da avere usato le poesie del grande autore inglese per i suoi esercizi spirituali e addirittura a scuola.
Hopkins addirittura un poeta rap, non è un po’ eccessivo? La lingua di Hopkins è una lingua di assoluta modernità, tanto che all’epoca sua – visse nella seconda metà dell’Ottocento, in pieno clima vittoriano – fu assolutamente incompreso. È stato il Novecento a riscoprirlo, ad apprezzare il suo verso spezzato, la sua libertà sintattica, il suo gusto per la sonorità delle parole. Hopkins ha inventato una lingua, e poeti come W. H. Auden, Seamus Heaney, Dylan Thomas hanno apertamente riconosciuto il loro debito nei suoi confronti. Certo, nella traduzione molto va, inevitabilmente, perduto: l’inglese è una lingua ritmica mentre l’italiano è fondamentalmente melodico. L’ideale sarebbe che la lettura dell’italiano servisse da introduzione alla lettura dell’originale; meglio ancora, all’ascolto, perché la lingua di Hopkins dà il massimo quando è letta ad alta voce. Io ho una rara registrazione di suoi versi recitati da Dylan Thomas, e l’effetto è straordinario.
Tutto questo come emerge ne La freschezza più cara che lei stesso ha contribuito a curare? Un piccolo pacco di esplosivo ad alto potenziale, come scrive Attilio Bertolucci. La voce di un uomo che per tutta la vita si è chiesto: «Come salvare la bellezza dallo svanire lontano?», come recita il primo verso de “L’eco di piombo e l’eco d’oro”, una delle sue poesie più straordinarie. La bellezza, che per Hopkins è la percezione dell’origine delle cose, la capacità di cogliere le cose nella loro freschezza originaria, nella freschezza della loro creazione. Per lui il poeta è un nuovo Adamo, che dà un nome per la prima volta alle cose. Che, come dice un altro verso che abbiamo scelto non a caso come titolo della raccolta, coglie «la freschezza più cara» che vive nella realtà. Che scopre nella realtà quell’«eccesso di presenza» che solo la bellezza riesce a comunicare.
La presenza di Dio? Certo. Il mondo «è carico della bellezza di Dio» scrive. Ma attenzione, carico non vuol dire gravato, appesantito; carico nel senso di una carica elettrica, di una tensione che dà vita. Le sue liriche sono disseminate di vocaboli come luce, folgore, fiamma, lampo: è una continua accensione. Dio non è il fondamento statico dell’essere, ma l’autore di ogni fremito, dell’energia che lo muove, delle polarizzazioni, dei contrasti.
Anche drammatici, a quanto pare. Nelle sue poesie compare chiaro il cruccio della caducità della bellezza, del suo svanire… Secondo Benedetto Croce, che pure lo ha tradotto piuttosto bene (alcune traduzioni di Croce sono riportate nell’appendice al volume, ndr), Hopkins era un grande poeta “nonostante” fosse gesuita. Invece la sua vocazione religiosa è un elemento costitutivo della sua poesia. Il suo è lo sguardo degli Esercizi spirituali di sant’Ignazio, così carico di capacità di “discernimento”, cioè di discernere, distinguere, vedere acutamente gli aspetti di una cosa. Pensi a “L’eco di piombo e l’eco d’oro”, testo chiave della sua produzione, dove all'”eco di piombo” che lamenta lo sfiorire di ogni cosa risponde l'”eco d’oro”: «un altro luogo, beato luogo, uno ce n’è [dove] non un capello, né un ciglio, non il minimo ciglio è perduto; ogni capello / ogni capello del capo è contato».
Poi ci sono i cosiddetti sonetti terribili… Sì, i sonetti che ha scritto nei momenti più bui della depressione, sull’orlo della disperazione. Ma, vede, anche qui si tratta di un’angoscia “fresca”: non c’è niente di letterario, di culturalizzato, come in tanta letteratura dell’assurdo che si compiace, si avvoltola nell’affermazione del non senso della vita. L’angoscia di Hopkins è sincera, è il dramma di chi fa esperienza di cos’è la vita umana senza la bellezza, di chi percepisce l’incompiutezza insuperabile della condizione umana. In “Che la natura è un fuoco eracliteo e del conforto della resurrezione” dice: «Basta! La resurrezione, squillo del cuore!» è il grido che prorompe dopo aver elencato i mali della vita. Hopkins sa che Dio non è una placida conquista, ma il grido, il desiderio che la primavera invada l’essere. La domanda di stare sempre nell’origine (“being in the beginning” è il formidabile originale), per riscoprire sempre che «questo aggeggio, gioco, povero gioco, citrullo, truciolo» che sono io «è diamante immortale». E nell’inglese “diamond” è nascosto “I am”, io sono.
Una lezione quanto mai attuale… Sì. Hopkins può insegnare agli uomini d’oggi, stanchi, nichilisti, lo sguardo che coglie la bellezza di tutto ciò che è sorgivo, iniziale. E non è spiritualismo. In “A che serve la bellezza mortale” spiega che è la «bellezza mortale», quella della vista, della carne, che «fa danzare il sangue», quella che risveglia i sensi, a ridestare anche la coscienza, a spalancarla alla realtà. Hopkins ha questa capacità di trasmettere il suo sguardo e di modificare il mio sguardo sulla realtà. Per questo mi accompagna da quindici anni.
di Roberto Persico (@ Tempi, 17 aprile 2008)

Prima di inserire un commento, assicurati di aver letto la nostra policy sui commenti.