Pance impossibili e possibili surrogati
GREULOT, NACHI STULÒ me tengo ‘na
“La fame dello Zanni”, Dario Fo
fame, ‘na sgandula che pe’ la desperasián u
zervèl me STRÒPIA A SGRÒLL. Deo che
fame! Gh’ho ‘na fame che me magnaría anca
un ögio (mima di cavarsi un occhio) e me lo
ciuciaria ‘me ‘n’òvo. (Succhia l’immaginario
uovo) Un’orégia me strancaria! (Fa il gesto di
strapparsi un orecchio) Tuti e dòi l’oregi
(esegue e li mastica con avidità) ol naso
cavaria. (Esegue) Oh, che fame tégno! Che
me enfrocarla ‘na man dinta la boca, ziò in
t’ol gargaròz fino al stomego e CAÒ IN
PRATOSCIÒ GUIU (mima tutta l’azione) e
stroncaria da po’ le bidèle, tute le tripe a
STROSLON FRAGNAO (mima di cavarsi le
budella tirandole fuori attraverso la gola,
quindi le arrotola sul braccio) STROPIAN
CORDAME – SRUTOLON.
Inizia così “La Fame dello Zanni”, il monologo di Dario Fo all’interno del suo “Mistero Buffo” del 1969. Difficile descriverlo a parole, andrebbe visto ed ascoltato!
Ma chi è questo Zanni? Lo Zanni è «il prototipo di tutte le maschere della Commedia dell’arte» ci spiega Fo, «però, a differenza di quasi tutte le maschere che hanno nomi e comportamenti inventati, questa ha un origine reale […] Zanni era il soprannome che fin dal xv secolo i Veneziani davano ai contadini provenienti da tutta la Lombardia, il Piemonte e le province del Garda e dell’Adda». Questi, infatti, si ritrovarono stremati dalla povertà e dalla concorrenza delle merci a basso costo che arrivavano dall’estero e, prosegue Fo, «si riversarono nelle città e nei porti più ricchi del Nord. In particolare a Venezia. In grandissimo numero gli Zanni scesero a Venezia con le loro donne a cercare lavoro; accettarono i lavori più bassi dallo svuotare latrine al facchinaggio al porto, si adattarono al ruolo di sottoservi, quasi schiavi. Le loro donne, oltre che ricoprire il ruolo di serve e sguattere, si dedicarono alla prostituzione». È dallo Zanni che poi sarebbero derivate altre maschere più note come Arlecchino o Brighella.
Dario Fo adotta il grammelot – linguaggio teatrale, miscuglio di dialetti, parole inventate, onomatopeico e gestuale – per mettere in scena uno Zanni talmente esausto della propria fame che mangerebbe persino se stesso, prima un occhio, poi un orecchio, le budella e più avanti le montagne, il cielo, Dio, i cherubini e persino… il pubblico. La pancia dello Zanni è talmente vuota che potrebbe ingerire di tutto, metafora di un periodo, fame storica, ma anche universale: ad animare lo Zanni di Fo è una disperazione che si
smorza nel comico, ma ci lascia un senso di vuoto che si risucchia da solo, un buco nero che potrebbe scomparire in un attimo dal palco.
Se la pancia dello Zanni sembra potersi riempire all’infinito, ce ne è un’altra da cui, al contrario, sembra poter uscire di tutto. Spostiamoci dalla Lombardia al lontano Giappone. L’anno è lo stesso, il 1969. Il mangaka Fujiko F. Fujio, realizza per la rivista “CoroCoro Comic” il personaggio di Doreamon.
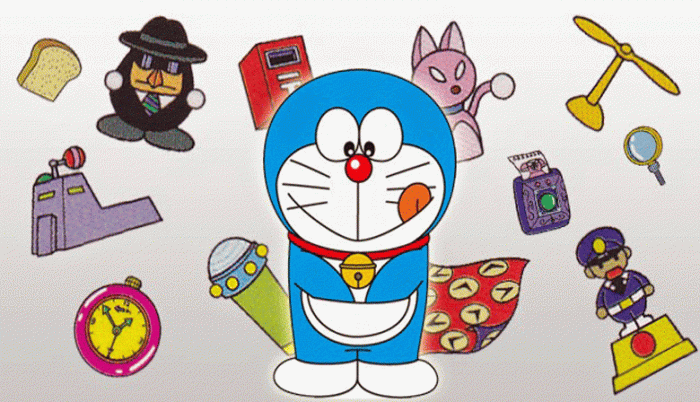
Ecco Doraemon, gatto robot, la pancia grande, piu’ grande che puo’.
Bravo Doraemon, con tutte le cose nella sua tasca magica, Mamma che noia studiare a casa, ora Doraemon ci aiutera’.
Come recita la sigla anni ‘80 degli Oliver Onions per la trasposizione italiana della serie anime, Doraemon è un gatto robot inviato dal futuro per assistere nella crescita il piccolo Nobi Nobita (da noi l’indimenticabile Guglia Guglielmo Guglielminetti), altrimenti destinato ad una vita di continui fallimenti.
Doreamon ha una tasca (come i canguri) da cui può estrarre qualsiasi tipo di chusky, futuristici gadget con i quali aiuta Nobi Nobita in ogni situazione. La sua pancia è sostanzialmente il gimmick dell’intera serie, ogni episodio presenta un chusky diverso ed ha, in questo senso, un valore positivo; se la pancia dello Zanni rappresenta la povertà, quella di Doraemon rappresenta la sicurezza, la varietà, la confort zone da dove uscirà, in qualche modo, una soluzione per tutto.
Se il passaggio da Dario Fo a Doraemon può sembrare ardimentoso se non addirittura infantile, in realtà ci fa da ponte per un altra “applicazione” della pancia.
Quando Fujiko F. Fujio creò graficamente Doraemon si ispirò ad alcune bambole tipiche dell’artigianato nipponico chiamate Okiagari-koboshi (起き上がり小法師), letteralmente “piccolo monaco sempre in piedi”.

Realizzate partendo da una struttura di legno poi rivestita di cartapesta e decorata, se ne ha traccia sin dal XIV secolo e la loro caratteristica è quella di riuscire a mantenere sempre una posizione eretta, anche quando vengono toccate e fatte cadere. In Giappone queste bambole sono considerate dei portafortuna, simboleggiano l’equilibrio, la pazienza e la resilienza. Tradizione vuole che, prima dell’acquisto, si debbano rovesciare tutte le bambole e poi scegliere solo tra quelle che sono ritornare in piedi, se ne prende una per ogni membro della famiglia ed una in più a scopo propiziatorio… magari per la nascita di un altro figlio… che guarda un po’ nasce proprio dalla pancia della mamma.

Ma ne siamo così sicuri? Per capire meglio questa altra funzione della pancia ci è stato suggerito il documentario “Comizi d’amore” realizzato da Pier Paolo Pasolini nel 1964 per interrogare gli italiani sul tema della sessualità e testare la loro pruderie su argomenti come prostituzione, sesso, omosessualità e divorzio.
Nello specifico, la domanda “come nascono i bambini?” viene rivolta ai bambini stessi. Pasolini scegli i figli della classi più popolari del Sud e le risposte che riceve (a parte “dalla pancia” timidamente citata una sola volta) contemplano: cavoli, cicogne, cicogne che prima vanno da Dio, “o fiore”, uno zio ed una fantomatica “levatricia”. Per i picciriddi di Pasolini la domanda è divisiva, anche nelle reazioni, c’è chi ride, chi scherza, chi risponde con malcelato pudore e chi invece ostenta sicurezza nel dare credito a questi ingegnosi surrogati.
Anche a distanza di tempo, in un divertente video del 2016 realizzato da Adnkronos intitolato “Che fine ha fatto la cicogna”, la pancia della mamma rimane ancora un luogo misterioso, per iniziati, che confonde… anche se per questi bambini moderni il cerchio sembri stringersi sempre di più intorno alle figure genitoriali: ci sono un serpentello ed una pallina, il matrimonio come conditio sine qua non, c’è un papà che non ha fatto altro che stare tutto il tempo al cellulare, un “qualcosa” a.k.a. “un semino” e poi c’è Dio (che sempre pone e dispone).

E le cicogne? E chi sarebbero costoro? Alcuni di questi bambini non credono neppure che esistano!
E poi perché proprio le cicogne? Proviamo a chiudere il cerchio con una spiegazione, in fondo se la sono guadagnata: dunque, filologicamente parlando una risposta la potremmo trovare sin dal 1839 in una omonima fiaba di Hans Christian Andersen, in cui si nomina senza troppe spiegazioni uno “stagno in cui si trovano tutti i bambini piccoli in attesa che le cicogne li portino dai loro genitori”, altrimenti una spiegazione più etologica si rifarebbe alla abitudine delle cicogne (prima dell’invenzione del termosifone s’intende), di fare il nido in primavera vicino ai comignoli dei camini, spesso ancora accesi proprio perché in casa era appena arrivato un neonato… di qui l’accostamento leggendario tra le une e gli altri.
Prima o poi la scienza, sono sicuro, ci darà una risposta definitiva.
