La gentilezza che spezza il cuore di pietra
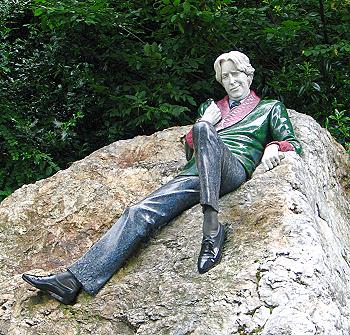 Il De profundis, tra le più intense della produzione di Oscar Wilde, è una lunga lettera a lord Alfred Douglas. Perché Wilde l’ha scritta? Per rispondere è necessario entrare almeno succintamente nella biografia dello scrittore. La vita di Wilde è definibile come “estetica”, catturata dalla bellezza e dai suoi riflessi fascinosi. In fondo poi tutto, fino a un certo punto, andò bene nella sua esistenza: una brava e affettuosa moglie, due bambini, il successo. Ma non durò a lungo. L’affetto per la moglie era fin troppo spiritualizzato ed estetizzante per resistere. I luoghi dove il giovane Wilde, certe notti, si perdeva erano i bassifondi, dove andava alla ricerca di ragazzi sessualmente compiacenti. L’equilibrio creato non poteva durare a lungo e infatti si spezzò quando Wilde fece la conoscenza di lord Douglas. Quest’amicizia portò lo scrittore insieme all’esaltazione e alla rovina economica e morale. La parabola discendente giunse a portare Wilde in tribunale, giudicato e condannato per pederastia. Siamo nell’Inghilterra del 1895. Il mondo di Wilde, già uomo di successo, si capovolse.
Il De profundis, tra le più intense della produzione di Oscar Wilde, è una lunga lettera a lord Alfred Douglas. Perché Wilde l’ha scritta? Per rispondere è necessario entrare almeno succintamente nella biografia dello scrittore. La vita di Wilde è definibile come “estetica”, catturata dalla bellezza e dai suoi riflessi fascinosi. In fondo poi tutto, fino a un certo punto, andò bene nella sua esistenza: una brava e affettuosa moglie, due bambini, il successo. Ma non durò a lungo. L’affetto per la moglie era fin troppo spiritualizzato ed estetizzante per resistere. I luoghi dove il giovane Wilde, certe notti, si perdeva erano i bassifondi, dove andava alla ricerca di ragazzi sessualmente compiacenti. L’equilibrio creato non poteva durare a lungo e infatti si spezzò quando Wilde fece la conoscenza di lord Douglas. Quest’amicizia portò lo scrittore insieme all’esaltazione e alla rovina economica e morale. La parabola discendente giunse a portare Wilde in tribunale, giudicato e condannato per pederastia. Siamo nell’Inghilterra del 1895. Il mondo di Wilde, già uomo di successo, si capovolse.
Gli anni di carcere furono durissimi, confortati solo da qualche lettura, e tra queste quella di Dante, del Nuovo Testamento, dei Pensieri di Pascal, della Vita di Gesù di Renan. In questo contesto Wilde scrisse il De profundis, che si configura come il grido stesso dell’anima che dall’abisso della disfatta cerca di risalire alla luce: “Dalla mia natura sono venuti fuori una selvaggia disperazione, un abbandono al dolore pietoso da guardare, furore terribile e impotente, amarezza e sdegno, angoscia che piangeva a gran voce, infelicità che non riusciva a trovare sfogo, dolore muto. (…) non potevo sopportare che (le mie sofferenze) fossero senza significato. Ora trovo, nascosto da qualche parte della mia natura, qualcosa che mi dice che niente al mondo è senza significato, e meno di tutto la sofferenza”. Cosa è capace di trasformare il “dolore muto” nella “bellezza del dolore”? La risposta si può trovare in un’opera di Wilde forse meno nota eppure strordinaria: The Ballad of Reading’s Gaol (La ballata del carcere di Reading), un poemetto di 109 sestine scritto dopo la scarcerazione. Scontata la sua pena, Wilde si rifugia a Berneval, un paesino della Francia.
Lì comincia a comporre l’opera che uscì esattamente 110 anni fa, nel 1898, dapprima anonima: il suo nome apparirà solo nella settima edizione fino alla quale l’autore si celò sotto i numeri della sua matricola carceraria “C33”. Il protagonista è un uomo, di cui non viene fatto il nome, che aveva ucciso la donna che amava e che la legge ha giustiziato.
La Ballata si apre con l’immagine del condannato che cammina tra i carcerati con un triste abito grigio. In pochi tratti Wilde prosegue descrivendo tasselli e figure di vita carceraria, con straordinaria efficacia fino a descrivere quella “sete morbosa / Che ti insabbia la gola, prima / che il boia con i suoi guanti da giardiniere / Esca dalla porta imbottita / E ti leghi con tre corregge di cuoio, / Che la gola non provi sete mai più”. Wilde percepisce il pianto, la “guancia che trema”, la preghiera “a labbra di creta” mai fuori dallo sguardo altrui.
Viene il giorno dell’esecuzione della sentenza e l’autore riflette: “Come navi a bufera spinte / Incrociammo le rotte: / Segno o parola non facemmo, / Nulla c’era da dire; / Non la santa notte incontrammo, / Ma di vergogna il giorno”. Non la santità aveva segnato il loro incontro, ma la vergogna, ciascuno nella sua cella, nel suo “inferno separato: il mondo ci aveva espulsi dal suo cuore, / E Dio dalla Sua cura”. Il senso dell’abbandono vince la riflessione e le immagini luminose perché ci si scopre presi dalla “ferrea tagliola” del peccato, trapassati dalla sua spada “fino all’elsa avvelenata”. La preghiera accompagna queste emozioni di tristezza e di angoscia (“Tutta notte pregammo inginocchiati”). L’orologio della prigione “Trafisse l’aria tremante” e “Al gancio di trave annerita / L’unta corda vedemmo, / La preghiera si udì che il laccio / In stridìo strangolò”. Il cadavere, nudo e incatenato, “avvolto in un lenzuolo di fiamma“, è ceduto alla calce che lo divora. Quel pezzo di terra sarà interdetto alla semina perché sconsacrato. Resterà sterile e spoglio perché in carcere pensano “che un cuore di assassino corromperebbe / Anche i loro semi innocenti”. Ecco il “dolore muto”, espressione di una condanna senza appello.
Ma a questo punto il grido di Wilde è incontenibile nel suo sdegno: “Non è vero! La terra di Dio è gentile”, pietosa, migliore più di quanto la mente dell’uomo possa sapere o immaginare: “La rosa rossa potrebbe fiorirvi / più rossa ancora e più bianca la bianca”. La Grazia ha percorsi insondabili e si manifesta proprio dove l’angoscia divora il cuore e il senso del peccato sembra non lasciar respiro. Alla “dolce aria di Dio”, al raggio del suo sole potrebbe venire “Dalla bocca una rosa rossa! / Una bianca dal cuore!”. Infatti “chi può dire per quali strane vie / Cristo porta alla luce la Sua volontà?”. La via della Grazia può essere strana, insolita, ma viene comunicata dal fatto che “il Figlio di Dio è morto per tutti”.
La “strana via” parte dalla Croce di Cristo, davanti alla quale la sofferenza senza senso e il “dolore muto” diventano grido di appello prima e poi di stupore per la salvezza che ricorda da vicino ciò che sant’Ignazio scrive nei suoi Esercizi Spirituali, dopo aver proposto la meditazione sul peccato: “Grido di stupore con profonda commozione, considerando che (…) la terra non si sia aperta per inghiottirmi, creando nuovi inferni per tormentarmi in essi per sempre” (n. 60). Si ha la netta percezione che la “gentilezza” della “terra di Dio” sia icona, immagine viva della salvezza.
Le leggi di Dio, quelle eterne, sono come la terra: gentili, clementi, buone a tal punto che spezzano il cuore di pietra. E questa frattura è la porta attraverso la quale Cristo può entrare nella vita di un uomo. Nessuna durezza può sbarrargli il passo: “Ogni cuore umano che si spezza / In cella o cortile di carcere, / È come l’anfora spezzata che rese / Il suo tesoro al Signore, / E colmò la casa del sudicio lebbroso / Del profumo del più prezioso nardo”. Anche se di pietra, il cuore spezzato dalla Grazia è come l’anfora di nardo che nel Vangelo appare infranta per profumare i piedi di Cristo. E questo profumo stilla da un cuore di peccatore, anche da quello di un omicida. Allora, esclama Wilde, “Beati coloro il cui cuore può spezzarsi / E conquistare la pace del perdono!”. Anzi, “Se non per il cuore spezzato / Come entrerebbe Cristo?”. Il cuore spezzato è una condizione perché il vangelo e il perdono non scorrano via come su una superficie impermeabile.
Il carcere può diventare luogo di salvezza perché a contatto con il Cristo, la bruttura del peccato è tolta, e la “bellezza del dolore” si rivela. Ecco la conclusione e la risposta alla domanda che ponevamo all’inizio: il dolore “bello” è quello proveniente dalla commozione stupita che si ritrovano coloro il cui cuore è stato spezzato dalla gentilezza di Dio. Ecco “il centro motore dell’arte di Wilde”: “L’uomo non può arrivare al cuor divino se non attraverso quel senso di separazione e di perdita che si chiama peccato” (James Joyce).
da L’Osservatore Romano – 16 luglio 2008

Un testo imprevedibilmente intenso, il De Profundis di Wilde. Confesso che non l’ho mai amato come scrittore, tanto che la lettura del Ritratto di Dorian Gray mi è risultata irritante e fastidiosa. Troppo il gusto per i paradossi, troppa la voglia di stupire il lettore, in un testo irrimediabilmente soffocato da un simile insopportabilmente costante impulso barocco. La medesima irritazione mi ha suscitato L’importanza di chiamarsi Ernesto, commedia (oggi si direbbe “brillante”) fondata sull’equivoco generato dall’ambiguità di un nome, e sì, sulla parodia di una classe con le sue contraddizioni, ma pur sempre all’insegna di una frivolezza che, alla fine, non disseta quelle fauci esigenti, che si nutrono davvero solo col profondo.
Il De Profundis, invece, testimonia di un Wilde diverso: lontano dalle leggerezze della mondanità, dai facili esibizionismi delle frasi paradossali, dalle parole che indulgono alla seduzione del ritmo ma non a quella del pensiero, l'”ultimo” Wilde sembra attraversato da una ferita che non ammette altro che di esser pensata, elaborata, rivissuta, detta…capita. Al rumore e alla scostanza del mondano, subentra il silenzio assordante del solitario.
Intensa davvero, poi, la ricognizione del perdono, con l’intimo sincero convincimento della sua necessità.