“La visione del cieco” e “Una tragedia negata”: il verbo essere e il tragico
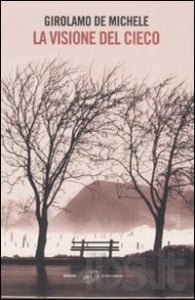
Copertina di "La visione del cieco" (Einaudi) di Girolamo De Michele
Scrivo questo post con colpevole ritardo, riprendendo in mano appunti vecchi di mesi. All’inizio l’idea era quella di scrivere una recensione al romanzo “La visione del cieco” (Einaudi) di Girolamo De Michele; poi, leggendo il saggio “Una tragedia negata” (Il Maestrale) di Demetrio Paolin, mi sono accorta che il secondo testo spiegava il primo, o meglio spiegava il motivo per cui non mi aveva convinta. Riprendendo i libri e gli appunti a qualche mese di distanza, ho deciso di concentrarmi su una caratteristica del primo e sulla tesi principale del secondo, tralasciando tutto il resto.
“La visione del cieco” è un romanzo scritto senza l’uso del verbo essere. Ho deciso di leggerlo proprio per questo, dopo che una recensione in cui si elogiava la capacità di De Michele di portare avanti una narrazione di quasi trecento pagine senza farvi ricorso mi aveva lasciata perplessa.
Leggendo le prime pagine mi sono stupita, effettivamente, di come De Michele fosse riuscito a ovviare a questa mancanza attraverso l’uso di frasi spezzate, interiezioni, ricorrendo spessissimo ai due punti e ai punti di sospensione. Eppure, in un secondo momento, queste trovate mi si sono rivelate in tutta la loro fragilità. Il motivo per cui, durante la lettura e anche in seguito, sentivo che c’era qualcosa che non andava era il fatto che il verbo essere non era stato messo fuori gioco, non era scomparso, ma era semplicemente stato nascosto.
Per spiegare meglio ciò che voglio dire sarebbe forse utile addentrarsi almeno superficialmente nel campo della linguistica, ma rischierei di essere imprecisa e di divagare*. È forse più utile, a questo punto, citare un brano del libro:
“- Come una frase senza verbo essere, – dice Andrea – Le parole rimbalzano qua e là come palle di gomma cercando un senso a cui aggrapparsi. Frammenti e schegge, storie e racconti, trame putride e trame intessute: molecole gassose che rimbalzano senza pace tra le pareti, – (agitandosi fino alla gocciolina purpurea che trapela sulla bendatura).
– Mai piaciuto quel verbo lì, – mormora Cristiano senza alzare gli occhi dalle steppe biancosporcate di fango sanguigno dove affonda il ginocchio del sergente Mario, Sergentmagiù ghe rivarem a baita?, – mai piaciuto: immobilizza la vita, fissa il movimento come un ago dentro l’insetto pronto per la teca. Una vita sottovetro…
– Ti metti a fil… a concionare sul senso della vita? – stizzisce Andrea. – Guarda che non…
(Poi evita: ma non gli occhi di Lara).
Il senso della vita non esiste, dice Andrea, Sbagli, dice Cristiano: esiste. Purtroppo. Ma non vuol dire che lo accetti solo perché esiste. Andrea annuisce, Sapevo che l’avresti detto: ma cosa c’entra adesso?, No, guarda che il senso della vita c’entra, eccome, solleva la testa Cristiano: come il senso delle parole che non si forma bloccandosi sul verbo, ma prendendosi per mano l’un l’altra. Il verbo essere inaridisce il deserto, parole profughe, il senso fugge verso la vita… esodo dal faraone, conclude cercando di non perdere il filo dei passi nella neve, ma poi il libro tace di scatto sotto la copertina, la steppa resta una baita nell’anima, il tempo si riavvolge al presente.”
De Michele, pp. 238-239
L’operazione di De Michele non può, dunque, essere casuale, ma è frutto di una precisa visione delle cose, di una scelta in qualche modo esistenziale prima che linguistica.

Copertina di Una tragedia negata (Il Maestrale) di Demetrio Paolin
Come dicevo all’inizio del post, per comprenderne meglio i motivi e le conseguenze è stata illuminante la lettura di “Una tragedia negata” di Demetrio Paolin, un saggio uscito qualche mese fa per Il Maestrale. In breve, Paolin, prendendo in analisi una parte consistente della narrativa italiana che parla degli “anni di piombo”, sostiene che in questi testi manca la dimensione “tragica” di quel periodo, dal momento che viene fuori solo una parte della storia e che la figura della vittima resta sullo sfondo.
In questi libri, la realtà viene descritta in maniera frammentaria, viene reinventata, non viene raccontata per intero anche per la convinzione che sia impossibile farlo. Si fa ricorso al complotto, si cerca di rileggere la storia con distacco o di ambientarla in un salotto borghese, la si racconta solo dal punto di vista dei terroristi, mentre la vittima viene vista come un’unità indivisibile (la Polizia, lo Stato), muta, oscura.
Dice Paolin:
“Il complotto è consolante, il complotto mi mette al sicuro. Trasforma un accadimento, l’omicidio, il rapimento di qualcuno in altro. Ne fa un simbolo di qualcosa che è marcio, spostando l’attenzione dal particolare al generale. In questo modo si elude il tragico sostenendo che niente è mai come si vede. Il complotto, la sua teoria e la sua paranoia (contrariamente a ciò che avviene nel romanzo americano, penso a Ellroy e Don Delillo) non portano in superficie il tragico vero, ma anzi lo nascondono e lo cancellano.”
Paolin, p. 34
La storia viene raccontata da una sola delle due parti, mentre l’altra rimane una sagoma di cartone, non viene riconosciuta:
“I romanzi di cui mi occupo non danno cittadinanza narrativa alla vittima, che viene lasciata sullo sfondo. Non si dà ragione di lei, della sua vita, se aveva figli, se aveva sogni, cosa pensava del mondo, come si muoveva nella società. La vittima è un ordigno narrativo: serve per far andare avanti la storia, ma non possiede spessore”.
Paolin – p. 39
La vittima non ha profondità, per cui è impossibile provare pietas nei suoi confronti, dice Paolin. Anche i movimenti del terrorista, dell’assassino sono meccanici, lui stesso non si rende conto di cosa sta facendo, perché non vede la persona che sta uccidendo.
Appare chiaro, quindi, che non riuscendo a vedere, a riconoscere la vittima, gli autori di questi libri non riescono a dare forma alla dimensione tragica, e di conseguenza gli stessi protagonisti rimangono piatti, indifferenti, apatici, non riescono a dare un valore alle proprie azioni**. Attraversare il tragico non significherebbe fare una scelta ideologica, tentare di indottrinare il lettore, non lasciargli libertà di scelta o addirittura avere una visione consolatoria della letteratura. Significherebbe, al contrario, attraversare un territorio doloroso (e realmente doloroso), dando a ciascuna parte una profondità, mettendo veramente le due parti in rapporto, facendo sì che si riconoscano a vicenda, pur rimanendo ciascuna al proprio posto.
Ma che relazione c’è tra un romanzo in cui viene meno l’uso del verbo essere e un saggio che analizza la narrativa italiana sugli anni di piombo? Credo che le due cose siano strettamente legate, in realtà, e che la critica di Paolin possa estendersi anche a quella parte della narrativa italiana contemporanea che non parla di quelli anni né più in generale della storia d’Italia. La scelta di non usare il verbo essere, a mio parere, è la conseguenza di questa visione delle cose, di questa elusione del tragico: in entrambi i casi si cerca di sviare, di nascondere, di cancellare. Si preferisce una verità frammentaria, mobile, imprecisa, alla possibilità di una verità intera. Ci si rende conto che la verità esiste, ma si sceglie di non riconoscerla.
D’altra parte, come si è visto all’inizio, viene detto esplicitamente da uno dei protagonisti di “La visione del cieco“: il senso della vita esiste, ma non per questo, solo perché esiste, può essere accettato. Tutto questo, come lo stesso personaggio ammette, è strettamente connesso alla scomparsa del verbo essere, è il tentativo di eludere il tragico, di sfuggire alla realtà. Si tratta di una dichiarazione chiara, che denuncia una difficoltà propria non solo di De Michele, non solo dei libri sugli anni di piombo, ma di gran parte della narrativa italiana di oggi.
Nella maggior parte dei casi, a mio parere, credo che questa difficoltà dipenda dall’incapacità di vedere le cose nella loro complessità e dalla scelta, più o meno consapevole, di vedere nelle parole solo parole, nel verbo essere qualcosa di cui, con un po’ di mestiere, si può fare a meno. Mi sembra che molti libri nascano dal tentativo genuino di denunciare delle situazioni di cui non si parla, di raccontare storie dimenticate, ma credo che gli autori di questi libri si fermino troppo presto, che non portino a termine il proprio compito, che credano che il compito finisca lì o che non riescano ad andare avanti.
Paradossalmente, i libri degli ultimi anni non fanno che parlare di dolore, di morte, di tragedia, di Male. Eppure sviano, non affrontano mai il discorso, non lo attraversano mai davvero e, in questo modo, sviliscono le parole, fanno perdere alle parole “dolore”, “tragedia”, “morte”, “male” il loro reale significato. Alla mistificazione della realtà, quella che parte di questi romanzi intende denunciare, si risponde con un’altra mistificazione, operata dagli stessi autori.
Il limite che Paolin individua nella narrativa sugli anni di piombo torna quindi anche qui. Si tratta, a questo punto, di una difficoltà generale degli scrittori italiani, che sembra giochino contro la verità una partita che credono di aver perso in partenza. Una serie di pregiudizi, di difficoltà, un’incapacità di vedere le cose che si riflette, come si vede nel caso di De Michele, anche nelle scelte linguistiche e stilistiche.
* Non ne ho, dopotutto, le competenze. Rimando, ad ogni modo, ad A. Moro, The raising of predicates, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
** “Riccardo esce dal bar, per fortuna il meccanismo è scattato anche stavolta: non sente niente, non prova altro che un dispiacere lontano, una nausea appena accennata, ma come per qualcosa che non gli appartiene. Niente gli appartiene veramente, non quella roba, no, quella non gli appartiene.”. da G. M. Villalta, Tuo figlio, Mondadori, Milano 2004, p. 58.

Splendido articolo
Applausi per Maura… io credo che questa incapacità di vedere le cose nella loro complessità, di delineare la dimensione di una “scelta”, derivi dall’esclusione dal proprio orizzonte della possibilità del bene… non riescono a crederci, a concepirla.
Grazie a entrambi.
Io non direi che ci sia da parte di questi scrittori un’esclusione della possibilità del bene (De Michele ne è la prova); direi piuttosto che, data la complessità che comporta l’attraversamento di un campo minato, si preferisce sviare, camminare ai bordi piuttosto che attraversare il campo.
Non si tratta di escludere dal proprio orizzonte la possibilità del bene, ma di escludere dal proprio orizzonte la complessità delle cose. Solo in questo modo può avvenire un vero attraversamento, un vero riconoscimento, solo così si può svelare la verità.
Accogliere nel proprio orizzonte unicamente la possibilità del bene, per esempio, avrebbe esattamente le stesse conseguenze. La difficoltà sta nell’individuare la struttura reale delle cose, di dare a ciascuna cosa il proprio posto, di distinguere i vari elementi riuscendo ad avere al contempo, però, anche una visione d’insieme.
“Accogliere nel proprio orizzonte unicamente la possibilità del bene avrebbe esattamente le stesse conseguenze”… è prporio così. Ma la possibilità del bene è la fetta di complessità che più spesso manca (mi pare).
Complimenti, Maura, proprio un intervento interessante, importante.
Perché rischiare di fallire il proprio proposito di scrivere un libro confrontandosi con la complessità del reale quando può bastare una tesi, un’idea politicamente corretta o la messa in scena di clichés (Ozptek docet)? Mi sembra che l’obiettivo di tanti sia solo la pubblicazione, l’identità che ne deriva e la successiva iscrizione al club degli scrittori perché scrivere un libro apre spazi di sviluppo del proprio marketing personale.
Oggi è difficile trovare dei libri scaturiti da un’esigenza di verità sulla propria storia personale e/o familiare. Esigenza che nasce di solito dopo che ci si è sporcati e feriti con la vita, dopo che si è provato dolore, appunto. Ma il dolore oggigiorno non serve a nulla, è inutile. Non genera consenso, competenze, appartenenza, funzionalità, sapere o altri denari da spendere per ritagliarsi un’identità riconoscibile.
Dal dolore e dagli anni di piombo è scaturito, per esempio, il bellissimo libro di Mario Calabresi, “Spingendo la notte più in là” (Mondadori) in cui il figlio del Commissario Calabresi, assassinato da esponenti di Lotta Continua, fa i conti con la complessità del crescere improvvisamente senza padre, del chiedere giustizia e del perdonare, del discernere nello sciame di voci liberato dopo la morte del padre.
Ecco, 99 persone su 100 al posto di Mario Calabresi avrebbero scritto un libro vittimistico, rancoroso, scuro. “Spingendo la notte più in là” è un libro straordinario perche lui non si impedisce l’accesso alle tonalità più chiare dello spettro dei colori esistenti
Mario Calabresi ha atteso tanti anni prima di scrivere questo libro. Il suo libro non è stato il frutto di una “espressione precipitosa”. Ha atteso che le parole si facessero carne nella sua vita e dalla carne scaturisse il racconto e la riflessione. Questo significa che il dolore ha bisogno di essere ascoltato, ha bisogno di silenzio per permettere allo scrittore di udire quella voce a cui deve ubbidire per scrivere un libro che sia di “sangue e acqua” ovvero un ponte tra il visibile e l’invisibile ovvero Letteratura.
Scrive Martin Heidegger in Lettera sull’umanesimo:
“Ciò che importa, è solo che la verità dell’essere venga al linguaggio e che il pensiero pervenga in questo linguaggio. Può darsi che allora il linguaggio richieda, invece di un’espressione precipitosa, un giusto silenzio. Tuttavia chi di noi uomini d’oggi può immaginare che i tentativi di pensare si trovino a proprio agio sul sentiero del silenzio?”
In “Una tragedia negata” si parla proprio del libro di Mario Calabresi e di quello di Sabina Rossa come esempi di una visione diversa.
In particolare, in “Guido Rossa, mio padre” di trova una riflessione importante (citata in UTN): “Sono assolutamente convinta che gli ex brigatisti che hanno saldato il conto con lo Stato non possano essere considerati reati ma persone, di cui si è disposti a guardare il cambiamento”. (p. 15)
Mi sembra che qui emerga la capacità di vedere la complessità delle cose, di non chiudersi nel dolore della vittima dimenticando l’altra parte, ma considerandola una persona prima di tutto, e ponendosi nella posizione di chi è disposto a guardarne il cambiamento.
Credo che le parole usate da Sabina Rossa non siano per niente casuali e, cosa che voglio sottolineare ancora una volta, credo che la “visione complessa” di cui ho parlato non si risolva in una dialettica bene-male (anche quella sarebbe una visione parziale).
Ritengo sia difficile riassumere un discorso di questo tipo e un dolore così grande in un commento come questo. Mi sento anche un po’ in imbarazzo, a dire la verità, ma volevo riportarvi queste due citazioni, dal momento che avete parlato di “Spingendo la notte più in là”.
Sempre in UTN, dicevo, si ricorda che Calabresi doveva essere ucciso il 16 maggio, ma che poi l’omicidio venne rimandato di un giorno. Ed è veramente commovente il racconto di quel “giorno in più” che viene fatto nel libro e che, come dice Demetrio nel saggio, ci fa vedere come quello che è stato ucciso era prima di tutto un uomo:
“La sera prima avevamo giocato a nascondino. Era stato un regalo del destino. Aveva avuto un giorno in più con sua moglie e i suoi figli. Ancora una cena, qualche pagina del libro che aveva sul comodino, Krusciov ricorda, letta all’alba prima di fare il caffè, e la possibilità di scegliersi quella cravatta bianca. Fu il caso ad allungargli la vita di ventiquattrore esatte.” (p. 37)
@ Maura
La tua interpretazione si basa sulla certezza che il tragico sia la dimensione in qualche modo “reale” dell’esistenza, che la verità coincida col tragico. Legittimo da parte tua pensarlo, ma per me non è così. In un libro filosofico di qualche anno fa, “Felicità e storia”, ho esplicitamente rifiutato le letture tragiche dell’esistenza come quelle di Steiner: per me è proprio l’ipostatizzazione della dimensione tragica ad essere consolante e consolatoria. Nei miei romanzi ho sempre cercato di descrivere un processo di ricomposizione dell’infranto, di attraversamento della frammentarietà verso una verità che alla fine, in qualche modo, viene colta: e se nei primi due ho usato il genere noir, è proprio perché mi consentiva questo approccio. Solo, per me il tragico non è la verità: l’immagine del bicchiere in frantumi l’ho presa da Milton, ed è un’immagine che rimanda al senso della verità. Probabilmente non è la tua idea di verità, ma non puoi accusarmi di sviare o tenermi ai bordi della verità. Quanto alla rinuncia del verbo essere, è un espediente espressivo che serve a rendere la frammentarietà dei linguaggi quotidiani, e la reciproca inconciliabilità per l’assenza di un medium comune. Il linguaggio che ho usato è un’allegoria della frantumazione della società civile e dell’assenza di un ethos condiviso: in questo senso è vero che l’operazione è esistenziale prima ancora che linguistica – ma non è questo il senso della tua critica, se ho ben capito. In ogni caso, per me la dimensione esistenziale rimanda all’esistenzialismo, quello di Camus e Fenoglio: non certo all’aria fritta e rifritta di Martin Heidegger. Se intendi dire che ho mancato una comprensione in senso heideggeriano della questione dell’essere (e della sua tragicità), ti ringrazio: lo prendo per un complimento, e non per una critica.
In tutta sincerità, non capisco cosa abbia a che fare l’interpretazione di Paolin (che per altro condivido molto poco: e ogni volta che ci ripenso mi convince sempre meno) col mio romanzo: davvero non so dove stia l’incapacità di riconoscere la vittima, e cosa c’entrino le vittime del terrorismo con le vittime del (nel) mio libro. Mi sembra di avere, al contrario, dato molto spazio alle vittime, in tutti i sensi: sicuramente molto più che ai loro carnefici.
Non credo che il tragico sia una dimensione reale dell’esistenza, ma che sia un momento necessario dell’esistenza, date certe premesse.
Dato un certo evento x, e dato che x è un evento rilevante nella vita di P, è necessario non solo trovare x (ovvero una quantità), ma comprendere tutto il processo (quindi dare un nome – o una quantità – a una serie di altre incognite, e capire come si è arrivati a x).
Io non credo che la verità sia tragica, tutt’altro; credo solo, ripeto, che il tragico sia un momento da attraversare prima di riuscire a comprendere la verità intera. Se non lo si fa è molto difficile capire quale sia la verità, perché se ne conosce giusto una parte, mentre il momento tragico (mi rendo conto che si tratti di un termine ambiguo e quindi equivocabile, lo si potrebbe anche definire) permette di tener presenti, di far emergere tutte le parti, tutti i fattori che hanno avuto un ruolo nella riuscita di x.
Si tratta, in altre parole, della necessità di tener conto di tutti i frammenti di vetro prima di ricomporre il bicchiere. Il fine è che il bicchiere torni intero, anche se rimarranno i segni di quello che è successo.
Non vedo nulla di consolatorio in questo momento tragico (ripeto che la mia è tutto tranne che una visione tragica dell’esistenza).
Non ho fatto riferimento ad Heidegger, in verità ho preferito fare un solo riferimento, e di tipo linguistico.
Mi riesce difficile capire quale sia la tua posizione, dici di aver sempre “cercato di descrivere un processo di ricomposizione dell’infranto, di attraversamento della frammentarietà verso una verità che alla fine, in qualche modo, viene colta”, dunque proprio quello che io ti ho accusato di non fare, ma il resto mi fa pensare che non sia proprio così, che invece il bicchiere sia rimasto in frantumi e che molti di questi siano spariti.
L’unica soluzione che trovo è che tu parli d’inconciliabilità e frammentarietà a livello socio-politico, e che quindi ci sia una certa frattura tra questo livello e gli altri.
Mi sembra che ne “La visione del cieco” si rimanga in un certo senso prigionieri di questo livello, che i personaggi non siano capaci di vedere altro, e che dunque la loro unica possibilità sia quella di conoscere un frammento della realtà. La frammentarietà del linguaggio quotidiano, tutti gli espedienti linguistici e tutto quello che succede nel romanzo denotano questo, ed è precisamente questo a sembrarmi consolatorio e parziale.
“Una tragedia negata” c’entra nella misura in cui parla dell’incapacità da parte di molti autori italiani di comprendere la complessità delle cose. Credo che questo discorso, che Paolin riserva ai romanzi sugli anni di piombo e a chi li ha scritti, possa essere valido anche per molti altri romanzi.
domanda per Di Michele: tu dici che “…la rinuncia del verbo essere, è un espediente espressivo che serve a rendere la frammentarietà dei linguaggi quotidiani, e la reciproca inconciliabilità per l’assenza di un medium comune. Il linguaggio che ho usato è un’allegoria della frantumazione della società civile e dell’assenza di un ethos condiviso”. Ti chiedo: che effetto ti fa questo fenomeno della frammentarietà-frantumazione che di fatto descrivi omettendo il verbo essere? Cioè: prendi una posizione (e quale?) rispetto a questa crisi? Chiedo in anticipo perdono perchè parlo senza aver letto il libro, ma ti chiedo: c’è una via d’uscita nel tuo romanzo? ci può essere senza l’essere?
@ Andrea
è una scelta espressiva. La posizione che prendo emerge dal fatto che i personaggi, sparse schegge di una realtà infranta, gradualmente trovano linguaggi e gesti comuni, e dalla dimensione individuale passano a quella collettiva: trovano un ethos comune, fanno comunità (anche al prezzo del sacrificio personale). L’immagine finale del libro è proprio quella di due personaggi (col loro gatto) che, tenendosi per mano, “passano oltre”, “bucano la tela” che costituisce un limite. La stessa scena è ripetuta nell’incontro tra il bambino e il cane, a sottolineare la solidarietà tra i viventi umani e non umani. In una delle ultime pagine è richiamata (lo si consideri un omaggio a un Grandissimo, non un paragone) la pagina finale de “Gli Invisibili” di Balestrini: ma dove in Balestrini vincono il carcere a l’isolamento, qui prevalgono l’evasione e l’essere in comune (l’amore, se volete).
@ Maura
quanto scrivo sopra risponde, spero, anche a te. Può darsi che tu non abbia colto le trasformazioni dei personaggi, o che io non abbia saputo farle cogliere. Ma la sotto-trama “noir” dovrebbe in qualche modo far capire che l’intreccio dei delitti non potrebbe essere sciolto (e lo è) se Andrea, Olga, Lara e Cristiano, collettivamente, facendo un vero e proprio brainstorming, non afferrassero tutti i capi della matassa.
Capisco cosa dici, la scena finale rappresenta in qualche modo il tentativo di “passare oltre”, ma io credo che i personaggi non ci riescano, mi sembra che non riescano a fuggire da quella dimensione, che intuiscano qualcosa ma che non afferrino tutti i capi della matassa. Come ti ho detto, mi sembra che siano tutti prigionieri di quella dimensione, nonostante Andrea, Olga, Lara e Cristiano abbiano evidentemente una capacità “visiva” maggiore rispetto agli altri, e siano fortemente legati tra loro.
Scusate se mi intrometto senza aver letto nessuno dei due libri.
Di fronte ad una realtà infranta, il tentativo di “ricomposizione dell’infranto” mi sembra non solo legittimo, ma addirittura doveroso. Il punto è che non capisco cosa l’abbia infranta mentre vedo elevato il rischio della petizione di principio. Si dà per scontato che la realtà, la relazione, l’esperienza umana siano a pezzi, mentre la mia convinzione è che questo presupposto (falso) renda la realtà e la relazione – che, molto semplicemente, sono “già date” – terribilmente complicate e sfuggenti (e, in un certo modo, rifiutate).
Peraltro, se il presupposto è quello di una vita all’insegna della perdita, qualunque lettura non può che essere o incompiuta o consolatoria – non ci sono santi.
In particolare, vorrei chiedere a De Michele: non pensa che una scelta così estrema trasformi il suo lavoro in un mero esercizio di stile? O altrimenti una sorta di manifesto ideologico? Insomma, la dimensione narrativa non ne risulta schiacciata? Da potenziale lettore non mi sento invitato a leggere un romanzo che ad ogni riga sembri “volermi dire qualcosa” a tutti i costi; piuttosto leggo – e volentieri – un saggio.
@ Cristiano
chiaro che non sono io a doverlo dire: sto interpretando il mio romanzo, ma è appunto un romanzo, e l’intento che mi sono posto è di non scrivere “come se ogni pagina dovesse dire qualcosa”. Spero di esserci riuscito. In ogni caso a breve anche questo romanzo sarà messo nella biblioteca copyleft di http://www.iquindici.org, dove potrà essere scaricato gratuitamente (come i due precedenti): così, nel caso, fai un tentativo senza spendere soldi, poi decidi :-)
@ tutti i partecipanti alla discussione
tengo a dirvi – e vi ringrazio – che è un piacere discutere con pacatezza, senza per questo rinunciare alle proprie idee, con persone che non sostituiscono l’insulto all’argomentazione, che prestano attenzione alle parole dette prima di rispondere, e che hanno la correttezza, nel caso non abbiano letto i testi in discussione, di dichiararlo in apertura del proprio post. Non sempre nella rete si incontrano luoghi di civile frequentazione come questi.
hehehe… in un modo o nell’altro la curiosità m’è venuta, alla fine.
Grazie anche a te Girolamo, perché è altrettanto inusuale che un autore intervenga – altrettanto pacatamente – ad una discussione che, peraltro, non nasconde i propri accenti critici.
Per quanto mi riguarda, adesso ho una motivazione in più per leggere il tuo romanzo e partecipare a questa discussione: questa ipotesi di “realtà infranta” sembra essere oggi un paradigma col quale non è possibile non entrare in contatto anche nelle discussioni quotidiane, nella mentalità generale.
Ho la sensazione che sia convinzione diffusa che l’unica scelta che abbiamo sia tra combattere una guerra persa in partenza (per poter dire: almeno io ho lottato) o abbandonarsi all’ineluttabilità delle cose (e dell’incomunicabilità, dell’impossibilità di una relazione autentica, di una continua opposizione tra “io” e “l’altro” senza alcuna possibilità di un vero “noi”).
Credo di capirlo, pur non condividendolo: quello che fatico a capire è invece da dove nasca; l’unico modo che ho è proprio quello di parlare con chi questo punto di vista lo sostiene.
Questo problema mi sembra simile a quello sollevato non molto tempo fa proprio da Maura nella sua discussione con Wu Ming, proprio su queste pagine. Insomma, alla fine qui si scontrano visioni del mondo, credo.