Faust: il disgustoso e il sublime
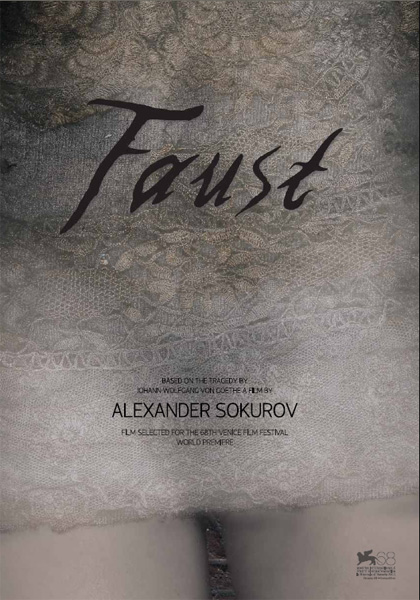 Quando ci si domanda se la letteratura può “salvare” si sottintende, in genere, la salvezza del lettore. Ma è una richiesta indebita, oltre che eccessiva: è già molto se la letteratura riesce a salvare i propri personaggi. Perché non basta un happy end caritatevolmente elemosinato dal deus ex machina di turno: se la storia naviga davvero a mare aperto, l’approdo – fosse pure quello del naufrago – non è più scontato. I capolavori di Cervantes e di Goethe sono lì a ricordarcelo, due “opere mondo” riprese in mano fino alle soglie della morte dai rispettivi autori, stratificandovi pagine che mal si adeguano con quelle dell’esordio e che tuttavia solo così – ambigue, incerte – possono sbozzare un embrione di salvezza per le proprie creature.
Quando ci si domanda se la letteratura può “salvare” si sottintende, in genere, la salvezza del lettore. Ma è una richiesta indebita, oltre che eccessiva: è già molto se la letteratura riesce a salvare i propri personaggi. Perché non basta un happy end caritatevolmente elemosinato dal deus ex machina di turno: se la storia naviga davvero a mare aperto, l’approdo – fosse pure quello del naufrago – non è più scontato. I capolavori di Cervantes e di Goethe sono lì a ricordarcelo, due “opere mondo” riprese in mano fino alle soglie della morte dai rispettivi autori, stratificandovi pagine che mal si adeguano con quelle dell’esordio e che tuttavia solo così – ambigue, incerte – possono sbozzare un embrione di salvezza per le proprie creature.
Su questo una parola in più la merita proprio il Faust di Goethe, complice la vertiginosa rilettura filmica di Aleksandr Sokurov, premiato con il Leone d’oro a Venezia. Raramente infatti, nonostante le differenze nella trama, un classico è stato portato sullo schermo con altrettanta audacia visionaria. Tanto da calzargli perfettamente la definizione che Franco Fortini coniò per il capovaloro goethiano, «monumento inquietante e intimidatorio […] di calcolate contraddizioni». Sokurov ci sprofonda in un’atmosfera di accattonaggio universale, ossessivamente dominato dalla fame, dalla miseria, dall’usura, dal tempo che scorre senza freno e tutto conduce a consunzione. È il «reame di tarme» (v. 659) nel quale il Faust goethiano si sente serrato: un mondo che urla da ogni atomo il proprio non bastare a se stesso ed è perpetuamente condannato a sperimentare la propria penuria, il radicale bisogno di oltrepassarsi e l’impossibilità di poterlo realizzare da sé. È per rimanere fedele a questa fame abissale che Faust è disposto a vendere la propria anima a Mefistofele: «Desiderare con ogni mia forza / è appunto quello che prometto […] Solo se non ha requie l’uomo impegna se stesso» (vv.1743-44.59).
 C’è solo un modo per anestetizzare questa spina, lasciarsi disorientare dallo stordimento degli istinti e dalla soddisfazione dell’istante. Ed è con questo che Mefistofele seduce Faust, conducendolo prima in una taverna, restituendogli poi la giovinezza, presentandogli infine Margherita. Perché questa ragazzina di poco più di quattordici anni scatena in Faust un desiderio di possesso così violento («Devi farmi avere quella ragazza»)? Non tanto, o non solo, per il repentino rifluire delle passioni, quanto piuttosto perché Margherita possiede ancora ciò che Faust ha svenduto (e continua a svendere) in cambio della sua scienza: «Ah, la semplicità, l’innocenza non sanno / che sono e che sacro valore hanno in sé!» (vv. 3102-03). Semplicità e innocenza, umiltà e modestia, rappresentano non tanto virtù morali, quanto un diverso approccio al reale. Ciò che agita Faust non è una sete di conoscenza fine a se stessa, incarnata invece nella sciocca figura dello studente Wagner, ma un’esigenza di unità assoluta, un mistico senso di partecipazione all’esistenza umana: «Guarito dalla smania di conoscere, il mio animo / non dovrà chiudersi a nessuna sofferenza. / e di quanto ebbe in sorte l’intera umanità / voglio godere nel profondo di me stesso, / nella mia mente accogliere le sommità e gli abissi, / stringere nel mio cuore il suo bene e il suo male / e così dilatare nel suo essere il mio / e come essa, alla fine, anch’io schiantarmi» (vv. 1768-75). Compartecipare all’esistenza umana significa condividerne gli estremi, il disgusto e il sublime. Nella sua rilettura filmica Sokurov ha saputo rendere entrambi: il primo nell’incipit, con il protagonista che fruga nelle viscere di un cadavere putrefatto alla ricerca dell’anima, trovando solo «rifiuti»; il secondo nella sequenza dei due amanti che scivolano abbracciati in uno specchio d’acqua, una scena che entra di prepotenza nella storia del cinema.
C’è solo un modo per anestetizzare questa spina, lasciarsi disorientare dallo stordimento degli istinti e dalla soddisfazione dell’istante. Ed è con questo che Mefistofele seduce Faust, conducendolo prima in una taverna, restituendogli poi la giovinezza, presentandogli infine Margherita. Perché questa ragazzina di poco più di quattordici anni scatena in Faust un desiderio di possesso così violento («Devi farmi avere quella ragazza»)? Non tanto, o non solo, per il repentino rifluire delle passioni, quanto piuttosto perché Margherita possiede ancora ciò che Faust ha svenduto (e continua a svendere) in cambio della sua scienza: «Ah, la semplicità, l’innocenza non sanno / che sono e che sacro valore hanno in sé!» (vv. 3102-03). Semplicità e innocenza, umiltà e modestia, rappresentano non tanto virtù morali, quanto un diverso approccio al reale. Ciò che agita Faust non è una sete di conoscenza fine a se stessa, incarnata invece nella sciocca figura dello studente Wagner, ma un’esigenza di unità assoluta, un mistico senso di partecipazione all’esistenza umana: «Guarito dalla smania di conoscere, il mio animo / non dovrà chiudersi a nessuna sofferenza. / e di quanto ebbe in sorte l’intera umanità / voglio godere nel profondo di me stesso, / nella mia mente accogliere le sommità e gli abissi, / stringere nel mio cuore il suo bene e il suo male / e così dilatare nel suo essere il mio / e come essa, alla fine, anch’io schiantarmi» (vv. 1768-75). Compartecipare all’esistenza umana significa condividerne gli estremi, il disgusto e il sublime. Nella sua rilettura filmica Sokurov ha saputo rendere entrambi: il primo nell’incipit, con il protagonista che fruga nelle viscere di un cadavere putrefatto alla ricerca dell’anima, trovando solo «rifiuti»; il secondo nella sequenza dei due amanti che scivolano abbracciati in uno specchio d’acqua, una scena che entra di prepotenza nella storia del cinema.

“Partecipare”, al basso come all’alto. Ecco quello che Mefistofele non fa, sarcastico osservatore delle vicende umane che brama solo il non-essere, «spirito che sempre dice no» (v. 1338) e «non prende a cuore nulla» (v. 3488). A questo egli mira ridurre chi a lui si lega. E così, mentre Goethe conclude l’opera insinuando uno spiraglio di luce per Margherita come per Faust, Sokurov – riprendendo l’originaria allegoria morale cinquecentesca – vira verso un finale molto più inquietante. Posseduta Margherita e abbandonatala ai dèmoni del rimorso, Faust fugge con Mefistofele in una landa desolata, dove intima a un geyser di scomparire, bello e inutile, perché egli ha già scoperto come funziona. Nella mente di Faust il rapporto si è ribaltato, l’esistenza è divenuta funzionale alla conoscenza. E così, definitivamente smarrito nel suo delirio di onniscienza, egli s’inoltra nell’infinita distesa di un ghiacciaio invocando l’andare oltre, oltre, oltre… Ma è un oltre fine a se stesso, una maledizione circolare e cannibale, una ricerca che non ambisce più a trovare, ma soltanto a nutrirsi di se stessa. Faust è sazio, il desiderio abiurato. Mefistofele ha vinto. Chi avrebbe potuto salvarlo era proprio quel mondo di miseria dove ancora egli era uomo tra gli uomini (vv. 938-40). Poiché Penuria – ci ricorda Platone nel Simposio – è il vero nome dell’Amore.

L’esistenza di Faust sottomessa alla conoscenza mi ha fatto riecheggiare in mente i famosi versi danteschi del XXVI dell’Inferno (vv. 118-20): “Considerate la vostra semenza:/ fatti non foste a viver come bruti, / ma per seguir virtute e canoscenza…”, con l’ambigua mescolanza fra fascino e condanna per il comportamento ulissiaco, carico di ybris, che li impregna. Se si schiaccia la vita per il sapere si incorre in un “folle volo”, nella perdizione di sé e degli altri, nell’allontanamento dai confini dell’essere; se si subordina il sapere alla vita ci si incammina in un “altro viaggio” come quello che Virgilio suggerisce a Dante. Un viaggio che non è ritto, perché non esclude la presenza e la conoscenza del male ma che presuppone un suo superamento in un orizzonte di accettazione del sacro.
Con Faust e Ulisse si ripropone il paradigma di Eva che asseconda la sua curiositas, condannandosi al peccato e al dolore ma anche aprendosi alla vita e all’amore. E aggiungerei alla narrazione, perché senza rischi, cadute, voli, scommesse sul sapere non ci sarebbe cambiamento, spinta all’innovazione e perciò racconto.
Di tutta l’orazion picciola c’è una parola sempre poco considerata, ed è quella “e” che sigla la corretta circolarità ermeneutica da stabilire tra virtus e ratio. L’Ulisse dantesco – abbandonando l’innocente Penelope – è il primo a cortocircuitarle, sancendo l’implosione della propria stessa narrazione. Anche in Faust la donna – Margherita/Gretchen – è il reagente che si combina con il polo contrario alla curiositas, ella è la “e” riequilibratrice che Mefistofele/serpente mira quindi a distruggere.
Senza errore non potrebbe esserci amore? Goethe risponde con il suo verso immortale «Es irrt der Mensch, solang er strebt» (v. 316), «Erra l’uomo finché cerca». Viviamo in media res, siamo l’intreccio della storia, pensarci diversamente varca le colonne d’Ercole della nostra immaginazione. Una cosa è certa: per strada c’è un lupus in fabula che ci attende. Possiamo attendere la sua imboscata, oppure andare a stanarlo.
Non credo che l’abbandono di Penelope da parte di Ulisse sancisca l’implosione della sua stessa narrazione, ma che anzi la riattivi in modo nuovo, introducendo una variante del mito che ne ha garantito la sopravvivenza, nei secoli e nella memoria letteraria e culturale dell’Occidente, come simbolo immortale della ricerca conoscitiva che sfida sé stessa e gli orizzonti del sacro. L’Ulisse omerico non viaggia per conoscere ma per tornare: e il suo nostos sarà possibile solo con una riconciliazione con la divinità profanata. L’Ulisse dantesco non viaggia per tornare ma per conoscere: e il suo percorso non sarà possibile perché rompe il patto con la divinità e con la tradizione di valori rappresentata dalla patria e dalla donna, che il suo antenato omerico aveva faticato per riconquistare. E tuttavia, come Faust, da questa spinta alla “gnomè” ne ottiene l’eternità narrativa.
Concordo, invece, con l’idea che la figura femminile rappresenti la “e”, il vincolo fra virtus e ratio e la Divina Commedia ce lo dimostra quando Dante si ricongiunge con Beatrice nel Paradiso, chiudendo con lei, che rappresenta il bene, quel viaggio di sperimentazione del Male attraverso cui ha conosciuto sé stesso. Dall’errore all’amore: così si definisce la parabola dantesca. E forse ogni ideale parabola umana.
Se fosse la spinta conoscitiva ad eternare i personaggi letterari, allora il Faust che oggi ricordiamo dovrebbe essere quello del mito originario che – come l’Ulisse dantesco – si (con)danna nella ricerca solitaria. Il Faust che si è affermato, invece, è quello della reinterpretazione goethiana, con i finali delle due parti che culminano nell’ambigua salvezza dei suoi due protagonisti: per questo aprivo l’articolo con la considerazione sulla difficoltà di maturare una “fine credibile”. E’ piuttosto il gioco dell’et, l’incerta scommessa del libero arbitrio, la possibilità fino all’ultima pagina di accettare o respingere la mano tesa, a dare tensione e dinamismo durevoli alla narrazione.
Il verso «Erra l’uomo finché cerca» sottolinea che il desiderio, anche conoscitivo, gira a vuoto se il suo cercare non è indirizzato a un (s)oggetto concreto. Gli «orizzonti del sacro» che vengono sfidati da una ricerca afinalistica sono gli orizzonti della società e della comunione umana. La mano di Eva sul pomo sigla un divorzio gnoseologico: d’ora in poi saranno possibili verità senza amore e amore senza verità. Ecco allora i due fragili finali ai quali Goethe giunge per rappresentare una riunione con il comune/sacro: nel primo Margherita, salvata dagli angeli, chiama a sé l’amato; nel secondo il coro mistico invoca l’Eterno Femminino «che ci trae in alto». La circolarità tra ricerca conoscitiva e comunione amorosa è restaurata.