A partire da.. “I pianeti” di G. Holst
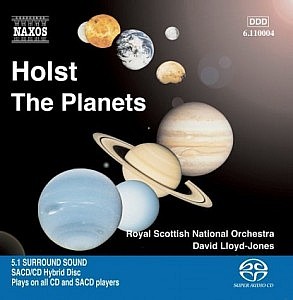 I pianeti, la suite composta da Gustav Holst tra il 1914 e il 1916 nasce dall’interesse del musicista per l’astrologia, una pratica divinatoria molto vicina alla chiromanzia e ad altre pratiche magiche (molto in voga anche oggi) con cui si pretende di predire il futuro in base all’osservazione della posizione dei pianeti rispetto alla Terra. Holst era tanto affascinato dai pianeti e aveva così fiducia nel loro potere sull’essere umano da dedicare a ciascuno di loro una composizione (in quei giorni scriveva ad un amico: «è il carattere di ogni singolo pianeta ad offrimi un mucchio di suggerimenti ed è per questo che mi interesso piuttosto assiduamente di astrologia»). Ogni pezzo avrebbe dovuto rappresentare il carisma grazie al quale ciascun pianeta è in grado di condizionare la psiche delle persone. In questo senso, per individuare il carattere dominante di ciascun pianeta il compositore inglese si servì di un libro di un noto astrologo del suo tempo e probabilmente anche della mitologia romana. Composta nei primi anni della Grande Guerra e in tempi di bellicose avanguardie artistiche, l’opera si apre con Marte che nei titoli viene presentato come colui che porta la guerra, segue Venere colei che fa rinascere l’amore, Mercurio l’alato messaggero portatore di nuove risorse e, così via, anche gli altri quattro pianeti allora conosciuti (manca Plutone che venne scoperto quindici anni dopo la composizione dell’opera).
I pianeti, la suite composta da Gustav Holst tra il 1914 e il 1916 nasce dall’interesse del musicista per l’astrologia, una pratica divinatoria molto vicina alla chiromanzia e ad altre pratiche magiche (molto in voga anche oggi) con cui si pretende di predire il futuro in base all’osservazione della posizione dei pianeti rispetto alla Terra. Holst era tanto affascinato dai pianeti e aveva così fiducia nel loro potere sull’essere umano da dedicare a ciascuno di loro una composizione (in quei giorni scriveva ad un amico: «è il carattere di ogni singolo pianeta ad offrimi un mucchio di suggerimenti ed è per questo che mi interesso piuttosto assiduamente di astrologia»). Ogni pezzo avrebbe dovuto rappresentare il carisma grazie al quale ciascun pianeta è in grado di condizionare la psiche delle persone. In questo senso, per individuare il carattere dominante di ciascun pianeta il compositore inglese si servì di un libro di un noto astrologo del suo tempo e probabilmente anche della mitologia romana. Composta nei primi anni della Grande Guerra e in tempi di bellicose avanguardie artistiche, l’opera si apre con Marte che nei titoli viene presentato come colui che porta la guerra, segue Venere colei che fa rinascere l’amore, Mercurio l’alato messaggero portatore di nuove risorse e, così via, anche gli altri quattro pianeti allora conosciuti (manca Plutone che venne scoperto quindici anni dopo la composizione dell’opera).
Le musiche sono tutte molto coinvolgenti, evocative, di grande impatto emotivo e figurativo, ma non esiste un filo conduttore: l’opera di Holst non è una sinfonia e la combinazione dei brani è totalmente priva di narratività. I pianeti sono presentati come tante monadi, scollegati l’uno dall’altro, tanto privi di una storia comune quanto forti del proprio particolare carisma. Ciascuno di essi costituisce una figura mitica, ma in virtù della potenza riconosciutagli dall’uomo e non in virtù di una storia di cui è portatore e che condivide con gli altri pianeti. In altre parole, ogni pianeta sembra essere un mito privato della narrazione: una vistosa contraddizione considerando che “mito” deriva dal greco mythos che significa parola, discorso, racconto. Eppure oggigiorno il termine “mito” è usato spesso in questa accezione, quella di un idolo muto e statico di fronte a cui l’uomo rimane imbambolato, passivo, abbacinato come davanti a uno specchio magico in grado di riflettere una inaspettata quanto sorprendente immagine di se stesso e della propria vita.
Il mito-idolo è sempre uguale a se stesso e proietta la propria immagine presente nel futuro, negando a chi ne rimane sedotto la percezione del divenire della propria realtà. In questo senso, i pianeti celebrati da Holst, nel loro riconosciuto potere di preveggenza e di ascendenza sul destino dell’uomo, possiedono la stessa infallibilità e capacità profetica di “miti” a noi più familiari come certe icone del rock (Jim Morrison) o della rivoluzione (Ché Guevara): figure dalle indiscusse qualità, almeno fino al momento in cui un dettaglio della storia del personaggio non ne riduce il potere di attrazione e identificazione. Ma fino a quel momento, il mito è qualcosa con cui entrare in contatto per provare la sensazione di essere più forti nel rapporto con il mondo. È immagine che ingrandisce il nostro io nella misura in cui crediamo possa rivelarci la nostra identità segreta e indicarci il futuro (ancora più segreto) ovvero l’immagine di noi nel futuro. In questo senso, l’identità e il futuro corrisponderebbero, secondo la visione proposta da Holst nelle intenzioni di questa sua magnifica opera musicale, con un ingrandimento della persona umana.
Ma l’esperienza artistica non ci dimostra invece il contrario? Un’opera d’arte non è piuttosto il risultato di un lento e imprevedibile processo di trasformazione? La scrittrice Flannery O’Connor (sì, sempre lei) negava qualsiasi forma di preveggenza nell’atto dello scrivere ovvero dichiarava di non sapere cosa sarebbe accaduto ai suoi personaggi e cosa sarebbe intervenuto nella sua storia neppure due righe prima di scriverlo. Oggigiorno siamo talmente abituati a misurare la nostra identità con i miti-idoli e con l’immagine altrettanto mitica richiestaci dall’efficienza produttiva dovuta nel lavoro che nei laboratori di scrittura creativa molti faticano ad accettare l’idea che la scrittura, come ogni arte, richiede un’ascesa: un lento sviluppo della propria capacità di visione della realtà e della propria abilità nell’utilizzo della parola scritta. Il laboratorio è un luogo di confronto dove spesso alcuni partecipanti rimangono delusi dalla realtà del proprio testo quando viene svelata dai commenti degli altri partecipanti in veste di lettori. Restano delusi del testo come se lo fossero di se stessi. Non si accorgono che quel testo è la vita di una storia che inizia, l’inizio di un processo di cambiamento i cui esiti sono totalmente sconosciuti, ma già presenti in potenza come un embrione lo è per un essere umano non ancora formato. Lo scrittore (anche se scandalizzato dalla pochezza della prima stesura del suo testo) può decidere se entrare attivamente in questo processo di trasformazione e, quindi, accettare o meno di portare la sorprendente quanto faticosa gestazione che trasformerà il suo testo a poco a poco in una storia unica e soprattutto viva.
Per fare un esempio noto a tutti, utilizziamo Blade Runner, il film di fantascienza di Ridley Scott in cui il detective Deckart (Harrison Ford) dà la caccia ad un gruppo di “replicanti” fuggiti dal controllo degli umani e in cerca della chiave che li renderà liberi per sempre. La vera libertà del replicante passa attraverso la presa di coscienza del proprio passato, la consapevolezza di avere una propria storia, ma soprattutto nel comprendere di essere protagonista di una trasformazione che esige relazione, umiltà ed esercizio. Ma solo Rachel, la bella replicante che piange quando scopre di non essere umana, lo capisce. Gli altri replicanti Nexus 6 sono morbosamente attaccati all’immagine della propria potenza, non vogliono perderla, anzi vogliono ingrandirla. Sono già più forti e intelligenti di qualsiasi essere umano, ma vogliono esserlo per sempre, vogliono il dono dell’eternità, fissare la loro immagine presente nel futuro. E per questo periranno. Rachel invece accetta di imparare a poco a poco da Deckart l’amore ovvero si riconosce fragile (è per chiunque il primo passo per percepirsi “umano”) e si rende disponibile ad entrare in un processo di trasformazione che potrebbe farle vivere una vita pienamente umana. E per questo Deckart decide di non eliminarla.
La fissità in nome dell’immagine di noi stessi che ci rende (illusoriamente) giusti, forti e preveggenti è il pericolo da evitare. La vita è un processo di trasformazione, da quando nasciamo a quando moriamo, e non un processo di ingrandimento. Questo è il grande equivoco. Allora forse si tratta di cominciare a guardare i pianeti non nella loro fissità in un dato momento, ma nel loro movimento e nel loro essere parte di un universo che si sta trasformando. Proprio come ognuno di noi. Se il cielo non ruotasse durante la notte, se gli astri sopra la nostra testa fossero sempre gli stessi, la notte sarebbe una prigione, una cappa soffocante. E invece il cielo è una realtà dinamica. Come la buona musica d’altronde. Infatti – tornando ai pianeti di Holst – ciò che sorprende è che, al di là delle intenzioni concettuali e filosofiche del compositore, la musica scritta per ogni pianeta non è affatto statica, anzi è vitale e potente proprio perché gravida di divenire e di orizzonti. Non è un caso che I pianeti abbiano ispirato molte colonne sonore di Hollywood ovvero composizioni utilizzate proprio per esaltare il potenziale narrativo delle immagini del film. Non c’è forse la potenza della vita ovvero il racconto di una trasformazione in atto nelle vertigini marziali di Marte, nei richiami pieni di nostalgia di Venere, nelle corse a perdifiato di Mercurio, nell’allegria sfrenata di Giove, nell’infaticabile laboriosità di Saturno (il mio pezzo preferito), nell’inquieta fanfaronaggine di Urano o nell’attento ascolto del Mistero di Nettuno?

L’ uomo e il suo destino
La Vita umana non è solo la trasformazione dell’Io(ego) la sua dilatata intuizione sul passato e sul futuro, ma una continua Conversione nell’Essere.
L’Io più meno dilatato o mitico resta sempre una prima persona al singolare.
L’Essere contiene in ogni lingua la nozione di Esistenza.
L’Io è una piccola parte nella totalità psichica del Sè(Gustav Jung).
Il Sè è quella parte, invece, che ricorre all’idea di Soffio di Aurea, di Vento, che si avverte ma non si vede, cioè l’Anima.
L’ Ego (Io) rimane spesso incastrato nel suo bisogno d’affermazione, nel bisogno d’essere amato.
l’Io soffre quando è negato e si dibatte in una tragica lotta di vita o di morte, nel presente, nel tentativo di determinare e prevedere il suo futuro.
Il Sè nell’Essere si libera dal legame terreno, o degli astri, guarda in faccia e accetta il suo Destino.Accetta di Essere ciò per cui è stato predestinato, dando il meglio di Sè sempre.
Nella Fede l’uomo abbandona il rapporto individuale con Dio,instaura un rapporto personale(di persona) e nel Cammino si lascia guidare dalla ” preveggenza” di morte e resurrezione del suo misero io in un atto continuo di conversione verso ciò che è senza tempo: l’Infinito Amore.
Madre Teresa di Calcutta
http://www.youtube.com/watch?v=Wllt9qaFMew
Ascoltando i brani, mi tornava a mente “Il carnevale degli animali”, cioè: che cosa sarebbero gli animali se fossero musica.
Ma mi sono anche chiesto: come si potrebbero descrivere oggi i pianeti?
In una raccolta di saggi di Isaac Asimov ho letto che lui disprezzava i poeti che parlavano delle stelle e dell’amore, perché non capivano niente di quello che le stelle fossero veramente. E se lo avessero capito si sarebbero guardati bene dall’associare i due termini! Più o meno era una cosa simile, adesso non ricordo, e chissà dove ho cacciato il libro. Tolta l’arrroganza ironica tipica di Asimov, qualche ragione ce l’ha.
Studiando geografia astronomica mi colpiva quanto le stelle e i pianeti fossero a tutti gli effetti qualcosa di inconcepibile: le dimensioni e le energie in gioco sono talmente fuori dalle nostre capacità di comprensione che non dicono assolutamente nulla, o ci mettono di fronte ad una vastita che terrorizza al punto da scappare di fronte alla contemplazione.
Mi colpì però un’intervista su Le Scienze ad una ricercatrice che diceva più o meno (vale il discorso del libro di prima): «Quando leggo le equazioni di Maxwell (http://it.wikipedia.org/wiki/Equazioni_di_Maxwell) mi commuovo». Per un profano però sono solo un mucchio di lettere, segni e triangolini. Roba incomprensibile perché linguaggio specifico.
Mi chiedo: che rapporto ha questo con la poesia? Ci sono profondità talmente vaste che ognuno porta dentro che sono esplorabili ed esprimibili solo tramite la poesia. Ma la fisica e le sue leggi possono essere un modo della poesia? Non so, dico questo perché vedo un’affinità: come la poesia da una parte è ciò che mi permette di fare ordine e dare una dimensione a ciò che vivo e che mi porto dentro, così l’espressione matematica delle leggi fisiche, in modo completamente diverso ma simile, permette la possibilità di contemplare la terrificante potenza di un universo in continuo cambiamento.
Il risultato che si ottebbe sarebbe contrario all’ingrandimento che Stas vede in Holst. Ci sarebbe un rimpicciolimento dell’essere umano di fronte ad un universo di vastità incalcolabile, ma contemplabile senza il terrore di perdercisi dentro.