Letture: “Favole del morire” di Giulio Mozzi.
- Del morire.
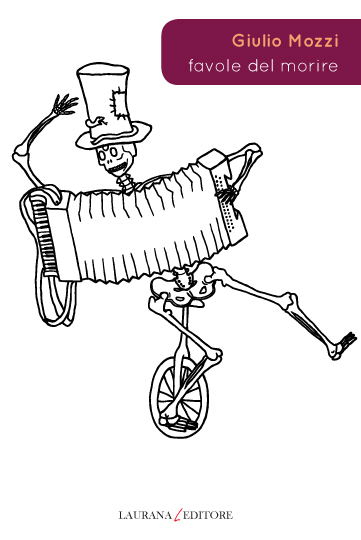
Con Favole del morire (Laurana, 2015), da poco più di un mese in libreria, Giulio Mozzi ci propone una riflessione articolata, vertiginosamente consequenziale ed apparentemente asettica sul morire. Non sulla morte, ma sul morire, sull’esserci e non esserci, sulla presenza o assenza di vita o, il che pare proprio lo stesso, sulla presenza o assenza di morte. La morte come metamorfosi, ma anche come durata, il trapasso come stadio intermedio tra due condizioni che a volte si fondono, come ci insegnano angoscianti declini di persone care, lenti di una lentezza che esaspera lo strazio della contemplazione impotente su alterazioni che sfigurano caratteri prima ancora che fattezze. La materia uncina poi ogni coscienza appena un po’ avvertita del proprio attraversare un tempo ed uno spazio limitati da una fine, di tutto o di questo tempo e di questo spazio. Per assioma, non ha limiti, e Mozzi la percorre cogliendo frammenti che possano tornare utili non come elementi di comprensione (siamo al cospetto dell’inconoscibile), né tantomeno di consolazione, ma come ausili alla consapevolezza. Questo libro ci pone di fronte al morire non per capire, non per trarne qualche forma di conforto, ma per ricordarci che c’è, che ci sarà immancabilmente: ci si confronta allora con qualcosa (“qualcosa”? ma la prosa di Mozzi nella sua precisione assoluta, pare lasciare intendere per contrasto quanto siano inadeguate le ordinarie convenzioni espressive per questo tema) che per alcuni “non è un traguardo alla fine di un percorso, ma un niente dove non c’è nemmeno il niente”, come chiosa Lorenzo Marchese nell’illuminante postfazione Una comparsa in frantumi. Lo stesso Marchese definisce Favole del morire come un libro di “difficile riconoscibilità” nella narrativa contemporanea: la difficoltà, per iniziare dalla superficie, sta allora anche nell’identificazione del genere. Si tratta di una raccolta di testi eterogenei, racconti, prose non narrative, un testo teatrale, alcune composizioni poetiche di diversa lunghezza, con i quali l’autore compone un prosimetro che è poi figura della inclassificabilità del tema, o, anche, e forse meglio, della sua necessaria appartenenza ad ogni possibile manifestazione espressiva dell’umano. Anche attraverso un utilizzo sapiente di questa ricchezza di forme espressive, Mozzi conferma la sua straordinaria maestria a cogliere nell’essenzialità di storie minime le possibilità di scandagliare il profondo dell’esistenza.
2. Leopardismi e altro.
Nonostante l’apparente disomogeneità dei testi raccolti, alcuni dei quali non inediti, ma leggermente riveduti per l’occasione, la coerenza dell’insieme è garantita dall’uniformità tematica. E’ quanto appare fin dal primo di essi, La stanza degli animali, a sua volta scandito su dieci parti, alcune in versi liberi, altre in prosa, in cui un figlio ricorda la collezione di animali che il padre biologo conservava in barattoli pieni di formalina, provenienti da spedizioni scientifiche in svariate parti del mondo, Somalia, golfo di Taranto, laguna veneta, delta del Danubio. Una moltitudine di animali morti, mantenuti nella forma esteriore che ne precedeva la morte, altrettanti simulacri dell’istante del trapassare, trattenuto il più a lungo possibile con ritrovati chimici, in un (auspicato) soffermarsi sul limitare dell’abisso o della trasformazione. Nella stanza degli animali si tenevano anche le biciclette di casa, e un giorno con un cavo da freno di bicicletta, il padre, in un accesso di follia, strangolò la madre. La scrittura volutamente disadorna di Mozzi produce qui squarci di devastante visionarietà, nei quali s’insinua il pensiero del morire, tout court, senza soluzioni e senza commenti: “… [gli animali marini] … muoiono e risorgono data l’impossibilità di morire. Vivono eternamente data l’impossibilità di fuggire. Apro gli occhi e sono di nuovo nella stanza, e la stanza è vuota…mia madre è morta uccisa da mio padre, mio padre è come morto dentro un carcere, io sono vivo data l’impossibilità di morire, tutto ciò che vive dentro la mia mente è morto, tutto ciò che è dentro la mia mente non può morire”. Uno sghembo parallelismo congiunge le vicende degli animali marini e quella di chi narra, accumunati dall’essere al limite del morire, ma anche dall’essere impossibilitati a farlo: sostano sulla soglia di una non vita, fisica ed apparente per gli animali, morale e psicologica per il figlio dell’assassino.
Un senso di sospensione emotiva evoca anche il discorso che rivolge ai suoi amici, compagni nelle danze, l’ ”uomo che credeva di essere morto, e invece era morto davvero, mentre contemplava l’immagine sua sorta nella sua mente morente”, che appare in Operetta di giugno, altro testo ibrido, mescolanza di prosa e di versi, che nasce dalla contemplazione del Ciclo dei Mesi di Torre Aquila, nel Castello del Buonconsiglio a Trento. Qui la soglia è attraversata, il distacco si sta attuando, e le parole non sono parole, perché nessuno le ascolta, ma pensieri lanciati a disperdersi in una cosmica solitudine: “se sapessi che il pensiero [della morte] è vero, forse non sarei morto. Se sapessi che il pensiero non è vero, certamente sarei non morto ma, come voi siete, moribondo.” Ed allora la danza dei gentiluomini e delle dame si propone come spietata allegoria della vita, che più la si gode più la si consuma: “Amici miei, come potete credere alla musica? Ogni passo della vostra danza è un passo che vi allontana dalla vostra origine e vi avvicina alla vostra fine. Voi credete di tornare sempre nello stesso luogo, completato il circolo; invece percorrendo circoli su circoli, come corpi catturati in un gorgo d’acqua, sprofondate verso il fondo del gorgo, dove la bestia finale vi attende, pazientissima.” Ma se la vita (e la morte) sono come questa danza primaverile, qualcosa dello stato primitivo forse pare restare: “nel mio ora ora capisco: la punizione dei morti, è contemplare la vita. La vita non si disfà del tutto …io vedo questo, non vedo il vostro disfarvi, io vedo la vostra vita trasformata in vita eterna, perché eterna è la mia esistenza in questo ora, ed eternamente l’immagine della vostra vita mi compare davanti agli occhi, se ho occhi, o nella mene, se ho mente, o nell’anima, se ho anima”. La sobrietà espressiva del testo qui si trasfigura in purezza assoluta, con esiti di straordinaria suggestione. Echi del Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie risuonano abbastanza evidenti sia in La stanza degli animali, sia in Operetta di giugno. Assenti l’appassionato interrogare ed anche gli affioramenti comico paradossali del Dialogo, nel primo si può individuare l’attenzione al morire, al consistere sul limitare, che assume i connotati di un impossibile sforzo per trattenere un istante transeunte (un trattenere, si badi bene, senza alcun sembiante nostalgico o sentimentale, del resto assente anche in Leopardi, quanto piuttosto di oggettiva presa d’atto di una condizione con cui per forza ci si deve confrontare). Nel secondo, del Dialogo ritorna il rovesciamento prospettico, comprese certe asimmetrie, tra morte e vita. Il Coro dei morti ha una certa persistenza tra le fonti di Mozzi. Alcuni suoi versi sono richiamati in Dieci motivi per essere cattolici, libro del 2011 scritto con Valter Binaghi, scomparso nel 2013 e al quale è dedicato Favole del morire. Una citazione inversa del luogo più noto del Coro “Sicura no, ma lieta/è la mia vita presente, / è la mia vita futura”, si legge inoltre nel poemetto Il culto dei morti nell’Italia contemporanea del 2000 (da Aldo Nove definito “uno dei più bei libri di poesia italiana del secondo dopoguerra”). E “Lieta no, ma sicura” sono le parole fuori campo che risuonano nel dialogo Emilio delle tigri se ne è andato, riusate in un ambito di “situazioni intermedie”, come scrive Marchese nella postfazione, cioè nel momento in cui Salgari sta per suicidarsi, e la voce con cui dialoga gli dimostra come molto (tutto?) di ciò in cui ancora spera, sull’orlo dell’ultimo passo, sia privo di vera significatività, compreso ciò che constata essere (posto che “essere “sia una categoria adatta alla circostanza) una volta passato dall’altra parte : “Emilio: “…Che succederà ora? – Voce; Niente. – Emilio: Come, niente? – Voce: Non succederà assolutamente niente. – Emilio: Ne è sicuro? – Voce: Per sempre.” Le suggestioni leopardiane, evidenziate (volutamente) per via di calchi espressivi ben riconoscibili, possono agire anche in via mediata: la fascinazione per i processi metamorfici può risalire non già direttamente all’archetipo leopardiano, ma modellarsi anche sugli sviluppi del leopardismo novecentesco, del quale pare spicchi qui come riferimento il Michelstaedter del Canto delle crisalidi. Sono comunque richiami disseminati su un humus culturale autonomo. Di Leopardi è ben presente soprattutto l’abito psicologico, il rifiuto delle illusioni, quello sguardo diretto e senza infingimenti sul destino umano quale ci è dato conoscere. Entro questi termini, piuttosto circoscritti, la lezione leopardiana si offre a Mozzi come uno dei contributi utili per una riflessione di straordinaria ampiezza ed intrisa in via del tutto prevalente degli apporti di un cattolicesimo che, se è autentico come è il suo, non può negarsi alla speranza. E in Favole del morire la speranza, concetto piuttosto ingombrante per testi che scopertamente respingono intenti consolatori, comparirà in ultimo, come paradosso estremo ma inevitabile.
3. Immaginazione e speranza.
Un diverso aspetto della sospensione tra morte e vita è definito in Novella con fantasma, il testo più scopertamente narrativo della raccolta, in cui si racconta di un vedovo a cui si presenta il fantasma della moglie, sotto le spoglie di un buffo ometto che si installa nel paese finché non viene ritrovata la salma della defunta, dispersa in un crepaccio ed irrecuperabile fino ad un miracoloso e precoce disgelo. Qui il momento risolutivo è rappresentato da un intenso momento di preghiera, descritto con apporti di particolari baroccheggianti. Per ottenere la grazia, Aurelio, il protagonista, prega per sessantacinque ore davanti alla Madonna dei Sette Dolori, assistito da quattordici pie donne (due per ogni dolore) “ciascuna più magra, più cattolica e più cattiva dell’altra”. E l’improvviso disgelo è tutto un fiorire di carni candide, esplosioni di fioriture su rami ancora nudi di foglie, frutta marcescente al mercato (allora anche la sospensione ha un termine, c’è quindi la possibilità di un dopo?).
Non c’è pacificazione, in queste Favole, ma ciò non significa che non sia presente un senso di dolente pietas verso ogni vivente, per il solo fatto di attraversare questa sua presente provvisoria condizione, e non piuttosto di permanervi. Spesso è quasi sottintesa e implicita nelle pieghe di una scrittura sistematicamente scabra e volte apparentemente ostile, o particolarmente esigente verso il lettore. Traspare più esplicita nella lirica collocata a chiusura dell’ultima delle Tre Invocazioni, un’Ave Maria sui generis in cui si canta l’amore terreno come abbandono temporaneo (ancora un senso di sospensione) alla dolcezza dell’esistere, un amore che perpetua la vita che introduce alla morte, o forse è già ad essa mescolata: “… tu che hai generato/ senza conoscere l’uomo/concedi a noi/di non conoscere/concedi a noi/ l’abbandono/ a ciò che siamo/e non comprendiamo/alla bellezza che ci sfiora/e ci abbandona/che ci sfiora/ e ci abbraccia…” L’invocazione sigilla una serie di monologhi che scavano dentro concezioni dimidiate dell’esistenza, preludenti alla sua fine o (il che non cambia poi molto) ad una mineralizzazione dei sentimenti (l’uomo estraneo a se stesso che non si riconosce più e dorme abbracciato a una pietra), in una sorta di tensione verso metamorfosi in cui si distinguano una fine (il custode dell’albero e della casa che voleva “essere l’albero e la casa”) o in cui si realizzi l’anelito ad altro che non sia la condizione attuale (l’assassino dell’uomo che ha usato violenza alla sua donna, la donna che la violenza l’ha subita, l’uomo violento ed ucciso: tutti e tre non potevano “fare altro”).
Per scrutare il morire soccorre l’immaginazione, unica forma di conoscenza possibile in mancanza di ogni altro elemento. E sull’immaginare si costruisce il testo più elaborato del libro, Favola del morire: “Del morire non sappiamo niente. Però ci immaginiamo. Vediamo gli altri morire. Moriremo, questo è certo. Da sempre ci immaginiamo. C’è chi dice che immaginare sia stupido. C’è chi dice: è la fine, stop. Io che cosa dico? Morirò, mi trasformerò.” Al morire Mozzi associa l’idea del divenire, di un universale ed incessante moto rotatorio, per cui vita e morte non sono in antitesi, se non nel destino individuale di ciascun vivente. Morte e vita sono inscindibilmente contenute una nell’altra, anche l’idea di un loro avvicendamento sfuma piuttosto nel concetto di continuità senza soluzione. “Se penso al mio vivere come a una cosa ferma, sono morto. Se penso al mio morire come a un movimento, sono vivo. Mi perderò, sarò salvo. Seppellirò i miei morti e sarò sepolto dai miei vivi. Se il seme non muore, non può far vivere. … Si può pensare che morire sia come venire al mondo? Si può pensare che quando si va all’altro mondo si lasci qui, in questo mondo ciò che serve a questo mondo perché tutti siano vivi per il tempo che a ciascuno tocca?”. Un’algida ricognizione biologica ci suggerisce l’estrema constatazione proponibile ai nostri sensi. Ciascun vivente con il proprio morire è sostentamento per la vita altrui: “diventerò fonte di vita per altri viventi, destinati come me alla morte. Quanti viventi ho mangiati, nella mia vita? Quante vacche, quanti maiali, quanti conigli, quante galline, quanti tonni, quanti pescispada, quante biete, quanti spinaci, quante insalate, quanti radicchi, quante cipolle, quanti finocchi, quante patate, quanti funghi? … Di quanti viventi io sono stato, vivente, la tomba? Non c’è nessuna colpa. Siamo nati per mangiare, siamo nati per mangiarci. Siamo aminoacidi volitivi “. Una visione paradossale e grottesca delle cose ultime domina la fantasia di Mozzi, che descrive la scissione (o forse il raddoppio) delle vite nel momento in cui precipitano (evolvono?) nella morte in altrettanti “colui” (il chi, l’anima, lo spirito?) e ”ciò” (il che cosa, il corpo, la fisicità?): l’azione misericordiosa di un Creatore li rimescolerà, esploderanno mille milioni di frammenti di vita, “ciascuno misteriosamente memore di tutta la storia passata, e avrà inizio il creato”.
L’orizzonte opaco, limitato dall’incomprensibilità del tutto per le nostre menti umane, si squarcia nel lampo improvviso che chiude Favola del morire: “Questa è la speranza: un’immaginazione”. Si tratta, nel contesto, della speranza di un nuovo creato, successivo a quello nel quale (chissà, forse a torto) riteniamo di vivere. Ma nell’affermazione c’è l’esito (precario, provvisorio eppure l’unico enunciabile se si vuole riconoscere coerenza con tutto quanto lo precede) della ricerca di senso che percorre il libro. Traspare qui, in estremo, esplicita una religiosità altrove sottintesa: se “fede è sustanza di cose sperate”, ma anche “argomento delle non parventi”, l’immaginazione sola può sottrarci alla meccanica implacabile dell’avvicendarsi senza sosta di esistere e non esistere, di morte e di vita, e consentirci una rappresentazione meno angusta del nostro destino.

molto interessante, grazie Luigi!