Sul filo della spada, al di là del taglio
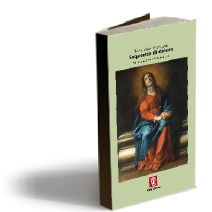 Dire addio a una persona amata che attraversa il filo della spada della morte, e che ormai sa che cosa c’è / oltre il suo taglio significa toccare i fili che legano in noi ossa, carne e anima rendendoci umani. La parola, della quale con sgomento Rosa Elisa Giangoia percepisce ora più che mai il limite espressivo, diventa esercizio di umanità, indagine di senso. La memoria non è pura membrana che risuona di nostalgia, ma occhio capace di guardare ancora al passato soltanto perché sa protendersi verso un orizzonte, che è limite e, insieme, pista di lancio.
Dire addio a una persona amata che attraversa il filo della spada della morte, e che ormai sa che cosa c’è / oltre il suo taglio significa toccare i fili che legano in noi ossa, carne e anima rendendoci umani. La parola, della quale con sgomento Rosa Elisa Giangoia percepisce ora più che mai il limite espressivo, diventa esercizio di umanità, indagine di senso. La memoria non è pura membrana che risuona di nostalgia, ma occhio capace di guardare ancora al passato soltanto perché sa protendersi verso un orizzonte, che è limite e, insieme, pista di lancio.
La poesia dunque fiorisce inaspettata, forse, come sintassi di una esperienza impossibile da condividere / per assenza di parole. Questo è il paradosso, infatti: Bisogna prendere dalla vita / le parole per dire la morte / che non ha parole, e che anzi soffoca quelle che timidamente si affacciano. La poesia di questa plaquette nasce da un paradosso, dunque, il quale però è in grado di intuire che la morte è un gesto ampio della vita. E come tale qui viene rivissuto.
I versi ci presentano un uomo, l’uomo amato, che si confronta con la morte, nemico duro di pietra che rende il corpo una sequenza particolare / programmata per l’estinzione. Il pensiero della morte si inserisce nella linea orizzontale della vita obbligandola a una riconsiderazione di se stessa. Nulla può essere come prima, quando si sa che i propri giorni volgono al termine, e occorre affrontare un apprendistato di confidenza / nel continuare ad essere vivo iniziando ad aspettare che si apra una porta, sperando sia di luce.
Questa forse la prima tappa di un abbandono e di una consegna non vissuta in solitudine ma sempre condivisa. E la poesia registra con delicatezza aspra una crescente comunione che si approfondisce quanto più si sente crescere quel muro di pietre a secco / tra me e te – scrive la Giangoia – quando i nostri giorni / si sono vestiti di reticenza, / attraverso le lacrime / atteggiate a sorriso scambievole. L’amore vive di questo ossimoro esistenziale: persino il muro di una lontananza invalicabile diventa strumento di congiunzione sulla soglia di un non detto che le apparenze sembrerebbero invece sciogliere nell’equivoco e nell’imbarazzo. E così il gioco di sguardi diventa la collezione di frammenti di un muto discorso amoroso: Guardare il tuo sguardo / per catturarlo con il mio / per trattenerlo, / vicendevolmente immobilizzati, / senza che nulla potesse distrarli, / né distinguerli l’uno dall’altro. Il discorso amoroso qui salta le distinzioni e l’empatia profonda non supplisce, ma porta a frutto la feconda assenza di parole. Le traiettorie degli sguardi sembrano unificarsi e puntare verso un luogo assente, che però non è utopia, ma speranza che regge la domanda se la morte sia fine o transito, se essa fa della vita / un cerchio o un arco.
E presto la nostalgia giunge a dare il suo gusto anche a un presente il cui godimento già sfugge: e noi sapevamo di perdere il sapore / dei lamponi del nostro giardino / irraggiungibile / mentre al sole che invecchiava / maturavano le melette asprigne / verso il freddo del loro rosso autunnale. Il mondo esterno sembra svanire mentre la stanza del dolore e dell’abbandono annunciato diventa essa stessa un mondo in cui si alternano parole di ghiaccio, di fredda consapevolezza, e parole di fuoco, di confidenza nella grazia.
…ma io volevo trattenere qualcosa / e non sapevo cosa di te, / perché l’illimitata trasparenza / tra il mio vivere e il tuo morire / non si offuscasse mai. Il gesto di trattenere qualcosa lancia le mani verso la morte per strapparle qualcosa, per mettere in salvo qualsiasi cosa in grado di mantenere una trasparenza radicale delle reciproche condizioni di esistenza… anche un’ora / un giorno, un tempo sconosciuto / per una supposta compiutezza… eppure il gesto resta teneramente, umanamente vano. Il mondo presente non è e mai può essere il tempo della compiutezza. I discorsi sono sempre lasciati a metà perché noi non ne conosciamo il senso ultimo. L’unico modo per vivere la compiutezza – se ne accorge in un lampo la Giangoia – è l’amore… e intanto t’amavo anche per i giorni / in cui non ci saresti più stato. Il dolore per la perdita imminente dà il suo suo primo frutto, valicando il muro della separazione con un salto che spinge l’amore talmente in avanti da superare anche la soglia ultima.
Pagina dopo pagina si dispiega il diario di un dolore vissuto con dignità sapiente, capace di avvertire il fuoco dell’assenza e sentire proprio in quello il segno di una presenza differente tutta da scoprire e ricercare pur nelle nubi di una conoscenza criptata da decifrare nel desiderio e nella speranza che si alimentano reciprocamente. Fino a quando, cogliendo il limite sul lato del visibile, / nella giusta distanza / della compassione e dell’immaginazione l’amato non si fa misteriosamente inconoscibile, fino a quando lui è ancora e per sempre «tu», ma nella forma dell’assenza.
L’accompagnamento si fa muto scambio di comprensione interiore: io ti guardavo / e tu vedevi che io ti guardavo / e io capivo che tu te ne rendevi conto / e io vedevo che tu capivi che io ti guardavo / e io volevo oltrepassare lo sguardo, / finché tu vedesti il ricapitolarsi / del tuo vivere nel suo perdersi / e poi nessuno dei due vide più nulla, / con gli occhi della vita, / più nessun riflesso dei riflessi. In questa manciata di versi densissimi che non lasciano al lettore la clemenza di una pausa, di un respiro, di una lacrima di commozione, accade tutto: mors et vita duello conflixere mirando. E questa lotta tra vita e morte si materializza in sguardi che sono carezze: la carezza va al di là del suo termine e cerca ciò che ancora sta come chiuso e sopito al di là dell’avvenire e della possibilità. Non è ricerca di dominio, di possesso: toccato dalla carezza dello sguardo l’uomo amato non perde la sua libertà di affrontare faccia a faccia il mistero che in lui si sta compiendo. Lo scambio di sguardi semmai è talmente serrato da far emergere con solennità un terreno di incontro. Il passaggio dalla vita alla morte qui si compie non solo con dolcezza e tenerezza, ma soprattutto con una intensità per cui il distacco diventa cecità. In quel momento è come se si facesse largo la consapevolezza che lo sguardo è solamente il riflesso dello sguardo dell’altro: se questo cede, l’altro si spegne. E resta il buio. Allora, in quel momento e da quel momento, il mondo sì resta uguale (i mobili e i quadri erano al loro posto, / il sole entrava dalla finestra, / il mare azzurro brillava sullo sfondo / e una grande nave bianca lo solcava)… eppure tutto cambia. Il mondo diventa un palcoscenico mezzo smontato che a chi resta lascia il senso di un vuoto ascendente, di una solitudine che rende ogni tocco privo di intimità reale: vivo la solitudine collettiva / dei fili d’erba sul prato.
Ed ecco il salto, però, giungere guizzante dalle ceneri di uno sguardo spento e dalle macerie di un mondo andato in pezzi. La consapevolezza si approfondisce e la solitudine diventa luogo di meditazione capace di sollevare la pietra tombale: il limite tra la vita e la morte non è barriera, muro scalcinato su cui si proiettano le nostre ombre. Il limite, quando a spingersi oltre il limite è l’amato, viene riscoperto e intuito come frontiera che mentre separa congiunge ma in modo diverso: Non è la morte che separa davvero / se almeno tu ora / vedi nel mio cuore. Il filo immateriale diventa la testimonianza di un percorso – la vita stessa – in cui io semino ovunque il mio amore / perché ovunque tu possa trovarlo. E si comprende adesso come l’incompletezza sia terribile e dolce cifra vera dell’amore in questa terra che lancia nel futuro, al di là della frontiera, il compimento della dolcezza: consola sentire che le parole più belle / ancora ce le dobbiamo dire. E si apre quindi la lotta con l’immaginazione per pensare l’amato in un dove e in un come: è la buona battaglia della fede – che si combatte sapendo di aver già perso – con le proprie facoltà. Ma è bene che questa battaglia venga combattuta per comprendere quale sia l’unico modo per vincerla: la resa.
Ma anche la resa non basta, perché una volta avvenuta, resta il travaglio del timore di non riconoscerti / quando ti ritroverò / nel giorno della risurrezione / che io credo sicura. E la lotta ricomincia, e ricomincia l’amore che è in se stesso ricerca e riconoscimento dell’amato, come il Cantico dei Cantici ci dichiara. E quindi resta soltanto un’ultima parola, la vera, l’unica che dà pace all’animo in lotta: la mia riconoscenza infinita / per essere stato per me.

questo di Rosa è un libro speciale.
L’ho letto con godimento e sofferenza, con profonda commozione.
Ne scriverò, su questo blog o altrove su qualche giornale ma ne voglio scrivere, ne voglio parlare; è un libro importante, incandescente. La bella prefazione di Antonio coglie i nodi essenziali del testo e per certi versi va anche oltre, come è giusto che un critico faccia. Mi cimenterò pure io con questa prova, appena il calore che mi ha trasmesso si sia sedimentato, decantandosi… o forse no.
L’unico paragone che mi viene è con «Diario di un dolore» di Lewis, condensato nella plastica incisività dei versi. C’è una tale verità, in queste pagine, ed è una verità così vulnerabile! Da lasciare senza fiato. Mi sono dovuto fermare più volte, leggendoli, rileggendoli, rivivendo alcuni lutti recenti, rivedendo il volto di chi saluta per l’ultima volta la persona a cui ha promesso «finché morte non ci separi». E’ un’immersione senza sconti in questo realismo assoluto dell’amore, mai nascosto neppure nella celebrazione stessa dell’unione. Giunti a questo punto non ci sono altre vere strade (se non di alienazione). Bisogna imboccare questo sentiero: «Per essere consolati / bisogna essere addolorati».
Grazie Rosa. Grazie, Mino.
anch’io ovviamente ho pensato a Diario di un dolore di Lewis e noto la differenza tra la prosa e la poesia, tra un “diario” e una “sequenza”, parola che mi trasmette una sensazione quasi “liturgica” di questo testo orale ma al tempo stesso di una interiorità-intimità assoluta. Immersione senza sconti, ha ragione Paolo. E mi unisco a lui nel dire: grazie Rosa, grazie Mino.
Dico anch’io grazie a Rosa, e grazie a voi, amici, che ne avete scritto. Ho ricevuto il libro dalla stessa autrice e l’ho letto d’un fiato, e poi riletto piano piano, perche’ il dolore e’ come una lama che bisogna far entrare lentamente nella carne, altrimenti ci dissangua. Ho vissuto e rivissuto attraverso le sue pagine esperienze “sorelle” a quel dolore di Rosa, e ho percepito tutta la bellezza della sua poesia, che parla di cose universali e percio’ arriva dritta al cuore.
Giovedì 18 marzo 2010 iniziera’ una conversazione su Flannery.it dedicata proprio al libro di versi “Sequenza di dolore” che sara’ cosi’ presentato ai nostri amici-amiche di Flannery. Sono ansiosa di sentire cosa pensano di queste liriche, sono certa infatti che lasceranno un segno… e allora vi do’ appuntamento a tutti, se lo volete, su Flannery.it.
Grazie, Antonio, per la tua splendida prefazione al libro :-)
Un caro saluto.
Maria