E un piffero suonava in me topi e topi che non erano precisamente ricordi. Non erano che topi, scuri, informi, trecentosessantacinque e trecentosessantacinque, topi scuri dei miei anni, ma solo dei miei anni in Sicilia, nelle montagne e li sentivo smuovere in me, topi e topi fino a quindici volte trecentosessantacinque, e il piffero suonava in me, e così mi venne una scura nostalgia come di ricevere in me la mia infanzia.
Elio Vittorini, Conversazione in Sicilia
 E ora aspettiamo che u tratturi faccia la stessa fine di Saddam, riscagliato a terra, da icona mitica tornerà un piccolo uomo di neanche un metro e settanta, un uomo che ha governato l’isola triangolare e i destini ad essa legati per quarant’anni.
E ora aspettiamo che u tratturi faccia la stessa fine di Saddam, riscagliato a terra, da icona mitica tornerà un piccolo uomo di neanche un metro e settanta, un uomo che ha governato l’isola triangolare e i destini ad essa legati per quarant’anni.
La Sicilia, i siciliani si sono sentiti abbandonati. Da sempre, dallo Stato, dai vari politici che hanno fatto incetta di voti e ci hanno lasciato soli. Sempre di più. Compriamo l’acqua per cucinare pure un tegamino di pasta. Ci mancano i servizi minimi. E il lavoro è un’utopia. E ora la precarietà a cui hanno consegnato il nostro futuro farà il resto. Il “posto” diventerà il nostro sogno proibito. Andremo avanti, per inerzia. E la cultura? Che farà la cultura scacciasofferenze?
Che possa fare davvero qualcosa non lo credo più dal ‘92. Sono tredici anni che ho perso ogni speranza. Perché non si può far saltare un’intera autostrada per cancellare chi voleva fare davvero qualcosa. Solo perché Falcone l’amava irrimediabilmente questa terra. Hanno fatto esplodere un pezzo di autostrada, il Giudice tornava in volo da Roma, mette piede a terra, decide di guidare e si vede la strada sparire, l’asfalto polverizzato. Una catastrofe che presto hanno avvolto nelle lenzuola. Le loro idee cammineranno sulle nostre gambe, l’abbiamo gridato. L’abbiamo scritto sulle lenzuola. Le lenzuola. Sempre le lenzuola. Che prima stendevamo per far vedere che la nostra sposa era arrivata illibata. Sangue di verginità perdute, speranze perdute. Sempre sulle lenzuola. Che sbiancate dal sole assomigliano a vecchi sudari. Sindoni di civiltà perdute. Lenzuola e lì, dove il Giudice perse la sua battaglia, hanno messo un doppio obelisco. Una minchia di pietra che si incula il cielo.
Intendiamoci, Che la cultura possa fare qualcosa ne sono certo, ma si tratta di vedere che tipo di cultura, sia essa anche quella anti-mafiosa che striscia subdola arricchendosi di arrocchi stilistici che a poco o nulla servono, forse solo a sollazzare la semiotica, tipo Cuffaro che dice: “La mafia fa schifo” su cartelloni tre metri per sei.
Rileggo spesso gli articoli di Pippo Fava:
“Voglio fare un discorso corretto e sereno sui siciliani, premettendo naturalmente che io sono perfettamente siciliano. Un discorso sulla stupidità dei siciliani. Noi affermiamo spesso di essere straordinariamente intelligenti, quanto meno di avere più fantasia e piacere di vivere, rispetto a qualsiasi altro popolo della terra. Non è vero! La storia è là a dimostrarlo. Da migliaia di anni siamo semplicemente terra di conquista, gli altri arrivano, saccheggiano, stuprano, costruiscono qualche monumento, ci insegnano qualcosa, e se ne vanno. Noi ci appropriamo di una parte di quella civiltà, a volte diventiamo anche i custodi del tempio, in attesa che arrivi un’altra ondata saccheggiatrice. Siamo quasi sempre colonia per incapacità di essere veramente popolo. Presi i siciliani ad uno ad uno, può anche accadere che taluno riesca ad esprimere (nella poesia, nel delitto, nella finanza, nell’arte) attimi di ineguagliabile talento. Sono quelli che ci fottono, che ci danno l’impressione, spesso la certezza, di essere i migliori. Nella realtà, presi tutti insieme, siamo quasi sempre un popolo imbecille.”
Questo lo scriveva nel 1983, ventitré anni dopo siamo qui, a gridare davanti alle telecamere “Bastardo, bastardo!” per poi accettare in complice silenzio una vita che nasce già segnata.
Ti striscia addosso, nel mercimonio elettorale che continua anche fuori dal seggio, nel do ut des, nel rispetto solo per i vincitori. Ci riempiamo la bocca con l’isola che diventa sovente metafora del mondo, metafora che ingloba e fa seccare ogni discorso critico serio.
Nel 1992 le cose, anche se per poco, cambiarono, quelli che per secoli erano stati semplicemente gli “sbirri” divennero “a polizia”, poi però la pace del papavero calò di nuovo e i ragazzi che andavano in motorino senza casco rifecero il vecchio gesto dell’indice e del medio verso il naso, gridando unanimi: “gli sbirri!”. Basta guardare il documentario “la mafia è bianca” per capire qual era la percezione di Provenzano tra le strade. Tutti quelli intervistati, che vedo ogni giorno venire qui, al terzo settore del Comune di Bagheria, dicevano che U Zu Binnu era un benefattore, un uomo giusto.
Riecheggia quella che fu la polemica all’uscita del primo capitolo della trilogia del Padrino, si scrisse un Nilo di articoli contro la moralità del vecchio Vito Corleone.
La risposta è sempre quella: tutto è melodramma in Sicilia. Anche la cattura del “re della mafia”.
La percezione del fenomeno mafioso è qualcosa d’innato, come diceva qualcuno per il linguaggio. La mafia non è quella che spara, è un evento che t’accompagna giorno dopo giorno, in ogni frangente.
E’ la banconota da inserire nel certificato per accelerare i tempi burocratici (una storia bellissima della Disney rendeva pienamente lo spirito: Paperino Portaborse di Giorgio Pezzin e Guido Scala,Topolino 1690), è l’acqua che non arriva mai, sono i treni che sembrano davvero carri bestiame, è il poliziotto che lascia passare il delinquente che guida senza casco, senza assicurazione, senza targa e, senza nessuna dignità, il milite fa la multa al figlio di nessuno che ha solo una lampadina fulminata.
E’ il senso di impotenza, la stasi suprema. Le targhe alla memoria non fanno ricordare nulla, i fiori che poggiano nei luoghi della guerra di mafia anno dopo anno li lasciano marcire al sole. Questo senso d’abbandono è ancestrale, ad esso dovrebbero rivolgersi i futuri governi. Al problema della terra, egregiamente sintetizzato nelle “maledette arance” di vittoriniana memoria. I giovani gridano sin quando possono che non si ridurranno mai come loro, quelli che li hanno preceduti. Gridano, poi l’urlo si smorza e quando qualcuno gli ventila la possibilità di un seppure precario impiego dimenticano gli ideali, arrotolano le bandiere e con l’etichettatrice Dymo tracciano il segno tra le utopie del passato e la Necessità, la vera dea della Sicilia che ci spinge ai più ignobili compromessi.
Amici miei che gridavano più forte degli altri hanno scelto il bavaglio per un posto alla Regione o alle Poste, anche se solo per sei mesi.
(questo pezzo è nato su Vibrisse, ringrazio i lettori intervenuti)
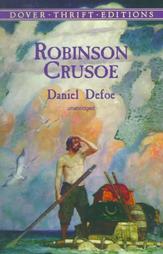 In un dibattito di qualche tempo fa, Antonio Spadaro parlava di uno sguardo fresco che ci “restituisca la realtà così com’è”, un po’ come quello di Robinson Crusoe che enumera le cose sfuggite al naufragio, e il solo nominarle le rende nuove e preziose; Leonardo Colombati reclamava invece il recupero della libertà totale del linguaggio che, senza relegare la letteratura in un mondo altro dalla vita, sia garante della “buona riuscita” di quello spettacolo che è la letteratura.
In un dibattito di qualche tempo fa, Antonio Spadaro parlava di uno sguardo fresco che ci “restituisca la realtà così com’è”, un po’ come quello di Robinson Crusoe che enumera le cose sfuggite al naufragio, e il solo nominarle le rende nuove e preziose; Leonardo Colombati reclamava invece il recupero della libertà totale del linguaggio che, senza relegare la letteratura in un mondo altro dalla vita, sia garante della “buona riuscita” di quello spettacolo che è la letteratura.
 E ora aspettiamo che u tratturi faccia la stessa fine di Saddam,
E ora aspettiamo che u tratturi faccia la stessa fine di Saddam,  Il 6 aprile 2006 l’Associazione culturale “Pietre di Scarto” ha avuto il piacere di ospitare a Reggio Calabria, nella sala conferenze del Museo Nazionale della Magna Grecia, il poeta di origine sarda, ma genovese di adozione, Bruno ROMBI, autore di un oratorio dal titolo Tsunami, pubblicato dalla casa editrice Nemapress. Questa iniziativa s’inserisce nell’ambito di un’attività ben più ampia dell’Associazione, che ha nei Convegni Nazionali sulla Letteratura, organizzati con cadenza annuale, momenti di grande valenza culturale e nei laboratori di lettura, scritture creative, autobiografia, dizione, il suo campo ordinario di impegno in città. La serata dedicata al poeta Bruno Rombi è stata presentata dalla Prof.ssa Francesca Crucitti, socio fondatore ed esponente del direttivo dell’Associazione.
Il 6 aprile 2006 l’Associazione culturale “Pietre di Scarto” ha avuto il piacere di ospitare a Reggio Calabria, nella sala conferenze del Museo Nazionale della Magna Grecia, il poeta di origine sarda, ma genovese di adozione, Bruno ROMBI, autore di un oratorio dal titolo Tsunami, pubblicato dalla casa editrice Nemapress. Questa iniziativa s’inserisce nell’ambito di un’attività ben più ampia dell’Associazione, che ha nei Convegni Nazionali sulla Letteratura, organizzati con cadenza annuale, momenti di grande valenza culturale e nei laboratori di lettura, scritture creative, autobiografia, dizione, il suo campo ordinario di impegno in città. La serata dedicata al poeta Bruno Rombi è stata presentata dalla Prof.ssa Francesca Crucitti, socio fondatore ed esponente del direttivo dell’Associazione. Ci sono incontri nella vita che sono delle vere e proprie esperienze. Non sempre l’incontro con una persona è un’esperienza: affinché ci sia esperienza, è necessario che ci sia mistero. Se una persona, in qualche modo, non è un mistero per te che la conosci, allora quell’incontro non è un mistero. È un incontro come tanti, si conoscono tante persone. Paolo Amodeo (1978-2004) è un mistero e continua ad essere un mistero. C’è sempre qualcosa che sfugge a contatto con le sue poesie. E anche osservando i quadri ed ascoltando la sua musica, c’è un mistero che rimane tale.
Ci sono incontri nella vita che sono delle vere e proprie esperienze. Non sempre l’incontro con una persona è un’esperienza: affinché ci sia esperienza, è necessario che ci sia mistero. Se una persona, in qualche modo, non è un mistero per te che la conosci, allora quell’incontro non è un mistero. È un incontro come tanti, si conoscono tante persone. Paolo Amodeo (1978-2004) è un mistero e continua ad essere un mistero. C’è sempre qualcosa che sfugge a contatto con le sue poesie. E anche osservando i quadri ed ascoltando la sua musica, c’è un mistero che rimane tale. La scienza degli addii di Elisabetta Rasy è senz’altro un romanzo importante, che testimonia il fatto che non esistano solo le “liale” nel panorama della nostra attuale produzione narrativa. Racconta vicende drammatiche con occhio sapiente che sa guardare nel profondo dell’esperienza del vivere, nello stesso tempo il racconto è condotto con ariosa leggerezza espressiva. L’intento dell’autrice è quello di far rivivere la vicenda umana e storica del poeta russo Osip Mandel’stam attraverso parole che vibrano di tutta la simpatia e la consonanza intellettuale che la narratrice ha nei suoi confronti. La vita di Osip e di sua moglie Nadezda Chazina, pur nella sua tragica drammaticità umana, è ricostruita attraverso la luce che nasce dalla fiducia nella vita e nell’arte. Davanti ai nostri occhi scorrono l’incontrarsi e il perdersi dei due giovani innamorati nella Russia sconvolta dalla rivoluzione e dalla guerra civile, la bizzarria e l’anticonformismo di lui, tutto dedito alla sua creatività, l’apparente fragilità di lei, che sa essere forte quando le vicende e le circostanze lo richiedono, fino a che lui morirà in un gulag siberiano e lei, per diversi decenni, continuerà con amore ad esserne la memoria vivente, pur sempre tra difficoltà e diffidenze.
La scienza degli addii di Elisabetta Rasy è senz’altro un romanzo importante, che testimonia il fatto che non esistano solo le “liale” nel panorama della nostra attuale produzione narrativa. Racconta vicende drammatiche con occhio sapiente che sa guardare nel profondo dell’esperienza del vivere, nello stesso tempo il racconto è condotto con ariosa leggerezza espressiva. L’intento dell’autrice è quello di far rivivere la vicenda umana e storica del poeta russo Osip Mandel’stam attraverso parole che vibrano di tutta la simpatia e la consonanza intellettuale che la narratrice ha nei suoi confronti. La vita di Osip e di sua moglie Nadezda Chazina, pur nella sua tragica drammaticità umana, è ricostruita attraverso la luce che nasce dalla fiducia nella vita e nell’arte. Davanti ai nostri occhi scorrono l’incontrarsi e il perdersi dei due giovani innamorati nella Russia sconvolta dalla rivoluzione e dalla guerra civile, la bizzarria e l’anticonformismo di lui, tutto dedito alla sua creatività, l’apparente fragilità di lei, che sa essere forte quando le vicende e le circostanze lo richiedono, fino a che lui morirà in un gulag siberiano e lei, per diversi decenni, continuerà con amore ad esserne la memoria vivente, pur sempre tra difficoltà e diffidenze.