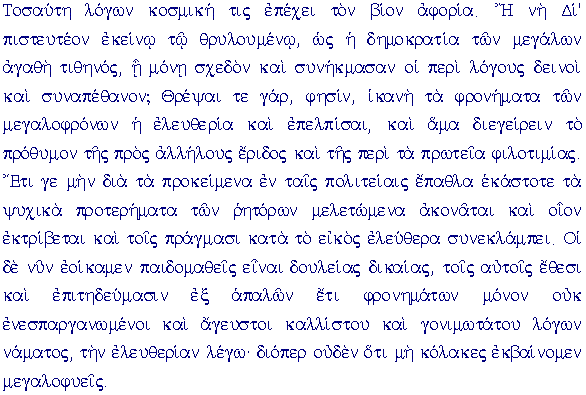 Sul sublime (Perì ùpsous) è il titolo di un opuscolo redatto in forma epistolare, di cui non è stato ancora possibile accertare l’autore, ma che vari elementi inducono gli studiosi a datare al I sec. d.C., forse intorno al 40. Conservatoci in forma lacunosa da 11 manoscritti, il più antico dei quali, il Parisinus 2036, a cui sembrano risalire direttamente o indirettamente tutti gli altri, è del secolo X, fu fatto conoscere da Francesco Robortelli, che lo pubblicò a Basilea nel 1554. Da allora gli studiosi si impegnarono soprattutto nell’identificazione dell’autore e nella ricostruzione filologica del testo, ma il suo importante contenuto ebbe un ruolo di rilievo nella cultura francese del XVII secolo, in quanto fu tradotto da Nicolas Boileau nel 1674. Successivamente influenzò notevolmente il pensiero tedesco, soprattutto per quanto riguarda la formulazione delle teorie estetiche di Lessin, di Burke e di Kant, mentre in Inghilterra lasciò tracce significative nella riflessione di Dryden, Swift e Pope. Durante il Romanticismo diminuì l’interesse nei suoi confronti, mentre trovò nuova fortuna nel Novecento, in Italia, soprattutto per merito di Benedetto Croce. Anche se questo testo nel corso dei secoli dell’età moderna è stato letto come un’opera di critica letteraria o come un trattato di estetica, esso sviluppa in realtà una sola idea, quella del “sublime”: con questo termine si indica il momento della perfetta sintesi tra forma e contenuto, che si ha quando, raggiunta la massima tensione espressiva, l’autore riesce a provocare nei suoi destinatari un intenso coinvolgimento emotivo, al quale la razionalità è completamente estranea. Cerchiamo di ripercorrere sommariamente il ragionamento dell’Anonimo autore, il quale, rivolgendosi ad un amico romano avviato alla carriera forense e politica, Postumio Floro Terenziano, si propone di insegnare come il sublime si possa conseguire. Il termine greco ùpsos letteralmente significa “altezza”, per cui viene reso in latino con sublimitas e sublime e, a giudizio dell’Autoew, è “il culmine e l’àpice dell’arte della parola” ed è l’elemento specifico e caratteristico grazie al quale i grandi poeti e prosatori conseguirono la gloria (cap. I). Questa eccellenza però non è il risultato di ricerche e di impegno puramente formali, ma deriva da nobiltà di concezione, da fervore di vita a livello fantastico e sentimentale, in definitiva da una ricchezza spirituale sovrabbondante che si riesce a trasferire compiutamente nella pagina scritta. A questo punto nascono degli interrogativi molto interessanti anche per noi oggi. Infatti l’Autore si chiede come si potrà insegnare un’arte che si basa soprattutto su condizioni spirituali, in particolare sulla grandezza d’animo, che, essendo come pensano molti, dote innata, non può essere acquisita. A queste possibili obiezioni l’Anonimo risponde che, pur essendo vero che le doti naturali sono condizione di base per ogni creazione artistica, esse devono essere opportunamente guidate e disciplinate: l’ispirazione disordinata e non opportunamente incanalata verso la correttezza espositiva non porta all’eccellenza, in quanto l’estro ha bisogno di essere sottoposto al metodo per essere temperato, ma anche spronato, senza contare poi che solo lo studio è in grado di rivelare la presenza di talune disposizioni naturali (cap. II). Senza quello che poi Dante chiamerà il fren de l’arte (Purg. XXXIII, 141) anche chi è naturalmente dotato può incorrere in taluni difetti: dal sublime può facilmente trapassare nell’enfasi, cadere nella futilità oppure lasciarsi trascinare ad una concitazione inopportuna, abusando di quelle disposizioni che, se invece ben disciplinate, possono far raggiungere livelli di eccellenza (capp. III e IV). Successivamente l’Autore, pur riconoscendo che solo grazie ad ampie e ben scelte letture, si affina il gusto letterario, si impegna per individuare un criterio che distingua il sublime reale da quello che potrebbe apparire tale ad una considerazione superficiale. A suo giudizio, il sublime consiste nel potere che hanno le opere veramente eccellenti di disporre l’animo alla grandezza, di suscitare intensi sentimenti e promuovere considerazioni elevate, inoltre nel far sì che perduri l’impressione da esse prodotta e che si rinnovi nel ripetersi degli incontri con il testo, infine anche nel concorde consenso del giudizio in persone diverse per condizioni di vita, consuetudini e cultura (capp. V – VII). A questo punto l’Anonimo cerca di individuare e fissare le fonti essenziali del sublime. Ne individua cinque, che espone in ordine d’importanza: le prime due sono l’elevatezza di pensiero e l’intensità di sentimento (pàthos), mentre le altre tre sono l’uso di figure retoriche (di pensiero e di parola), la nobiltà di elocuzione, cioè lo stile che comprende la scelta dei vocaboli e l’elaborazione dell’espressione con l’uso dei traslati, e infine la configurazione dignitosa e solenne del periodo. Naturalmente le prime due si rapportano alla sfera delle doti innate, mentre le ultime tre si conseguono e affinano con lo studio. Le prime due sono essenziali, secondo l’Anonimo, per il quale l’arte non è artificio di parola o di frase e che afferma che “il sublime è l’eco della grandezza d’animo” (cap.IX, 2). Egli afferma con convinzione profonda che solo chi ha animo nobile e si dedica a pensieri elevati può esprimere qualcosa di eccellente e pone di conseguenza l’accento sulla nobiltà d’animo e sulla dignità morale dell’artista. La disposizione alla grandezza d’animo, sebbene sia considerata dall’Autore una dote naturale, può, a suo giudizio, essere stimolata e coltivata, non con esercizi formali, ma con la frequentazione di pensieri elevati, tramite la compartecipazione dello scrittore a quanto esprime (a questo proposito cita Omero che “suole condividere con i suoi eroi la grandezza epica”) e mediante lo sforzo di elevarsi verso la grandezza come “il legislatore degli Ebrei”, che dovette comprendere “tutta la maestà di Dio” per esprimerla come fece al principio delle Leggi” (cap. IX). Dopo aver fissato il presupposto fondamentale della grandezza d’animo come dote naturale indispensabile per riuscire a dire cose sublimi, l’Autore approfondisce la sua indagine, cercando di individuare quali possano essere gli aiuti per raggiungere il sublime e ne individua quattro: la concentrazione delle idee più elevate riguardanti il soggetto da trattare, l’amplificazione, l’imitazione e la fantasia. Dapprima, sottolineando che in ogni argomento vi sono particolarità caratteristiche, consiglia di scegliere le più rilevanti e di comporle insieme, trascurando le altre, secondo un procedimento di concentrazione delle idee più elevate (cap. X). Molto utile è, a suo giudizio, il procedimento dell’amplificazione, che consiste nell’introdurre via via concetti sempre più elevati: questo susseguirsi incalzante di concetti elevati può pervenire alla cosiddetta “prova”, che consiste nel portare il lettore o l’ascoltatore alla persuasione mediante un itinerario razionale che si realizza tramite un susseguirsi di elementi probativi. Gli altri due procedimenti sono di carattere tipicamente intimo e spirituale: l’imitazione e la fantasia. Potremmo avere qualche riserva sull’imitazione, che però l’Anonimo considera essenziale strumento didattico, finalizzato a promuovere la ricchezza della vita interiore. Per lui, attraverso questa via, si attua l’educazione alla grandezza, per raggiungere la quale è fondamentale la lettura dei grandi poeti, che sanno nutrire lo spirito e lo rendono idoneo a produrre l’ispirazione suscitando stati d’animo e atteggiamenti simili a quelli da cui le grandi opere sono nate. Per l’Anonimo l’imitazione non è quindi pedissequa riproduzione a livello formale, ma è acquis
Sul sublime (Perì ùpsous) è il titolo di un opuscolo redatto in forma epistolare, di cui non è stato ancora possibile accertare l’autore, ma che vari elementi inducono gli studiosi a datare al I sec. d.C., forse intorno al 40. Conservatoci in forma lacunosa da 11 manoscritti, il più antico dei quali, il Parisinus 2036, a cui sembrano risalire direttamente o indirettamente tutti gli altri, è del secolo X, fu fatto conoscere da Francesco Robortelli, che lo pubblicò a Basilea nel 1554. Da allora gli studiosi si impegnarono soprattutto nell’identificazione dell’autore e nella ricostruzione filologica del testo, ma il suo importante contenuto ebbe un ruolo di rilievo nella cultura francese del XVII secolo, in quanto fu tradotto da Nicolas Boileau nel 1674. Successivamente influenzò notevolmente il pensiero tedesco, soprattutto per quanto riguarda la formulazione delle teorie estetiche di Lessin, di Burke e di Kant, mentre in Inghilterra lasciò tracce significative nella riflessione di Dryden, Swift e Pope. Durante il Romanticismo diminuì l’interesse nei suoi confronti, mentre trovò nuova fortuna nel Novecento, in Italia, soprattutto per merito di Benedetto Croce. Anche se questo testo nel corso dei secoli dell’età moderna è stato letto come un’opera di critica letteraria o come un trattato di estetica, esso sviluppa in realtà una sola idea, quella del “sublime”: con questo termine si indica il momento della perfetta sintesi tra forma e contenuto, che si ha quando, raggiunta la massima tensione espressiva, l’autore riesce a provocare nei suoi destinatari un intenso coinvolgimento emotivo, al quale la razionalità è completamente estranea. Cerchiamo di ripercorrere sommariamente il ragionamento dell’Anonimo autore, il quale, rivolgendosi ad un amico romano avviato alla carriera forense e politica, Postumio Floro Terenziano, si propone di insegnare come il sublime si possa conseguire. Il termine greco ùpsos letteralmente significa “altezza”, per cui viene reso in latino con sublimitas e sublime e, a giudizio dell’Autoew, è “il culmine e l’àpice dell’arte della parola” ed è l’elemento specifico e caratteristico grazie al quale i grandi poeti e prosatori conseguirono la gloria (cap. I). Questa eccellenza però non è il risultato di ricerche e di impegno puramente formali, ma deriva da nobiltà di concezione, da fervore di vita a livello fantastico e sentimentale, in definitiva da una ricchezza spirituale sovrabbondante che si riesce a trasferire compiutamente nella pagina scritta. A questo punto nascono degli interrogativi molto interessanti anche per noi oggi. Infatti l’Autore si chiede come si potrà insegnare un’arte che si basa soprattutto su condizioni spirituali, in particolare sulla grandezza d’animo, che, essendo come pensano molti, dote innata, non può essere acquisita. A queste possibili obiezioni l’Anonimo risponde che, pur essendo vero che le doti naturali sono condizione di base per ogni creazione artistica, esse devono essere opportunamente guidate e disciplinate: l’ispirazione disordinata e non opportunamente incanalata verso la correttezza espositiva non porta all’eccellenza, in quanto l’estro ha bisogno di essere sottoposto al metodo per essere temperato, ma anche spronato, senza contare poi che solo lo studio è in grado di rivelare la presenza di talune disposizioni naturali (cap. II). Senza quello che poi Dante chiamerà il fren de l’arte (Purg. XXXIII, 141) anche chi è naturalmente dotato può incorrere in taluni difetti: dal sublime può facilmente trapassare nell’enfasi, cadere nella futilità oppure lasciarsi trascinare ad una concitazione inopportuna, abusando di quelle disposizioni che, se invece ben disciplinate, possono far raggiungere livelli di eccellenza (capp. III e IV). Successivamente l’Autore, pur riconoscendo che solo grazie ad ampie e ben scelte letture, si affina il gusto letterario, si impegna per individuare un criterio che distingua il sublime reale da quello che potrebbe apparire tale ad una considerazione superficiale. A suo giudizio, il sublime consiste nel potere che hanno le opere veramente eccellenti di disporre l’animo alla grandezza, di suscitare intensi sentimenti e promuovere considerazioni elevate, inoltre nel far sì che perduri l’impressione da esse prodotta e che si rinnovi nel ripetersi degli incontri con il testo, infine anche nel concorde consenso del giudizio in persone diverse per condizioni di vita, consuetudini e cultura (capp. V – VII). A questo punto l’Anonimo cerca di individuare e fissare le fonti essenziali del sublime. Ne individua cinque, che espone in ordine d’importanza: le prime due sono l’elevatezza di pensiero e l’intensità di sentimento (pàthos), mentre le altre tre sono l’uso di figure retoriche (di pensiero e di parola), la nobiltà di elocuzione, cioè lo stile che comprende la scelta dei vocaboli e l’elaborazione dell’espressione con l’uso dei traslati, e infine la configurazione dignitosa e solenne del periodo. Naturalmente le prime due si rapportano alla sfera delle doti innate, mentre le ultime tre si conseguono e affinano con lo studio. Le prime due sono essenziali, secondo l’Anonimo, per il quale l’arte non è artificio di parola o di frase e che afferma che “il sublime è l’eco della grandezza d’animo” (cap.IX, 2). Egli afferma con convinzione profonda che solo chi ha animo nobile e si dedica a pensieri elevati può esprimere qualcosa di eccellente e pone di conseguenza l’accento sulla nobiltà d’animo e sulla dignità morale dell’artista. La disposizione alla grandezza d’animo, sebbene sia considerata dall’Autore una dote naturale, può, a suo giudizio, essere stimolata e coltivata, non con esercizi formali, ma con la frequentazione di pensieri elevati, tramite la compartecipazione dello scrittore a quanto esprime (a questo proposito cita Omero che “suole condividere con i suoi eroi la grandezza epica”) e mediante lo sforzo di elevarsi verso la grandezza come “il legislatore degli Ebrei”, che dovette comprendere “tutta la maestà di Dio” per esprimerla come fece al principio delle Leggi” (cap. IX). Dopo aver fissato il presupposto fondamentale della grandezza d’animo come dote naturale indispensabile per riuscire a dire cose sublimi, l’Autore approfondisce la sua indagine, cercando di individuare quali possano essere gli aiuti per raggiungere il sublime e ne individua quattro: la concentrazione delle idee più elevate riguardanti il soggetto da trattare, l’amplificazione, l’imitazione e la fantasia. Dapprima, sottolineando che in ogni argomento vi sono particolarità caratteristiche, consiglia di scegliere le più rilevanti e di comporle insieme, trascurando le altre, secondo un procedimento di concentrazione delle idee più elevate (cap. X). Molto utile è, a suo giudizio, il procedimento dell’amplificazione, che consiste nell’introdurre via via concetti sempre più elevati: questo susseguirsi incalzante di concetti elevati può pervenire alla cosiddetta “prova”, che consiste nel portare il lettore o l’ascoltatore alla persuasione mediante un itinerario razionale che si realizza tramite un susseguirsi di elementi probativi. Gli altri due procedimenti sono di carattere tipicamente intimo e spirituale: l’imitazione e la fantasia. Potremmo avere qualche riserva sull’imitazione, che però l’Anonimo considera essenziale strumento didattico, finalizzato a promuovere la ricchezza della vita interiore. Per lui, attraverso questa via, si attua l’educazione alla grandezza, per raggiungere la quale è fondamentale la lettura dei grandi poeti, che sanno nutrire lo spirito e lo rendono idoneo a produrre l’ispirazione suscitando stati d’animo e atteggiamenti simili a quelli da cui le grandi opere sono nate. Per l’Anonimo l’imitazione non è quindi pedissequa riproduzione a livello formale, ma è acquis
izione di identità di sentire, di pensare, di valutare. Per esemplificare questa sua affermazione, dimostra che dal grandissimo Omero hanno tratto ispirazione Erodono, Stesicoro, Archiloco e, soprattutto, Platone. Sempre per quanto riguarda l’imitazione, l’Anonimo si sofferma poi a distinguerla dal plagio: a suo giudizio, la consonanza con autori precedenti non è furto, ma piuttosto un rinnovarsi delle condizioni spirituali da cui hanno avuto origine le espressioni sublimi. Soprattutto egli intende l’imitazione come emulazione: si stabilisce in certo qual modo una gara in cui l’oratore e il poeta chiamano a testimoni e a giudici i grandi del passato e, cimentandosi in paragone con loro, chiede che essi stabiliscano se lui nuovo competitore sia alla loro altezza e quindi degno di essere accolto nel consesso in cui si affermano i più alti valori che prescindono dai limiti del tempo (capp. XIII e XIV). È questa una concezione che perdura a lungo nella nostra tradizione letteraria, come attestano Dante quando dice di essere sesto tra cotanto senno e Machiavelli quando racconta all’amico Francesco Vettori di sedere in elevati conversari con gl’illustri letterati dell’antichità.
Merita poi particolare attenzione il capitolo in cui l’Autore tratta della fantasia. Egli afferma che si chiama fantasia “tutto ciò che suscita un pensiero generatore di parole”, ma poi aggiunge che a questo termine nell’uso comune si dà piuttosto il significato di “espressione in cui chi parla per effetto di entusiasmo e di commozione ha l’impressione di vedere veramente quello di cui parla e nello stesso tempo riesce a metterlo davanti agli occhi di chi ascolta”. Da queste premesse e dai vari esempi che egli adduce risulta chiaro il modo in cui l’Anonimo concepisce l’arte: per lui non è rappresentazione della realtà esterna, ma espressione del particolare modo in cui l’animo del poeta o dell’oratore costruisce il mondo delle sue visioni sotto l’influsso delle passioni, il che rende evidente che nella concezione dell’arte dell’Autore l’accento è posto sull’elemento soggettivo (cap. XV). A questo punto l’Autore dichiara di aver trattato sufficientemente del sublime in rapporto ai concetti e alla sua derivazione dalla grandezza d’animo tramite l’imitazione e la fantasia, di aver cioè esaurito la trattazione di quella che egli ha affermato essere la prima e più importante fonte del sublime. Ci si aspetterebbe ora la trattazione della seconda fonte, l’intensità di sentimento o pàthos. In realtà questo argomento verrà sviluppato solo alla fine dell’opera, nel cap. XLIV, il che ha fatto nascere molte questioni filologiche sulla collocazione di questo stesso capitolo e sul contenuto di quelli perduti. A giudizio dell’Anonimo la passione è l’elemento fondamentale del sublime, ma non è da confondersi con esso, anzi spesso i due termini ùpsos e pàthos formano quasi un’endiadi per indicare appunto il sublime stesso. Successivamente l’Autore si impegna a rispondere ad un interrogativo, non nuovo nella cultura del suo tempo: qual è la ragione per cui, pur non mancando intelligenze acute e vivaci, molto raramente nella produzione letteraria si raggiunge ormai l’eccellenza? Il nostro Anonimo condivide per certi aspetti le posizioni di chi fa riferimento alla tirannide politica, ma precisa che c’è una schiavitù più grave di questa: è la schiavitù delle passioni, che distruggono i fondamenti della vita morale; cupidigia di ricchezze e bramosia di piaceri abbassano le tensioni degli animi e generano altri vizi che annientano ogni nobile aspirazione. Qualora regni l’indifferenza per ciò che è degno di emulazione e di onore, non può esserci tensione verso il sublime, neppure da parte delle intelligenze più brillanti.
La parte successiva dell’opera indaga su quelle fonti del sublime che si fondano prevalentemente sullo studio, innanzitutto le figure retoriche, terza fonte del sublime. Nel loro uso l’Autore consiglia accortezza e misura, in quanto, a suo giudizio, sono utili quando non ci si accorga di esse. Esamina dettagliatamente le figure di pensiero: l’apostrofe, l’interrogazione retorica, l’asindeto, l’anafora, la diapotiposi, l’iperbato, il poliptoto, il passaggio dal discorso diretto a quello indiretto e la perifrasi (capp. XVI – XXIX). Successivamente egli dichiara di aver completata la trattazione delle figure, ma noi avvertiamo la mancanza di alcun cenno a quelle che chiamiamo abitualmente figure di parola (o tropi), delle quali parlerà però nel trattare della quarta fonte che, come ha anticipato nel capitolo VIII, comprende, insieme alla scelta delle parole, l’elaborazione dell’espressione con l’uso traslati. L’Autore non si sofferma molto sulla scelta delle parole, limitandosi a consigliare lo sfarzo solo quando sia veramente opportuno. Anche per l’espressione, a suo giudizio, la maggiore o minore ricercatezza deve essere suggerita dall’ispirazione, che sola sa indicare quando l’espressione ornata sia più opportuna ed efficace di quella comune. Anche per il numero delle metafore l’Anonimo non ritiene che lo si possa determinare a priori, ma pensa piuttosto che esso debba essere suggerito di volta in volta dall’opportunità in relazione all’accendersi delle passioni e all’elevarsi del pensiero. Anche se l’incalzare dei tropi gli pare favorire la realizzazione del sublime, mette in guardia dal rischio di passare la misura del conveniente (cap. XXXII). Oltre che sulla metafora l’Autore si sofferma sulla comparazione, sulla similitudine, sull’iperbole e sull’attenuazione e molto probabilmente trattava di altri tropi nella lacuna che si riscontra tra il capitolo XXX e il XXXI.
Nell’esposizione della quarta fonte del sublime si inserisce un’interessante digressione (capp. XXXIII – XXXVI) che ha come argomento l’interrogarsi sul fatto se sia preferibile, tanto nella poesia, quanto nella prosa, l’impeccabilità o la grandezza. A questo riguardo l’Anonimo afferma con decisione che la grandezza, sebbene comporti il rischio della caduta, è preferibile all’assoluta esattezza, in quanto quest’ultima rischia di perdersi nella minuzia. A suo parere, i grandi ingegni non sono affatto esenti da difetti, mentre i mediocri, che non aspirano a raggiungere alti livelli, evitano più facilmente gli errori. Per esemplificare questa affermazione, esprime la sua preferenza nei confronti di Omero, nei cui poemi si incontrano non poche imperfezioni, rispetto alla perfezione formale delle Argonautiche di Apollonio Rodio. A questa valutazione aggiunge quella su Eratostene, il cui poemetto Erigone è irreprensibile, ma che non ritiene sia da anteporre ai componimenti di Archiloco, spesso disordinato nel suo impeto espressivo. Allo stesso modo si possono soppesare Bacchilide e Pindaro, Ione e Sofocle: i primi scrivono con ineccepibile eleganza, mentre gli altri, lasciandosi trasportare dalla loro ispirazione, non sono costantemente alla stessa altezza. Così Demostene nella sua veemenza supera tutti gli oratori, anche se Iperide ha maggior abbondanza di pregi. Evidentemente gli spiriti più grandi nello slancio della loro creazione trascurano l’osservanza meticolosa dei particolari avendo come obiettivo massimo il nobile destino assegnato all’uomo, il quale “pur avendo facilmente a disposizione ciò che è utile o anche necessario, ammira piuttosto ciò che esula dall’ordinario” (cap. XXXV) e d’altra parte riscattano tutti i loro errori con uno solo dei loro caratteri sublimi, che li innalzano al di sopra di tutti gli altri uomini (cap. XXXVI).
La quinta fonte del sublime è l’armonica composizione del periodo: su questa questione l’Autore non si sofferma molto, ma rimanda a quanto ha scritto in un’altra sua opera a noi purtroppo non pervenuta. Capiamo comunque che la sua idea è che basta cambiare l’ordine delle parole di un passo ritenuto sublime, o anche solo eliminare una sillaba per perdere l’effetto di eccellenza. Si sofferma in particolare sulla metrica: a suo giudizio i ritmi dattilici dato che permettono di appoggiare la voce sulle lunghe, favoriscono il conseguimento del sublime, mentre il martellare dei pirrichi, dei trochei e dei dicorei produce un effetto più basso. Del resto il costante insistere su una cadenza uniforme attrae l’orecchio dell’ascoltatore e lo distoglie dal prestare piena attenzione al soggetto trattato. Inoltre i singoli membri del periodo devono risultare connessi in un armonico sistema in quanto, solo attraverso questa tessitura espressiva, si perviene alla grandezza e quindi al sublime, mentre l’eccessiva spezzettatura del periodo non genera nobiltà e l’eccessiva brevità (quando non sia opportuna ed incisiva concisione) mutila il pensiero e ancora la prolissità lo infiacchisce (capp. XL – XLII), mentre è sconveniente passare, senza necessità, da espressioni elevate a termini bassi (cap. XLIII).
Che interesse possono avere per noi oggi queste considerazioni dell’Anonimo autore Del Sublime? Vediamo innanzitutto una concezione dell’arte fortemente caratterizzata dalla valutazione morale in ordine alla grandezza e all’elevatezza dell’animo e del pensiero. Questo vuol dire, in base alle esemplificazioni desumibili dai poemi omerici e dai grandi autori tragici, anche attraversare le bassezze della realtà umana ma avere un indirizzo, una meta di eccellenza da far risaltare, vuol dire osservare e giudicare, esporre e scegliere, in modo non semplicemente descrittivo, bensì orientato. Tutto può rientrare e amalgamarsi nella prospettiva della creazione del sublime, purché tutti gli elementi, tutte le parti vengano armonizzate con equilibrio e misura, nonché opportunamente indirizzati verso un punto alto. Strettamente connesso diventa allora il discorso dell’insegnamento delle tecniche compositive: le doti naturali e quelle tecniche si sostengono e si fortificano a vicenda, anche se alla base di tutto c’è quello che l’Anonimo definisce un “animo grande”, che è senza dubbio un animo naturalmente ricco e fine, ma anche un animo educato secondo una determinata e corretta scala di valori. Quindi a monte dell’educazione letteraria si profila la necessità di una pienezza di educazione umana, secondo una scala di valori che in base alla cultura e alla coscienza sociale possono anche subire spostamenti. Ad esempio, noi oggi posponiamo l’eroismo militare alla solidarietà, di conseguenza mettiamo in ombra il concetto di “nemico” a tutto vantaggio di quello di “uomo”, diamo valore alla pace rispetto alla guerra. I valori sono l’espressione di una elaborazione culturale complessa e l’espressione di una coscienza sociale, per cui gli eroi sono in ogni tempo e in ogni luogo coloro che incarnano i valori riconosciuti e condivisi da una comunità. L’importante, prima di scrivere, è avere una ricchezza umana che permetta di guardare se stessi, gli altri e la realtà circostante in modo consapevole, che per noi vuol dire soprattutto aperti e disponibili al mistero dell’esistenza, capaci di accettarla e viverla nella sua dimensione totale. Penso che potremmo così interpretare l’antico precetto della “grandezza d’animo”. Il secondo passaggio è quello della tecnica espressiva. A questo riguardo le idee dell’Anonimo sono fortemente precettive, in rapporto a precise norme codificate del testo scritto, sia in prosa che in poesia, la cui osservanza condiziona, a giudizio suo ampiamente condiviso nel suo tempo, nonché accettato e sostenuto fino alle soglie dell’età moderna, la valutazione dell’opera. Questo tipo di normativa a noi, eredi della mentalità romantica, ulteriormente liberatasi nell’esperienza del Decadentismo e attraverso le Avanguardie primo e tardo Novecentesche, può apparire difficile da accettare, ma mi pare vi siano due punti da mettere in rilievo, che, correttamente interpretati, possono sempre costituire degli elementi guida: innanzitutto l’idea dell’adeguatezza dello stile all’argomento di cui si tratta e al tono, o registro espressivo, con cui lo si vuole trattare, secondariamente l’efficacia dell’espressione, il trovare cioè il modo di esprimersi che veicoli dall’emittente al destinatario il massimo di informazioni e di emozioni nella forma più efficace, ma anche più nuova. Su questo la moderna didattica della scrittura può impegnarsi a far acquisire la spontaneità espressiva attraverso il controllo formale della personale creatività. La didattica della scrittura ha il compito di disciplinare le doti naturali verso il traguardo della massima efficacia, incanalando la spontaneità espressiva verso l’obiettivo più alto, quindi individuando dei percorsi, delle strade che portino a quello che il nostro Anonimo definisce “il culmine e l’apice dell’arte della parola”; per questo è importante anche guardare con occhio ammirato gli esempi del passato con l’atteggiamento, ancora una volta propostoci dagli stessi classici, di mettersi in gara, di andare oltre, di fare meglio.
Edizioni e Studi
A. Rostagni, Sul sublime, Istituto Editoriale Italiano, Milano, 1947 (ripubblicato nel 1982 con aggiornamenti a cura di L. Belloni); con ampia introduzione, testo greco e traduzione italiana a fronte.
- M. Mazzocchi, Sul sublime, Vita e Pensiero, Milano, 1992; con approfondito commento, testo greco e traduzione italiana a fronte.
- Matelli, Sul sublime, Rusconi, Milano, 1988; traduzione italiana con ampia introduzione e commento.
- Donadi, Sul sublime, BUR, Milano, 1991; introduzione, commento e testo greco con traduzione italiana a fronte.
Trattandosi di un’opera specialistica, gli studi che la riguardano sono di solito pubblicati su riviste di filologia classica. Per una prima informazione critica possono essere utili le introduzioni delle opere citate, corredate anche di indicazioni bibliografiche per eventuali approfondimenti.

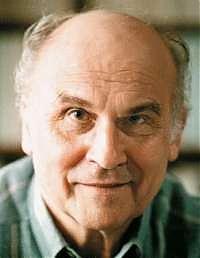
 2. “Homunculus”, manga di Hideo Yamamoto (editore Panini)
2. “Homunculus”, manga di Hideo Yamamoto (editore Panini) All’inizio del 2004, anno che si è rivelato di particolare fortuna per la narrativa breve (1) , è uscita postuma anche un’agile raccolta di racconti di Stefano Jacomuzzi, Il male senza parole e altri racconti per i tipi della Joker, e a cura di Franco Pappalardo La Rosa. L’autore, meglio conosciuto come insigne italianista, negli ultimi anni di vita (è scomparso nel 1996) si è cimentato anche come narratore, pubblicando i romanzi Un vento sottile (1988), Le storie dell’ultimo giorno (1993), e Cominciò in Galilea (1995). Il male senza parole raccoglie sei brevi racconti, non inediti, poiché già tutti pubblicati su diversi quotidiani nell’arco di tempo corrispondente a quello di pubblicazione dei tre romanzi.
All’inizio del 2004, anno che si è rivelato di particolare fortuna per la narrativa breve (1) , è uscita postuma anche un’agile raccolta di racconti di Stefano Jacomuzzi, Il male senza parole e altri racconti per i tipi della Joker, e a cura di Franco Pappalardo La Rosa. L’autore, meglio conosciuto come insigne italianista, negli ultimi anni di vita (è scomparso nel 1996) si è cimentato anche come narratore, pubblicando i romanzi Un vento sottile (1988), Le storie dell’ultimo giorno (1993), e Cominciò in Galilea (1995). Il male senza parole raccoglie sei brevi racconti, non inediti, poiché già tutti pubblicati su diversi quotidiani nell’arco di tempo corrispondente a quello di pubblicazione dei tre romanzi. 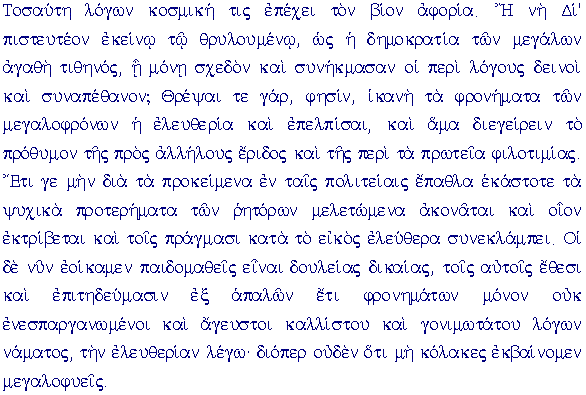 Sul sublime (Perì ùpsous) è il titolo di un opuscolo redatto in forma epistolare, di cui non è stato ancora possibile accertare l’autore, ma che vari elementi inducono gli studiosi a datare al I sec. d.C., forse intorno al 40. Conservatoci in forma lacunosa da 11 manoscritti, il più antico dei quali, il Parisinus 2036, a cui sembrano risalire direttamente o indirettamente tutti gli altri, è del secolo X, fu fatto conoscere da Francesco Robortelli, che lo pubblicò a Basilea nel 1554. Da allora gli studiosi si impegnarono soprattutto nell’identificazione dell’autore e nella ricostruzione filologica del testo, ma il suo importante contenuto ebbe un ruolo di rilievo nella cultura francese del XVII secolo, in quanto fu tradotto da Nicolas Boileau nel 1674. Successivamente influenzò notevolmente il pensiero tedesco, soprattutto per quanto riguarda la formulazione delle teorie estetiche di Lessin, di Burke e di Kant, mentre in Inghilterra lasciò tracce significative nella riflessione di Dryden, Swift e Pope. Durante il Romanticismo diminuì l’interesse nei suoi confronti, mentre trovò nuova fortuna nel Novecento, in Italia, soprattutto per merito di Benedetto Croce. Anche se questo testo nel corso dei secoli dell’età moderna è stato letto come un’opera di critica letteraria o come un trattato di estetica, esso sviluppa in realtà una sola idea, quella del “sublime”: con questo termine si indica il momento della perfetta sintesi tra forma e contenuto, che si ha quando, raggiunta la massima tensione espressiva, l’autore riesce a provocare nei suoi destinatari un intenso coinvolgimento emotivo, al quale la razionalità è completamente estranea. Cerchiamo di ripercorrere sommariamente il ragionamento dell’Anonimo autore, il quale, rivolgendosi ad un amico romano avviato alla carriera forense e politica, Postumio Floro Terenziano, si propone di insegnare come il sublime si possa conseguire. Il termine greco ùpsos letteralmente significa “altezza”, per cui viene reso in latino con sublimitas e sublime e, a giudizio dell’Autoew, è “il culmine e l’àpice dell’arte della parola” ed è l’elemento specifico e caratteristico grazie al quale i grandi poeti e prosatori conseguirono la gloria (cap. I). Questa eccellenza però non è il risultato di ricerche e di impegno puramente formali, ma deriva da nobiltà di concezione, da fervore di vita a livello fantastico e sentimentale, in definitiva da una ricchezza spirituale sovrabbondante che si riesce a trasferire compiutamente nella pagina scritta. A questo punto nascono degli interrogativi molto interessanti anche per noi oggi. Infatti l’Autore si chiede come si potrà insegnare un’arte che si basa soprattutto su condizioni spirituali, in particolare sulla grandezza d’animo, che, essendo come pensano molti, dote innata, non può essere acquisita. A queste possibili obiezioni l’Anonimo risponde che, pur essendo vero che le doti naturali sono condizione di base per ogni creazione artistica, esse devono essere opportunamente guidate e disciplinate: l’ispirazione disordinata e non opportunamente incanalata verso la correttezza espositiva non porta all’eccellenza, in quanto l’estro ha bisogno di essere sottoposto al metodo per essere temperato, ma anche spronato, senza contare poi che solo lo studio è in grado di rivelare la presenza di talune disposizioni naturali (cap. II). Senza quello che poi Dante chiamerà il fren de l’arte (Purg. XXXIII, 141) anche chi è naturalmente dotato può incorrere in taluni difetti: dal sublime può facilmente trapassare nell’enfasi, cadere nella futilità oppure lasciarsi trascinare ad una concitazione inopportuna, abusando di quelle disposizioni che, se invece ben disciplinate, possono far raggiungere livelli di eccellenza (capp. III e IV). Successivamente l’Autore, pur riconoscendo che solo grazie ad ampie e ben scelte letture, si affina il gusto letterario, si impegna per individuare un criterio che distingua il sublime reale da quello che potrebbe apparire tale ad una considerazione superficiale. A suo giudizio, il sublime consiste nel potere che hanno le opere veramente eccellenti di disporre l’animo alla grandezza, di suscitare intensi sentimenti e promuovere considerazioni elevate, inoltre nel far sì che perduri l’impressione da esse prodotta e che si rinnovi nel ripetersi degli incontri con il testo, infine anche nel concorde consenso del giudizio in persone diverse per condizioni di vita, consuetudini e cultura (capp. V – VII). A questo punto l’Anonimo cerca di individuare e fissare le fonti essenziali del sublime. Ne individua cinque, che espone in ordine d’importanza: le prime due sono l’elevatezza di pensiero e l’intensità di sentimento (pàthos), mentre le altre tre sono l’uso di figure retoriche (di pensiero e di parola), la nobiltà di elocuzione, cioè lo stile che comprende la scelta dei vocaboli e l’elaborazione dell’espressione con l’uso dei traslati, e infine la configurazione dignitosa e solenne del periodo. Naturalmente le prime due si rapportano alla sfera delle doti innate, mentre le ultime tre si conseguono e affinano con lo studio. Le prime due sono essenziali, secondo l’Anonimo, per il quale l’arte non è artificio di parola o di frase e che afferma che “il sublime è l’eco della grandezza d’animo” (cap.IX, 2). Egli afferma con convinzione profonda che solo chi ha animo nobile e si dedica a pensieri elevati può esprimere qualcosa di eccellente e pone di conseguenza l’accento sulla nobiltà d’animo e sulla dignità morale dell’artista. La disposizione alla grandezza d’animo, sebbene sia considerata dall’Autore una dote naturale, può, a suo giudizio, essere stimolata e coltivata, non con esercizi formali, ma con la frequentazione di pensieri elevati, tramite la compartecipazione dello scrittore a quanto esprime (a questo proposito cita Omero che “suole condividere con i suoi eroi la grandezza epica”) e mediante lo sforzo di elevarsi verso la grandezza come “il legislatore degli Ebrei”, che dovette comprendere “tutta la maestà di Dio” per esprimerla come fece al principio delle Leggi” (cap. IX). Dopo aver fissato il presupposto fondamentale della grandezza d’animo come dote naturale indispensabile per riuscire a dire cose sublimi, l’Autore approfondisce la sua indagine, cercando di individuare quali possano essere gli aiuti per raggiungere il sublime e ne individua quattro: la concentrazione delle idee più elevate riguardanti il soggetto da trattare, l’amplificazione, l’imitazione e la fantasia. Dapprima, sottolineando che in ogni argomento vi sono particolarità caratteristiche, consiglia di scegliere le più rilevanti e di comporle insieme, trascurando le altre, secondo un procedimento di concentrazione delle idee più elevate (cap. X). Molto utile è, a suo giudizio, il procedimento dell’amplificazione, che consiste nell’introdurre via via concetti sempre più elevati: questo susseguirsi incalzante di concetti elevati può pervenire alla cosiddetta “prova”, che consiste nel portare il lettore o l’ascoltatore alla persuasione mediante un itinerario razionale che si realizza tramite un susseguirsi di elementi probativi. Gli altri due procedimenti sono di carattere tipicamente intimo e spirituale: l’imitazione e la fantasia. Potremmo avere qualche riserva sull’imitazione, che però l’Anonimo considera essenziale strumento didattico, finalizzato a promuovere la ricchezza della vita interiore. Per lui, attraverso questa via, si attua l’educazione alla grandezza, per raggiungere la quale è fondamentale la lettura dei grandi poeti, che sanno nutrire lo spirito e lo rendono idoneo a produrre l’ispirazione suscitando stati d’animo e atteggiamenti simili a quelli da cui le grandi opere sono nate. Per l’Anonimo l’imitazione non è quindi pedissequa riproduzione a livello formale, ma è acquis
Sul sublime (Perì ùpsous) è il titolo di un opuscolo redatto in forma epistolare, di cui non è stato ancora possibile accertare l’autore, ma che vari elementi inducono gli studiosi a datare al I sec. d.C., forse intorno al 40. Conservatoci in forma lacunosa da 11 manoscritti, il più antico dei quali, il Parisinus 2036, a cui sembrano risalire direttamente o indirettamente tutti gli altri, è del secolo X, fu fatto conoscere da Francesco Robortelli, che lo pubblicò a Basilea nel 1554. Da allora gli studiosi si impegnarono soprattutto nell’identificazione dell’autore e nella ricostruzione filologica del testo, ma il suo importante contenuto ebbe un ruolo di rilievo nella cultura francese del XVII secolo, in quanto fu tradotto da Nicolas Boileau nel 1674. Successivamente influenzò notevolmente il pensiero tedesco, soprattutto per quanto riguarda la formulazione delle teorie estetiche di Lessin, di Burke e di Kant, mentre in Inghilterra lasciò tracce significative nella riflessione di Dryden, Swift e Pope. Durante il Romanticismo diminuì l’interesse nei suoi confronti, mentre trovò nuova fortuna nel Novecento, in Italia, soprattutto per merito di Benedetto Croce. Anche se questo testo nel corso dei secoli dell’età moderna è stato letto come un’opera di critica letteraria o come un trattato di estetica, esso sviluppa in realtà una sola idea, quella del “sublime”: con questo termine si indica il momento della perfetta sintesi tra forma e contenuto, che si ha quando, raggiunta la massima tensione espressiva, l’autore riesce a provocare nei suoi destinatari un intenso coinvolgimento emotivo, al quale la razionalità è completamente estranea. Cerchiamo di ripercorrere sommariamente il ragionamento dell’Anonimo autore, il quale, rivolgendosi ad un amico romano avviato alla carriera forense e politica, Postumio Floro Terenziano, si propone di insegnare come il sublime si possa conseguire. Il termine greco ùpsos letteralmente significa “altezza”, per cui viene reso in latino con sublimitas e sublime e, a giudizio dell’Autoew, è “il culmine e l’àpice dell’arte della parola” ed è l’elemento specifico e caratteristico grazie al quale i grandi poeti e prosatori conseguirono la gloria (cap. I). Questa eccellenza però non è il risultato di ricerche e di impegno puramente formali, ma deriva da nobiltà di concezione, da fervore di vita a livello fantastico e sentimentale, in definitiva da una ricchezza spirituale sovrabbondante che si riesce a trasferire compiutamente nella pagina scritta. A questo punto nascono degli interrogativi molto interessanti anche per noi oggi. Infatti l’Autore si chiede come si potrà insegnare un’arte che si basa soprattutto su condizioni spirituali, in particolare sulla grandezza d’animo, che, essendo come pensano molti, dote innata, non può essere acquisita. A queste possibili obiezioni l’Anonimo risponde che, pur essendo vero che le doti naturali sono condizione di base per ogni creazione artistica, esse devono essere opportunamente guidate e disciplinate: l’ispirazione disordinata e non opportunamente incanalata verso la correttezza espositiva non porta all’eccellenza, in quanto l’estro ha bisogno di essere sottoposto al metodo per essere temperato, ma anche spronato, senza contare poi che solo lo studio è in grado di rivelare la presenza di talune disposizioni naturali (cap. II). Senza quello che poi Dante chiamerà il fren de l’arte (Purg. XXXIII, 141) anche chi è naturalmente dotato può incorrere in taluni difetti: dal sublime può facilmente trapassare nell’enfasi, cadere nella futilità oppure lasciarsi trascinare ad una concitazione inopportuna, abusando di quelle disposizioni che, se invece ben disciplinate, possono far raggiungere livelli di eccellenza (capp. III e IV). Successivamente l’Autore, pur riconoscendo che solo grazie ad ampie e ben scelte letture, si affina il gusto letterario, si impegna per individuare un criterio che distingua il sublime reale da quello che potrebbe apparire tale ad una considerazione superficiale. A suo giudizio, il sublime consiste nel potere che hanno le opere veramente eccellenti di disporre l’animo alla grandezza, di suscitare intensi sentimenti e promuovere considerazioni elevate, inoltre nel far sì che perduri l’impressione da esse prodotta e che si rinnovi nel ripetersi degli incontri con il testo, infine anche nel concorde consenso del giudizio in persone diverse per condizioni di vita, consuetudini e cultura (capp. V – VII). A questo punto l’Anonimo cerca di individuare e fissare le fonti essenziali del sublime. Ne individua cinque, che espone in ordine d’importanza: le prime due sono l’elevatezza di pensiero e l’intensità di sentimento (pàthos), mentre le altre tre sono l’uso di figure retoriche (di pensiero e di parola), la nobiltà di elocuzione, cioè lo stile che comprende la scelta dei vocaboli e l’elaborazione dell’espressione con l’uso dei traslati, e infine la configurazione dignitosa e solenne del periodo. Naturalmente le prime due si rapportano alla sfera delle doti innate, mentre le ultime tre si conseguono e affinano con lo studio. Le prime due sono essenziali, secondo l’Anonimo, per il quale l’arte non è artificio di parola o di frase e che afferma che “il sublime è l’eco della grandezza d’animo” (cap.IX, 2). Egli afferma con convinzione profonda che solo chi ha animo nobile e si dedica a pensieri elevati può esprimere qualcosa di eccellente e pone di conseguenza l’accento sulla nobiltà d’animo e sulla dignità morale dell’artista. La disposizione alla grandezza d’animo, sebbene sia considerata dall’Autore una dote naturale, può, a suo giudizio, essere stimolata e coltivata, non con esercizi formali, ma con la frequentazione di pensieri elevati, tramite la compartecipazione dello scrittore a quanto esprime (a questo proposito cita Omero che “suole condividere con i suoi eroi la grandezza epica”) e mediante lo sforzo di elevarsi verso la grandezza come “il legislatore degli Ebrei”, che dovette comprendere “tutta la maestà di Dio” per esprimerla come fece al principio delle Leggi” (cap. IX). Dopo aver fissato il presupposto fondamentale della grandezza d’animo come dote naturale indispensabile per riuscire a dire cose sublimi, l’Autore approfondisce la sua indagine, cercando di individuare quali possano essere gli aiuti per raggiungere il sublime e ne individua quattro: la concentrazione delle idee più elevate riguardanti il soggetto da trattare, l’amplificazione, l’imitazione e la fantasia. Dapprima, sottolineando che in ogni argomento vi sono particolarità caratteristiche, consiglia di scegliere le più rilevanti e di comporle insieme, trascurando le altre, secondo un procedimento di concentrazione delle idee più elevate (cap. X). Molto utile è, a suo giudizio, il procedimento dell’amplificazione, che consiste nell’introdurre via via concetti sempre più elevati: questo susseguirsi incalzante di concetti elevati può pervenire alla cosiddetta “prova”, che consiste nel portare il lettore o l’ascoltatore alla persuasione mediante un itinerario razionale che si realizza tramite un susseguirsi di elementi probativi. Gli altri due procedimenti sono di carattere tipicamente intimo e spirituale: l’imitazione e la fantasia. Potremmo avere qualche riserva sull’imitazione, che però l’Anonimo considera essenziale strumento didattico, finalizzato a promuovere la ricchezza della vita interiore. Per lui, attraverso questa via, si attua l’educazione alla grandezza, per raggiungere la quale è fondamentale la lettura dei grandi poeti, che sanno nutrire lo spirito e lo rendono idoneo a produrre l’ispirazione suscitando stati d’animo e atteggiamenti simili a quelli da cui le grandi opere sono nate. Per l’Anonimo l’imitazione non è quindi pedissequa riproduzione a livello formale, ma è acquis Giacomo Debenedetti ha vissuto il suo lavoro di critico come un’esperienza ariosa e totalizzante, capace di richiedere un coinvolgimento integrale. Rompendo ogni schematismo, ha vissuto lo studio letterario come un fatto di coscienza, oltre che di competenza, da vivere con un rigore intriso di passione e calore. Forse più di altri ha realmente colto la sostanza di quell’«epica dell’esistenza» che è il romanzo europeo del Novecento, e l’ha saputa raccontare istituendo un patto biografico ed ermeneutico tra se stesso, gli autori, le opere, e soprattutto i personaggi. Debenedetti considera come fare storia del romanzo significhi in realtà fare storia del personaggio. In un colloquio con Cecchi confessava: «quel critico che io vorrei essere, interroga […] le voci, le affermazioni, le negazioni degli artisti, le loro riuscite e i loro errori, appunto per chiarire a se stesso e agli altri il senso e il fine della vita». È esattamente questo ciò che anch’io vorrei essere in quanto critico. Per questo amo Debenedetti. Se la critica dimentica il confronto con il senso della vita è condannata semplicemente ad essere flatus vocis, tradendo se stessa. I saggi di Debenedetti si trasformano in vere e proprie scommesse, non indenni da approssimazioni ed errori, che tengono d’occhio innanzitutto la linea d’orizzonte del «destino» dell’uomo europeo del Novecento, il suo immaginario e la sua coscienza. Debenedetti indaga la letteratura alla ricerca di un’illuminazione, ma questa ricerca è da intendersi come una vera e propria lotta, un corpo a corpo col testo, con l’autore e anche con se stesso: la critica perpetua il mito della lotta di Giacobbe conto l’angelo e non può nascere, veramente feconda, se non come dramma. La sua è innanzitutto una lezione di «stile» critico, di atteggiamento fondamentale. La radice profonda di una forma critica così intensa e coinvolgente da divenire una vera e propria «vocazione» bruciante, è ampiamente biblica. Occorre rileggere – e questa è la parte del suo magistero che mi affascina maggiormente, che è anche quella più acerba e brulicante – le sue cinque conferenze sui Profeti tenute nel 1924 in una sede legata alla Comunità ebraica di Torino. Qui si riconosce il Debenedetti che sceglie un cammino di lettura senza aver predisposto un itinerario, e soprattutto il critico che raggiunge la poesia partendo proprio dall’animo del poeta e non dall’asettica applicazione al testo degli strumenti della «scienza della letteratura». Di queste conferenze a noi restano una massa di appunti, raccolti in cartelle, che sono stati dati alle stampe nel 1998. Il giovane Debenedetti nella sua formazione acquisisce una sensibilità per il testo biblico che farà sentire i suoi echi fino alla fine del suo percorso di critico e di uomo. Il ritratto complessivo delle figure profetiche ne fa percepire tutta la visceralità: «Il loro dolore è un torrente di lava che strugge le montagne. La loro speranza, erompe ora come boato da terra convulsa, ed or mansueta sorride come l’arcobaleno che Iddio mandò a Noè dopo il diluvio, […]. La loro umanità non si manifesta per valori trattabili, bensì nel diapason, nell’esasperazione, nell’eccesso di ogni possibile sentimento umano». La riflessione sulle conferenze non è mancata negli anni che ci separano dalla loro pubblicazione in volume. Esse tuttavia sono state sostanzialmente esaminate in se stesse e ancora troppo poco in rapporto alla vicenda critica di Debenedetti. In quelle pagine manoscritte egli ha coniugato le sue radici ebraico-bibliche con gli elementi fondanti del suo metodo. Occorre riconoscere che la critica letteraria per Debenedetti ha un riferimento preciso, più o meno implicito, nell’esegesi ebraica, fondata sull’interrogazione del testo e sul commento. Il termine «esegesi» significa raccontare, esporre, interpretare un testo «traendone fuori» (exegèomai) il significato. Le letture di Debenedetti hanno proprio il gusto di un racconto esegetico che vale per il suo senso e per le relazioni che intesse tra elementi distanti. Qualche esempio: il profeta Amos, con la sua forza drammatica e scenica capace di sorprendere sempre la realtà in movimento, ha molti tratti simili a quelli che nel ‘40 Debenedetti attribuirà a Vittorio Alfieri. Nel caso del profeta Osea, che viene dipinto con gli stessi pennelli che più tardi Debenedetti userà per dipingere Umberto Saba, la profezia è «veduta in una biografia: l’autobiografia del profeta». Isaia è il modello «perfetto», se così si può dire, di profeta, quello dal quale Debenedetti appare maggiormente attratto, a tal punto da fargli affermare che «Forse nemmeno Dante, nelle più accese estasi del suo Paradiso, ha toccato un tal punto di umana grandezza». Ed è a proposito del linguaggio di Isaia che Debenedetti darà la definizione di metafora, che per il proprio linguaggio critico resterà sempre valida fino alla fine: «La metafora, non traveste, ma rinnova la realtà sotto luci che sono d’invenzione e di scoperta». Ancora a Isaia è attribuita la dote di poeta senza che egli abbia fatto nulla per volerla: «Egli appartiene a quella schiera di giganti per cui la poesia non è un consapevole e volontario sforzo d’arte, ma piuttosto una necessità del loro linguaggio, un altissimo valore interno delle parole che vogliono essere dette». A proposito del profeta Geremia è esplicitata, in una pagina memorabile, la tesi della «logica concessiva» della critica, opposta a qualunque «logica consecutiva» perché «La vita profonda sfugge, per quanto noi ne possiamo sapere, a tutti i rapporti che si possono preventivamente fissare». E, a titolo esemplificativo, segue l’accostamento di Geremia a Dostojevski. E più in generale, il modo in cui Debenedetti intende il rifiuto operato dai narratori del Novecento di una logica stringente di causa-effetto per aderire alla logica della probabilità ha già una anticipazione nella descrizione del passaggio nella storia biblica dal rapporto con l’Assoluto inteso come regolato dalla legge del dare-avere alla complessa e interiore legge scritta nel «cuore di carne». È anche da questa intuizione di origine profetica che sembra svilupparsi il modo di ritrarre la complessa figura del personaggio del romanzo novecentesco nella lettura debenedettiana. Ma gli esempi potrebbero moltiplicarsi. Qui c’è tutto il grande Debenedetti che sento vicino: padre, maestro, ma anche compagno. Se Debenedetti pochi anni prima della morte aveva scritto che fine della critica letteraria è «aprire l’ostrica», egli già quarant’anni prima aveva scritto che «I Profeti rompono la crosta e portano in luce la polla». Affrontare criticamente un testo letterario significa estrarre una perla dall’ostrica o far sgorgare l’acqua da una crosta di terra. Ma il frutto della conquista è sempre «possesso precario», mai accerchiamento definitivo. Modello di azione del critico letterario è dunque il profeta. Ecco il messaggio che sento per me e non solo per me urgente e bruciante per chiunque oggi intenda essere «critico» o anche lettore.
Giacomo Debenedetti ha vissuto il suo lavoro di critico come un’esperienza ariosa e totalizzante, capace di richiedere un coinvolgimento integrale. Rompendo ogni schematismo, ha vissuto lo studio letterario come un fatto di coscienza, oltre che di competenza, da vivere con un rigore intriso di passione e calore. Forse più di altri ha realmente colto la sostanza di quell’«epica dell’esistenza» che è il romanzo europeo del Novecento, e l’ha saputa raccontare istituendo un patto biografico ed ermeneutico tra se stesso, gli autori, le opere, e soprattutto i personaggi. Debenedetti considera come fare storia del romanzo significhi in realtà fare storia del personaggio. In un colloquio con Cecchi confessava: «quel critico che io vorrei essere, interroga […] le voci, le affermazioni, le negazioni degli artisti, le loro riuscite e i loro errori, appunto per chiarire a se stesso e agli altri il senso e il fine della vita». È esattamente questo ciò che anch’io vorrei essere in quanto critico. Per questo amo Debenedetti. Se la critica dimentica il confronto con il senso della vita è condannata semplicemente ad essere flatus vocis, tradendo se stessa. I saggi di Debenedetti si trasformano in vere e proprie scommesse, non indenni da approssimazioni ed errori, che tengono d’occhio innanzitutto la linea d’orizzonte del «destino» dell’uomo europeo del Novecento, il suo immaginario e la sua coscienza. Debenedetti indaga la letteratura alla ricerca di un’illuminazione, ma questa ricerca è da intendersi come una vera e propria lotta, un corpo a corpo col testo, con l’autore e anche con se stesso: la critica perpetua il mito della lotta di Giacobbe conto l’angelo e non può nascere, veramente feconda, se non come dramma. La sua è innanzitutto una lezione di «stile» critico, di atteggiamento fondamentale. La radice profonda di una forma critica così intensa e coinvolgente da divenire una vera e propria «vocazione» bruciante, è ampiamente biblica. Occorre rileggere – e questa è la parte del suo magistero che mi affascina maggiormente, che è anche quella più acerba e brulicante – le sue cinque conferenze sui Profeti tenute nel 1924 in una sede legata alla Comunità ebraica di Torino. Qui si riconosce il Debenedetti che sceglie un cammino di lettura senza aver predisposto un itinerario, e soprattutto il critico che raggiunge la poesia partendo proprio dall’animo del poeta e non dall’asettica applicazione al testo degli strumenti della «scienza della letteratura». Di queste conferenze a noi restano una massa di appunti, raccolti in cartelle, che sono stati dati alle stampe nel 1998. Il giovane Debenedetti nella sua formazione acquisisce una sensibilità per il testo biblico che farà sentire i suoi echi fino alla fine del suo percorso di critico e di uomo. Il ritratto complessivo delle figure profetiche ne fa percepire tutta la visceralità: «Il loro dolore è un torrente di lava che strugge le montagne. La loro speranza, erompe ora come boato da terra convulsa, ed or mansueta sorride come l’arcobaleno che Iddio mandò a Noè dopo il diluvio, […]. La loro umanità non si manifesta per valori trattabili, bensì nel diapason, nell’esasperazione, nell’eccesso di ogni possibile sentimento umano». La riflessione sulle conferenze non è mancata negli anni che ci separano dalla loro pubblicazione in volume. Esse tuttavia sono state sostanzialmente esaminate in se stesse e ancora troppo poco in rapporto alla vicenda critica di Debenedetti. In quelle pagine manoscritte egli ha coniugato le sue radici ebraico-bibliche con gli elementi fondanti del suo metodo. Occorre riconoscere che la critica letteraria per Debenedetti ha un riferimento preciso, più o meno implicito, nell’esegesi ebraica, fondata sull’interrogazione del testo e sul commento. Il termine «esegesi» significa raccontare, esporre, interpretare un testo «traendone fuori» (exegèomai) il significato. Le letture di Debenedetti hanno proprio il gusto di un racconto esegetico che vale per il suo senso e per le relazioni che intesse tra elementi distanti. Qualche esempio: il profeta Amos, con la sua forza drammatica e scenica capace di sorprendere sempre la realtà in movimento, ha molti tratti simili a quelli che nel ‘40 Debenedetti attribuirà a Vittorio Alfieri. Nel caso del profeta Osea, che viene dipinto con gli stessi pennelli che più tardi Debenedetti userà per dipingere Umberto Saba, la profezia è «veduta in una biografia: l’autobiografia del profeta». Isaia è il modello «perfetto», se così si può dire, di profeta, quello dal quale Debenedetti appare maggiormente attratto, a tal punto da fargli affermare che «Forse nemmeno Dante, nelle più accese estasi del suo Paradiso, ha toccato un tal punto di umana grandezza». Ed è a proposito del linguaggio di Isaia che Debenedetti darà la definizione di metafora, che per il proprio linguaggio critico resterà sempre valida fino alla fine: «La metafora, non traveste, ma rinnova la realtà sotto luci che sono d’invenzione e di scoperta». Ancora a Isaia è attribuita la dote di poeta senza che egli abbia fatto nulla per volerla: «Egli appartiene a quella schiera di giganti per cui la poesia non è un consapevole e volontario sforzo d’arte, ma piuttosto una necessità del loro linguaggio, un altissimo valore interno delle parole che vogliono essere dette». A proposito del profeta Geremia è esplicitata, in una pagina memorabile, la tesi della «logica concessiva» della critica, opposta a qualunque «logica consecutiva» perché «La vita profonda sfugge, per quanto noi ne possiamo sapere, a tutti i rapporti che si possono preventivamente fissare». E, a titolo esemplificativo, segue l’accostamento di Geremia a Dostojevski. E più in generale, il modo in cui Debenedetti intende il rifiuto operato dai narratori del Novecento di una logica stringente di causa-effetto per aderire alla logica della probabilità ha già una anticipazione nella descrizione del passaggio nella storia biblica dal rapporto con l’Assoluto inteso come regolato dalla legge del dare-avere alla complessa e interiore legge scritta nel «cuore di carne». È anche da questa intuizione di origine profetica che sembra svilupparsi il modo di ritrarre la complessa figura del personaggio del romanzo novecentesco nella lettura debenedettiana. Ma gli esempi potrebbero moltiplicarsi. Qui c’è tutto il grande Debenedetti che sento vicino: padre, maestro, ma anche compagno. Se Debenedetti pochi anni prima della morte aveva scritto che fine della critica letteraria è «aprire l’ostrica», egli già quarant’anni prima aveva scritto che «I Profeti rompono la crosta e portano in luce la polla». Affrontare criticamente un testo letterario significa estrarre una perla dall’ostrica o far sgorgare l’acqua da una crosta di terra. Ma il frutto della conquista è sempre «possesso precario», mai accerchiamento definitivo. Modello di azione del critico letterario è dunque il profeta. Ecco il messaggio che sento per me e non solo per me urgente e bruciante per chiunque oggi intenda essere «critico» o anche lettore. … A quel tempo danzavano per le strade come pazzi, e io li seguivo a fatica come ho fatto tutta la vita con le persone che mi interessano, perché le uniche persone che esistono per me sono i pazzi, i pazzi di voglia di vivere, di parole, di salvezza, i pazzi del tutto e subito, quelli che non sbadigliano mai e non dicono mai banalità ma bruciano, bruciano, bruciano come favolosi fuochi d’artificio gialli che esplodono simili a ragni sopra le stelle e nel mezzo si vede scoppiare la luce azzurra e tutti fanno “Ooooh!”.
… A quel tempo danzavano per le strade come pazzi, e io li seguivo a fatica come ho fatto tutta la vita con le persone che mi interessano, perché le uniche persone che esistono per me sono i pazzi, i pazzi di voglia di vivere, di parole, di salvezza, i pazzi del tutto e subito, quelli che non sbadigliano mai e non dicono mai banalità ma bruciano, bruciano, bruciano come favolosi fuochi d’artificio gialli che esplodono simili a ragni sopra le stelle e nel mezzo si vede scoppiare la luce azzurra e tutti fanno “Ooooh!”.