Io non faccio “letteratura”. La mia vita, la nostra vita, quella di mia moglie e di mio figlio Eric, che adesso ha sei anni e mezzo, è stata davvero sconvolta dai Signori Tedeschi, che sono rimasti proprio gli stessi.
 Così scriveva Paul Celan in una lettera del 19 gennaio 1963. In quest’affermazione c’è tutta la specificità della poesia celaniana.
Così scriveva Paul Celan in una lettera del 19 gennaio 1963. In quest’affermazione c’è tutta la specificità della poesia celaniana.
Specificità con cui si sono confrontati grandi maestri del pensiero come Adorno, Heidegger, Gadamer, Levinas e Derrida. Dietro ogni confronto è palpabile la volontà di accogliere quel dono insito nella poesia-soglia di Paul Celan.
Poesia-soglia: soglia tra memoria e dimenticanza, soglia in cui si rende possibile l’incontro con la testimonianza del “maggior poeta europeo del periodo successivo al 1945″. È un incontro voluto e cercato, incontro-confronto anche con la concezione che dell’arte ha Celan. Quest’incontro poteva avvenire soltanto nello spazio del Gedicht, la parola che il poeta ha cercato INFONDOALLANEVE. Lì, tra i “sassi muti” da conquistare per tracciare un percorso che, sin d’ora, ci impegniamo a riprendere e continuare.
L’intima coesione che caratterizza l’opera di Paul Celan, ravvisabile nell’unità tematica che collega le prove giovanili della Sabbia dalle urne alle ultime, criptiche e postume di Parte di neve, ci autorizza in virtù del principio ermeneutico della circolarità tra le parti e il tutto a cercare nel corpus poetico un punto attraverso cui guadagnare l’inizio. Abbiamo scelto di “attraversare” la soglia delle ventuno poesie del ciclo ATEMKRISTALL, uno dei risultati più notevoli di tutta l’opera celaniana.
Sulla scia di quella “possibilità condizionale di partecipazione intellettuale-emotiva” che caratterizza ogni approccio interpretativo, premettiamo sin da queste primissime righe che abbracciamo l’interpretazione che del ciclo ha dato Giuseppe Bevilacqua, storica “voce italiana” di Paul Celan.
Nel farlo, terremo presente anche la monografia che Hans Georg Gadamer ha dedicato al ciclo ATEMKRISTALL, sottolineando però come il grande ermeneuta, trincerandosi dietro la sua concezione a-metodica della verità, riesca a dare quanto meno “personalissime” interpretazioni di alcune poesie del ciclo.
Tra le molteplici differenze d’approccio degli interpreti con cui continuamente ci confronteremo, c’è almeno un vistoso punto di contatto. Esso riguarda la primissima sensazione che accomuna i lettori di Celan. Le poesie di Celan (spesso) sembrano impenetrabili, soprattutto quelle dell’ultimo periodo.
Dinnanzi alla complessità di alcune metafore celaniane il lettore ha la sensazione di doversi confrontare con le kenningar degli antichi Germani. Più che leggere, si cozza contro il testo, un testo che, per usare un espressione del ciclo, sembra quasi prenderci a cornate. A tal proposito Giuseppe Bevilacqua ha parlato di un azzardo che di necessità accompagna ogni lettura: “chi vuole interpretare la poesia di Celan deve abituarsi al rischio”.
Gadamer è riuscito a condensare le sensazioni connesse a questa principale difficoltà in quella che suona come una sentenza non appellabile: “le poesie di Celan ci raggiungono, ma noi non riusciamo a coglierle”.
Consci di questo rischio sempre latente, nell’accostarci all’intima unità del ciclo, cercheremo soprattutto la centralità e la ricorrenza del tema della “testimonianza” che sta lì ad aspettare nel favo di ghiaccio. Sta lì, rinchiusa nel cristallo di respiro. Messa da parte l’arte-sabbia delle prove giovanili, tutta la parabola umana e poetica di Celan coincide nel costante sforzo verso questo ATEMKRISTALL. In questo conato la sua poesia accantona la sua natura di nullapoesia, tende a diventare parola di luna. L’io del ciclo deve scivolare in fondo alla neve, solo lì può rispondere alla sfida lanciata dal celeberrimo monito adorniano sulle possibilità della Poesia nel dopo-Auschwitz. Il poeta si gioca la vita in questa sfida. Conosciamo già il tragico epilogo: Celan ha scelto infine il silenzio in fondo allo scorrere della Senna.
Il nostro percorso si articolerà in sei capitoli. Partiremo da un appunto biobibliografico in cui cercheremo di sottolineare gli snodi fondamentali della vita del poeta. Un unico filo, dall’infanzia tra gli alberi di gelso di Czernowitz al ponte Mirabeau.
Nel primo capitolo la nostra attenzione sarà focalizzata soprattutto sull’infanzia di Celan e sul suo rapporto con i genitori. Nello sviluppo della sua poesia e della sua poetica, la madre e soprattutto la lingua della madre, il tedesco, rimarranno centrali. Cercheremo appigli tra i versi del “ciclo della testimonianza” e quelli della prima fase, l’arte-sabbia, combattuta tra la necessità di coltivare la memoria e la dolce pace del papavero.
Il secondo capitolo ruoterà intorno a una data: il 20 gennaio. Il 20 gennaio del 1942 fu presa la decisione della “soluzione finale”.
Il terzo capitolo rappresenta il fulcro del nostro lavoro, analizzeremo puntualmente i ventuno componimenti del ciclo ATEMKRISTALL (confluito poi nella raccolta ATEMWENDE del 1967). Nel farlo, come abbiamo già detto, ci lasceremo guidare dalla meritoria analisi di Bevilacqua.
Per il quarto capitolo ci baseremo sui brevi e pregiatissimi appunti di poetica del nostro poeta. Esamineremo con particolare attenzione tre figure chiave: il messaggio nella bottiglia, la stretta di mano e il Meridiano. Li accomuna l’apertura all’Altro, tema centralissimo nella riflessione poetologica celaniana.
L’identità ebraica del poeta sarà il tema conduttore del quinto capitolo, cercheremo di coglierla nel fitto dialogo che s’instaura tra la poesia di Celan ed alcuni suoi illustri referenti: Kafka, Adorno, Benjamin, Nelly Sachs e, soprattutto, il poeta Osip Mandelstamm.
Concluderemo spiegando il titolo di questo nostro lavoro: “neve e silenzio”. Nel farlo, “rischieremo” confrontandoci con il delicatissimo e importantissimo rapporto tra Celan e la lingua materna.
Leggi la mia tesi di laurea (pdf, 560 Kb): Neve e silenzio. Paul Celan verso un’estetica della testimonianza, Palermo, 2004 – Relatore Salvatore Tedesco
 La poesia «è il mio lavoro, il mio campo e, credo, la mia vocazione: il canale primario da cui attingo (o ricevo) ogni senso delle cose ultime». E ancora: «la poesia rende vere le cose, rinnovandone la vita e la percezione che abbiamo di esse». Già da queste battute si comprende come non bisogna lasciarsi sfuggire il volume che le contiene: Lettere dalla Beozia, una raccolta di saggi di Les Murray, australiano, uno dei più grandi poeti viventi, autore del romanzo in versi Freddy Nettuno (Giano, 2004) e di numerose raccolte, dalle quali Adelphi ha tratto l’antologia Un arcobaleno perfettamente normale.
La poesia «è il mio lavoro, il mio campo e, credo, la mia vocazione: il canale primario da cui attingo (o ricevo) ogni senso delle cose ultime». E ancora: «la poesia rende vere le cose, rinnovandone la vita e la percezione che abbiamo di esse». Già da queste battute si comprende come non bisogna lasciarsi sfuggire il volume che le contiene: Lettere dalla Beozia, una raccolta di saggi di Les Murray, australiano, uno dei più grandi poeti viventi, autore del romanzo in versi Freddy Nettuno (Giano, 2004) e di numerose raccolte, dalle quali Adelphi ha tratto l’antologia Un arcobaleno perfettamente normale.
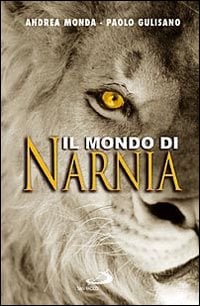 E così giovedì scorso, con un po’ di trepidazione, ho partecipato anch’io alla giornata e alla visione del film scelto per quest’anno e che sono stato invitato a presentare: Le cronache di Narnia tratto dall’omonima saga fantasy dello scrittore inglese C.S.Lewis. Mi sembra una scelta significativa, per questo ve ne parlo. L’invito era giustificato da un recente saggio sullo scrittore e il suo bestseller, da me realizzato insieme a Paolo Gulisano, per le edizioni SanPaolo, mentre la trepidazione era dovuta alla speranza di avere, tra il pubblico, Benedetto XVI. La speranza è rimasta delusa, la folla era numerosa e anche ricca di cardinali (ne ho contati almeno quattro: Lopez Rodriguez, Vlk, Agrè e Backis) vescovi e prelati, ma lui non c’era e non solo a causa della pioggia: forse non era il film adatto ad un Papa, non perché distante dalle sue sensibilità ma, al contrario, perché troppo vicino. Il Papa, questo Papa, non aveva bisogno di vederlo. Il cardinale Ratzinger infatti è stato in passato un ammiratore di Lewis e mi sono sorpreso io stesso del fatto di essermi trovato quasi costretto, nelle poche parole introduttive, a citare per due volte l’enciclica Deus Caritas est. Quando il Papa afferma che quello di cui l’uomo ha bisogno è “un cuore che vede” (n.31) coglie una delle profonde “morali” della bella favola raccontata da Lewis.
E così giovedì scorso, con un po’ di trepidazione, ho partecipato anch’io alla giornata e alla visione del film scelto per quest’anno e che sono stato invitato a presentare: Le cronache di Narnia tratto dall’omonima saga fantasy dello scrittore inglese C.S.Lewis. Mi sembra una scelta significativa, per questo ve ne parlo. L’invito era giustificato da un recente saggio sullo scrittore e il suo bestseller, da me realizzato insieme a Paolo Gulisano, per le edizioni SanPaolo, mentre la trepidazione era dovuta alla speranza di avere, tra il pubblico, Benedetto XVI. La speranza è rimasta delusa, la folla era numerosa e anche ricca di cardinali (ne ho contati almeno quattro: Lopez Rodriguez, Vlk, Agrè e Backis) vescovi e prelati, ma lui non c’era e non solo a causa della pioggia: forse non era il film adatto ad un Papa, non perché distante dalle sue sensibilità ma, al contrario, perché troppo vicino. Il Papa, questo Papa, non aveva bisogno di vederlo. Il cardinale Ratzinger infatti è stato in passato un ammiratore di Lewis e mi sono sorpreso io stesso del fatto di essermi trovato quasi costretto, nelle poche parole introduttive, a citare per due volte l’enciclica Deus Caritas est. Quando il Papa afferma che quello di cui l’uomo ha bisogno è “un cuore che vede” (n.31) coglie una delle profonde “morali” della bella favola raccontata da Lewis.  Il nuovo numero della rivista di BombaCarta è on-line. Buona Lettura. In questo nuovo numero c’è anche BombaBimbo, una rubrica per i più piccoli fatta dai loro coetanei e illustrata da Marcello Previtali.
Il nuovo numero della rivista di BombaCarta è on-line. Buona Lettura. In questo nuovo numero c’è anche BombaBimbo, una rubrica per i più piccoli fatta dai loro coetanei e illustrata da Marcello Previtali. Così scriveva Paul Celan in una lettera del 19 gennaio 1963. In quest’affermazione c’è tutta la specificità della poesia celaniana.
Così scriveva Paul Celan in una lettera del 19 gennaio 1963. In quest’affermazione c’è tutta la specificità della poesia celaniana.