La città e l’identità: “Napoli Ferrovia” di Ermanno Rea

Ermanno Rea
Rea ha accesso a un mondo, grazie alla presenza di Caracas. Caracas può incontrare un passato che non ha mai conosciuto grazie a Rea. I due camminano. Parlano. Raccontano. Si raccontano. Bevono thè. Non senza attriti. Caracas ha un dono: l’ascolto, la devozione nell’ascoltare. Scrive Rea:
“l’attenzione alle parole altrui, se non è una virtù cardinale, le assomiglia parecchio. Ma la devozione è molto di più, la partecipazione appassionata, l’immedesimazione sono qualità, anzi predisposizioni di cui soltanto pochi sono capaci e che non hanno mai mancato di suscitare in me, le rare volte che ne sono stato gratificato, ammirato stupore.”
I due si concentrano su quel micro-macro cosmo che è la Ferrovia, vera porta di accesso alla città da quando Napoli è stata “amputata” del suo mare. La percorrono, instancabilmente. Se ne allontanano e vi ritornano. La scoprono nel suo volto indaffarato, quello ordinario, fitto di partenze e transiti. E quello nudo, domenicale, quando i napoletani si ritirano da quello spicchio di città e a presidiare la piazza rimangono solo i “nuovi” napoletani, quelli adottivi, quelli che in qualche modo restituiscono a Napoli la sua vocazione: “Questa – scrive Rea – è una città-spugna, capace di apporre il proprio sigillo su ogni importazione, di ridurre alla propria misura chiunque la scelga per casa; questa è una città che inghiotte, metabolizza fingendo di farsi essa stessa straniera via via che integra lo straniero, lo divora. Perciò la mia piazza di oggi non è troppo dissimile da quella di ieri, perfino le voci si rassomigliano, e può accadere anche che il nigeriano gridi al nigeriano – “ma tu che cazzo vvuò?” – con una inflessione di parlata, una voce, come provenisse diretta dalle viscere della città”.Romanzo, cronaca, inchiesta, diario, toponomastica, immaginario: “Napoli ferrovia” è tutto questo, gioco di specchi tra il presente e il passato, tra la Napoli che si offre oggi, sfatta e ancora bellissima, abusata e sfrontata, e quella che emerge dal passato, la Napoli ancora sospesa in una rete di aspettative, prima che si consumasse il tradimento perpetuato ai suoi danni. Perché Napoli – è la tesi ricorrente nei libri dello scrittore napoletano – ha subito un’amputazione, un “sequestro”, nelle parole di Rea. È la Napoli che già erompeva nelle pagine di Mistero Napoletano (1995), altro romanzo-cronaca-diario tutto incentrato su quel sortilegio che ha attanagliato la città nel dopoguerra. Come è potuto accadere che, a un certo punto della sua storia, le menti migliori della città abbiano scelto di uccidersi? Quale disperazione “comune” ha spinto lo scrittore Luigi Incoronato, il matematico Renato Caccioppoli, la giornalista Francesca a uccidersi? Quale assottigliamento della speranza, quale restringersi della capacità-possibilità di incidere sulla realtà della città? Quale impotenza? Cosa ha spinto quelle menti a scegliere la (o lasciarsi scegliere dalla) defezione, la resa? Qui la scrittura di Rea si fa requisitoria, arringa. Non solo Napoli fu spogliata del suo porto e della sua vocazione industriale e mercantile per ospitare il Quartiere generale della Nato, trasformandosi “nel più grande porto militare d’Europa offrendosi come il maggior contributo italiano al sistema difensivo atlantico. Rinunciando così al suo stesso sviluppo. Anzi, a ogni futuro possibile. In compenso, tutto il Mediterraneo ai suoi piedi: ma non come mare di pace, come mare di guerra”. Ma al ripiegamento della città su se stessa, contribuì in maniera determinante – è la tesi dello scrittore – anche il partito comunista che raccolse quelle inquietudini ma allo stesso tempo mise in piedi una spietata macchina inquisitoriale che finì per spegnere, prosciugare aneliti e stendere – sugli spiriti più inquieti della città – una cappa di mortifero silenzio. Una “dismissione”, per citare un altro libro di Rea (La dismissione, 2002), che inghiottì non solo Bagnoli e la sua acciaieria (l’Ilva di Bagnoli) ma l’intero destino della città. Una “dismissione” che è metafora neanche troppo velata dello “smontaggio” che fu inflitto a Napoli, tanto più doloroso perché ebbe come apogeo proprio quell’acciaieria che era assurta a simbolo di un’altra città. “Noi amavamo Bagnoli – dice uno dei personaggi di La dismissione -. Perché rappresentava mille cose insieme ma, prima di tutto, perché incarnava ai nostri occhi una salutare contro-copertina della città. Una contro-copertina che trasformava in alacrità l’indolenza, in precisione l’approssimazione, in razionalità l’irragionevolezza, in ordine il caos, in rigore la rilassatezza. L’amavamo perché introduceva in una città inquinata – la Napoli della guerra fredda, dell’abusivismo selvaggio, del contrabbando – valori inusuali: la solidarietà; l’orgoglio di chi si guadagna la vita esponendo ogni giorno il proprio torace alle temperature dell’altoforno; l’etica del lavoro; il senso della legalità…”.C’è una virtù (o una maledizione?), un’attitudine, che accomuna, che ritorna, come una sorta di sigillo, nei personaggi (ma è meglio dire nelle persone) che Rea interroga, ascolta, trascrive nei suoi libri. Quella virtù ha un nome: ostinazione. Una sorta di irriducibile resistenza, di fiera passività, di attaccamento e fedeltà morali, pagate a caro prezzo. Qualcosa che ha due facce, se è vero che essa – quell’ostinazione, quella dirittura – può farsi estrema, avere estreme conseguenze. Farsi scelta radicale: quella della sparizione, come nel caso dell’economista Federico Caffè (e raccontata da Rea in “L’ultima lezione. La solitudine di Federico Caffè scomparso e mai più ritrovato”). L’ostinazione può essre insomma una virtù tragica: “Con la volontà si tende in generale a costruire; essa è progetto, e in quanto tale conosce e pratica le arti della duttilità. La volontà è una virtù rampante. L’ostinazione invece è difesa a oltranza di qualcosa. Generalmente di principi: non conosce perciò compromessi. Per l’ostinato la vita è una trincea da non abbandonare a nessun costo; è rifiuto. Anzi, è il rifiuto elevato a paradigma esistenziale, a ricerca di una possibile bellezza del mondo al di là delle degradate forme in cui tende a cristallizzarlo il potere. Qualunque forma di potere”.
“Ormai tutta la vecchia ossatura industriale napoletana era in via di smantellamento: avevano soltanto l’imbarazzo della scelta. Nella sola zona flegrea l’elenco delle fabbriche-non-più-fabbriche faceva spavento: Cementir, Montedison, Olivetti, Pirelli-cavi, Cantieri Navali di Baia, Novopan, Ferriere di Agnano. Senza contare le decine di ditte private che svolgevano lavori di manutenzione speciale degli impianti all’interno dell’Ilva. Poi c’erano le fabbriche della zona orientale: la Corradini, le Cotoniere meridionali, la Manifattura tabacchi, il polo petrolchimico…” (La dismissione, p.158).

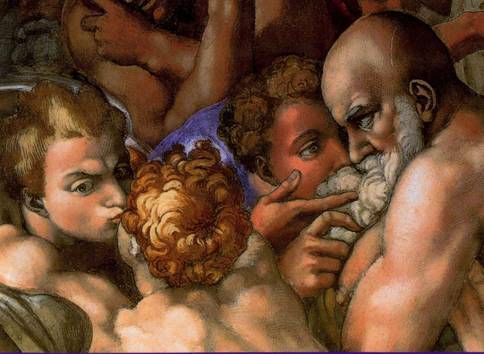
 La recente scomparsa di Julien Gracq, scrittore francese che ha attraversato tutto il Novecento (essendo nato nel 1910) e che l’ha punteggiato con i suoi 19 libri, pubblicati senza grandi tirature per lettori colti, induce a riconsiderare l’opera di questo narratore, poeta, saggista e memorialista, discreto e riservato, ritiratosi da molti anni a vivere nel suo villaggio natale, estraneo per scelta al mondo letterario della capitale, anche se le sue opere compaiono nel catalogo di Gallimard. Tentato in gioventù dall’impegno politico in area comunista, passato poi attraverso il coinvolgimento della guerra e l’esperienza della prigionia, si è in seguito dedicato in maniera esclusiva (oltre al lavoro di insegnante in un liceo di Parigi) alla produzione letteraria, nella convinzione che il linguaggio è lo strumento che permette di comunicare con il mondo e di conoscerlo misticamente. La sua stagione narrativa prende le mosse dal surrealismo, dominante al momento del suo esordio con Al castello d’Argol (1938), per accentuare nel dopoguerra la sua grande originalità, poetica, simbolica e metafisica in una narrazione che sempre più si arricchisce di intensi riferimenti culturali estranei alle ideologie dominanti.
La recente scomparsa di Julien Gracq, scrittore francese che ha attraversato tutto il Novecento (essendo nato nel 1910) e che l’ha punteggiato con i suoi 19 libri, pubblicati senza grandi tirature per lettori colti, induce a riconsiderare l’opera di questo narratore, poeta, saggista e memorialista, discreto e riservato, ritiratosi da molti anni a vivere nel suo villaggio natale, estraneo per scelta al mondo letterario della capitale, anche se le sue opere compaiono nel catalogo di Gallimard. Tentato in gioventù dall’impegno politico in area comunista, passato poi attraverso il coinvolgimento della guerra e l’esperienza della prigionia, si è in seguito dedicato in maniera esclusiva (oltre al lavoro di insegnante in un liceo di Parigi) alla produzione letteraria, nella convinzione che il linguaggio è lo strumento che permette di comunicare con il mondo e di conoscerlo misticamente. La sua stagione narrativa prende le mosse dal surrealismo, dominante al momento del suo esordio con Al castello d’Argol (1938), per accentuare nel dopoguerra la sua grande originalità, poetica, simbolica e metafisica in una narrazione che sempre più si arricchisce di intensi riferimenti culturali estranei alle ideologie dominanti. Alessandro Di Nocera è autore di un bel libro (e originalissimo nella grafica) sul mondo del fumetto americano “Supereroi e superpoteri. Miti fantastici e immaginario americano dalla guerra fredda al nuovo disordine mondiale” (Castelvecchi). Alessandro ha risposto ad alcune domane sull’universo del fumetto Usa.
Alessandro Di Nocera è autore di un bel libro (e originalissimo nella grafica) sul mondo del fumetto americano “Supereroi e superpoteri. Miti fantastici e immaginario americano dalla guerra fredda al nuovo disordine mondiale” (Castelvecchi). Alessandro ha risposto ad alcune domane sull’universo del fumetto Usa.
