Per capire la «Commedia» bisogna entrare in quel mondo fatto di realtà e visioni; Il fiorentino continuamente reinventato come lingua vera e propria, Il torrente vivo delle terzine lo porta a nuove scoperte di intonazioni. I versi dell’ Alighieri nell’ analisi di un grande poeta. Che spiega come cogliere lo spirito di un’ opera giunta a noi attraverso centinaia di trascrizioni.
 “1. Ma di quale testo di Dante parliamo? Come arrivare al vero testo attraverso centinaia di trascrizioni, se non c’è nemmeno un autografo del nostro massimo poeta? Una specie di scommessa diventa necessaria. Ma occorrono anche fonde rettifiche alla nostra percezione del suo mondo, dell’epoca che egli rappresenta. Quando ci si accosta a Dante, infatti, diventa necessario un coinvolgimento nel clima di visionarietà in cui allora si era immersi. Il passaggio dall’immagine «reale», al sogno, alla «visione» – nel senso di comunicazione con un altrove – non presentava particolari soluzioni di continuità. Esiste anche oggi, a macchie, un simile clima; penso per esempio al caso di quel distretto del nostro Sud in cui per molti anni «tutti» vedevano «qualcosa» (l’antropologo Paolo Apolito ne ha dato ampia relazione). E ovviamente ci si dovrà soffermare sul fatto che il mondo degli Evangeli è tutto inserito entro il contesto di un dramma cosmico di lotte: una concezione, questa, che attraversa i secoli per arrivare fino a Milton, a Goethe, (per non dire a Bulgakov…). Tommaso d’Aquino, immagine stessa di un realismo razionalistico di base aristotelica, ha una famosa visione in cui Cristo loda quanto il filosofo ha saputo dire di lui («Bene dixisti de me, Thoma»).
“1. Ma di quale testo di Dante parliamo? Come arrivare al vero testo attraverso centinaia di trascrizioni, se non c’è nemmeno un autografo del nostro massimo poeta? Una specie di scommessa diventa necessaria. Ma occorrono anche fonde rettifiche alla nostra percezione del suo mondo, dell’epoca che egli rappresenta. Quando ci si accosta a Dante, infatti, diventa necessario un coinvolgimento nel clima di visionarietà in cui allora si era immersi. Il passaggio dall’immagine «reale», al sogno, alla «visione» – nel senso di comunicazione con un altrove – non presentava particolari soluzioni di continuità. Esiste anche oggi, a macchie, un simile clima; penso per esempio al caso di quel distretto del nostro Sud in cui per molti anni «tutti» vedevano «qualcosa» (l’antropologo Paolo Apolito ne ha dato ampia relazione). E ovviamente ci si dovrà soffermare sul fatto che il mondo degli Evangeli è tutto inserito entro il contesto di un dramma cosmico di lotte: una concezione, questa, che attraversa i secoli per arrivare fino a Milton, a Goethe, (per non dire a Bulgakov…). Tommaso d’Aquino, immagine stessa di un realismo razionalistico di base aristotelica, ha una famosa visione in cui Cristo loda quanto il filosofo ha saputo dire di lui («Bene dixisti de me, Thoma»).
Del resto, lo stesso Innocenzo III autorizzò oralmente l’Ordine di Francesco in seguito a un celebre sogno. E una vena mistica, sempre più potente, pervadeva l’animo dello stesso Dante. Ma l’incontrastata forza di tale clima visionario, eccettuate naturalmente numerose e ben note reazioni opposte, crea una condizione generale di apertura al sentimento che «i morti non sono morti», sono tra noi, sono vivi. Nessuno poteva essere pensato come annichilito del tutto, al contrario di quanto accade nel mondo attuale, in cui pure chi non è escluso «in quanto memoria» può da un momento all’altro cadere nell’oblio. Chiara Frugoni ha indagato con intrepidità particolare l’alta e caratterizzata realtà di San Francesco in questo quadro, in cui si svilupparono le sue esperienze al limite, in un insieme di contrastanti sfumature.
2. Quando si dice memoria, poi, si rientra in un campo importantissimo: nel passato, persino i sussidi segnici delle scritture, deprecati fin da quando venne sospettato e talora condannato il dono del dio Teuth, si vedevano come «macchine obliteratrici» della ginnastica mentale. Oggi, al contrario, sembriamo rassegnati alla mineralizzazione della memoria nei banchi informatici, potenzialmente vasti come lo scibile che è in aumento geometrico. Ma da quando i bardi erano famosi per l’obbligatorio apprendimento mnemonico di interi poemi (si parla di tremendi esami, anche in situazioni fisiche difficilissime, per i Druidi) – dalle lontananze di un’«oralità perpetua» soprattutto riguardante la poesia e, secondo alcuni, trasmessa su un arco di almeno sessantamila anni – si viveva entro atmosfere costituite su «bolle» più o meno stabili di memorie disomogenee. E qui Dante brilla sovranamente: in una società in cui pochi avevano accesso alla materialità degli scritti, infatti, egli era già entrato nell’animo popolare, e i frammenti più semplici del suo poema erano ovunque spontaneamente recitati: egli stesso era ammirato per la sua portentosa memoria. Di questo suo «atletismo mentale» egli ci dà testimonianza per bocca di Virgilio, che riferendosi all’ Eneide , dice a Dante «ben lo sai tu, che la sai tutta quanta» ( Inf. XX, 114).
Questa memoria, che tiene viva e presente un’enorme tastiera di significati e significanti, è quella stessa forza che, nell’atto creativo, mette a disposizione una quantità eccezionale di mezzi espressivi già in «allarme». Ciò ben risulta da una nota testimonianza di uno dei più antichi commentatori, l’«Ottimo», secondo la quale Dante, pur affermando che se il torrente vivo delle terzine, con il ritorno delle rime, lo porta a nuove scoperte di intonazioni e immagini, e quasi lo costringe di continuo ad inventare, egli, comunque, non si discosta dai concetti fondamentali che la sua mente vuol proporre. Questo incredibile intreccio di energie, tutte «prepotenti», riesce a prevalere, relegando in disparte il lavoro teorico di opere come il Convivio e il De Vulgari Eloquentia , o altri suggestivi gruppi di versi e apre la strada al poema sacro «al quale ha posto mano e cielo e terra» ( Par. XXV, 2).
In ciò si rende visibile l’affermazione sempre più netta della necessità del fiorentino parlato e continuamente reinventato come lingua vera e degna della poesia, e proprio per la poesia di Dante. Egli incontrava così anche la traccia della «pantera profumata» ( panthera redolens , nel De vulgari Eloquentia ), che non si rinveniva in nessuna delle lingue o dialetti da lui presi in esame, pur tutti sfiorandoli. Si sapeva che egli acconsentiva al destino toscano della poesia che era già in atto ai suoi tempi, ma doveva difendersi, persino nei tardi anni ravennati, dalle accuse amichevoli di Giovanni del Virgilio relative al suo abbandono della lingua degli antichi padri (sempre viva nelle classi dotte). Dante non vuole e non può staccarsi dal volgare, già illustre eppure vicino al popolo, nella sua umile ma irrefrenabile fioritura, pensa alle donnette che lo parlano e lo «attestano». E capita qui di ricordare Lutero che, nella traduzione in tedesco della Bibbia, riconosceva di abbandonare una lingua sacralmente insuperabile, come l’ebraico, per favorire appunto le «mulierculae», il vissuto popolare-reale.
3. Madri, umiltà, bambini, tracce della «pantera» al momento adamitico delle lingue, fino all’inevitato, per Dante, contraddirsi tra certe sue affermazioni teoriche e la definitiva realtà del «risucchio» della Commedia che abiterà tutta nell’amore e nelle sue diversità. Il grande amore nasce per Dante «prima ch’io fuor di puerizia fosse» ( Purg. , XXX, 42): Beatrice è una bambina e tra lei e Dante, anche nel trascorrere degli anni prima della sua precocissima fine, prende forma la tormentata innocenza di un fatto sostanzialmente immaginario, (che a noi potrebbe ricordare il mito del «vert paradis des amours infantines» di Baudelaire). Il fantasma iniziale di Beatrice si trasforma lungo tutto l’itinerario letterario di Dante per dissolversi nell’ultimo sorriso in Par. XXXI, 91-93, generando un senso di sottile e misteriosa frustrazione («quella, sì lontana / come parea, sorrise e riguardommi; / poi si tornò a l’etterna fontana»). E lungo il poema l’attenzione a fatti, anche linguistici, di valore aurorale, continuerà ad apparire; basti pensare al «pappo e ’l dindi» delle prime sillabazioni ( Purg. , XI, 105), e al ricorrere, per ricordare l’impotenza umana a dire la realtà suprema, a numerose variazioni sul tema del «fante / che bagni ancor la lingua a la mammella» ( Par. , XXXIII, 107-108). E’ il caso del «fantolin che ’nver’ la mamma / tende le braccia, poi che ’l latte prese, / per l’animo che ’nfin di fuor s’infiamma» ( Par. , XXIII, 121-123); o, ancora, del conclamato atto di fiducia nell’infanzia ( Par. , XXVII, 127-136): «Fede e innocenza son reperte / solo ne’ parvoletti; poi ciascuna / pria fugge che le guance sian coperte. / Tale, balbuziendo ancor, digiuna, / che poi divora, con la lingua sciolta, / qualunque cibo per qualunque luna; / e tal, balbuziendo, ama e ascolta / la madre sua, che, con loquela intera, / disia poi di vederla sepolta». E traspare nel poeta un’ombra di non superata angoscia per il destino dei bambini incolpevoli ( Par. XXXII).
4. Ma per capire ciò che si verifica in quelli che si potrebbero chiamare display tipici della poesia, basterà dar rilievo ad alcuni frammenti danteschi – fermo restando che è sempre augurabile la lettura dell’intero poema, l’avvicinamento al suo «romanzo» integrale. Le increspature di emergenze altamente significative sono per altro tali e tante entro l’onda delle terzine, di loro gruppi, che degli esempi vanno evidenziati anche qui. Vi si rinviene infatti una specie di lingua totale e atemporale della poesia che si pone al «sommo» dell’espressione. Un massimo di figure retoriche signatae , già classificate, si fonde a una particolare innovazione «acrobatica» – a un «andar per sommi», cioè, nel realizzare la perfetta sincronia di musica mentale, intelligibilis (analogica?), e onda fonico-ritmica. È ciò che Dante stesso chiama «legame musaico», il tout se tient della poesia, piano autonomo voluto dalla Musa, e di tale coesione che «nulla cosa per legame musaico armonizzata si può de la sua loquela in altra trasmutare sanza rompere tutta sua dolcezza e armonia» ( Conv. , I, 7).
Si dia un’occhiata a Inferno , XVII, vv. 55-63. E’ l’incontro con gli usurai, anzi, con le borse che recano i loro stemmi di ricconi mai abbastanza avidi, cui si riduce il loro stesso volto: «dal collo a ciascun pendea una tasca / ch’avea certo colore e certo segno, / e quindi par che ’l loro occhio si pasca. / E com’io riguardando tra lor vegno, / in una borsa gialla vidi azzurro / che d’un leone avea faccia e contegno. / Poi, procedendo di mio sguardo il curro, / vidine un’altra come sangue rossa, / mostrando un’oca bianca più che burro». E la rassegna continua. La personificazione dell’azzurro, che diventa sostantivo e che agisce attraverso l’idea di leone, la si potrebbe ritrovare nei surrealisti, e ha un potere quasi ipnotico sullo sguardo di Dante, lo trascina come uno stridulo, pesante carro a vedere l’altra borsa il cui peso si moltiplica nel bianco lurido di un’oca su un fondo sanguinante. L’accostamento sangue e burro provoca quasi un senso di nausea, introduce in un mondo quasi di fisica perversione. Al polo opposto, nel XXXIII del Paradiso , vv. 124-126, ecco un improvviso lampo che mira a esprimere la totalità del divino e dell’essere come luce, in una serie di parallelismi perfetti e insieme irraggianti tutt’intorno alla perentorietà delle dentali sorde e sonore (/d/, /t/) e di certe vocali (/i/, /e/), mentre la sintassi crea una piena circolarità – e il poeta sembra quasi tremare in questa pronuncia dell’impossibile-possibile: «O luce etterna che sola in te sidi, / sola t’intendi, e da te intelletta / e intendente te ami e arridi!». Siamo di fronte a qualcosa di pienamente incentrato sulla teologia trinitaria ma che nello stesso tempo ne fuoresce, sfreccia, si sfa appunto in una specie di raggiera di tintinnii e dilatazioni foniche. Forse qualche cosa che a noi può ricordare la musica di Lajos Ligeti ( Lux Aeterna ) che si accompagna in un famoso e già lontano film all’enigmatica stele, o tavola di legge chiave del cosmo. Pare che Dante qui trascinato da una forza abissalmente autonoma della Musa arrivi attraverso la poesia sulla teologia a una «teologia della poesia» percepita come autonomia di un dire che si autotrascende, al di la di realtà e mito, in una perenne apertura sul possibile.”
(dal Corriere della Sera del 20 settembre 2004)
 Mi trovavo in Romania per un convegno internazionale e, durante un giorno di riposo, due professori della locale Università stavano guidando tre di noi in un giro turistico per Sibiu e Sighisoara. Eravamo: una collega australiana, un collega spagnolo e un italiano, il sottoscritto. Una bella gita, davvero. Passeggiando con la collega australiana parlavo, e non mi ricordo bene perchè, delle radici, così siamo passati a parlare delle nostre radici.
Mi trovavo in Romania per un convegno internazionale e, durante un giorno di riposo, due professori della locale Università stavano guidando tre di noi in un giro turistico per Sibiu e Sighisoara. Eravamo: una collega australiana, un collega spagnolo e un italiano, il sottoscritto. Una bella gita, davvero. Passeggiando con la collega australiana parlavo, e non mi ricordo bene perchè, delle radici, così siamo passati a parlare delle nostre radici.
 “1. Ma di quale testo di Dante parliamo? Come arrivare al vero testo attraverso centinaia di trascrizioni, se non c’è nemmeno un autografo del nostro massimo poeta? Una specie di scommessa diventa necessaria. Ma occorrono anche fonde rettifiche alla nostra percezione del suo mondo, dell’epoca che egli rappresenta. Quando ci si accosta a Dante, infatti, diventa necessario un coinvolgimento nel clima di visionarietà in cui allora si era immersi. Il passaggio dall’immagine «reale», al sogno, alla «visione» – nel senso di comunicazione con un altrove – non presentava particolari soluzioni di continuità. Esiste anche oggi, a macchie, un simile clima; penso per esempio al caso di quel distretto del nostro Sud in cui per molti anni «tutti» vedevano «qualcosa» (l’antropologo Paolo Apolito ne ha dato ampia relazione). E ovviamente ci si dovrà soffermare sul fatto che il mondo degli Evangeli è tutto inserito entro il contesto di un dramma cosmico di lotte: una concezione, questa, che attraversa i secoli per arrivare fino a Milton, a Goethe, (per non dire a Bulgakov…). Tommaso d’Aquino, immagine stessa di un realismo razionalistico di base aristotelica, ha una famosa visione in cui Cristo loda quanto il filosofo ha saputo dire di lui («Bene dixisti de me, Thoma»).
“1. Ma di quale testo di Dante parliamo? Come arrivare al vero testo attraverso centinaia di trascrizioni, se non c’è nemmeno un autografo del nostro massimo poeta? Una specie di scommessa diventa necessaria. Ma occorrono anche fonde rettifiche alla nostra percezione del suo mondo, dell’epoca che egli rappresenta. Quando ci si accosta a Dante, infatti, diventa necessario un coinvolgimento nel clima di visionarietà in cui allora si era immersi. Il passaggio dall’immagine «reale», al sogno, alla «visione» – nel senso di comunicazione con un altrove – non presentava particolari soluzioni di continuità. Esiste anche oggi, a macchie, un simile clima; penso per esempio al caso di quel distretto del nostro Sud in cui per molti anni «tutti» vedevano «qualcosa» (l’antropologo Paolo Apolito ne ha dato ampia relazione). E ovviamente ci si dovrà soffermare sul fatto che il mondo degli Evangeli è tutto inserito entro il contesto di un dramma cosmico di lotte: una concezione, questa, che attraversa i secoli per arrivare fino a Milton, a Goethe, (per non dire a Bulgakov…). Tommaso d’Aquino, immagine stessa di un realismo razionalistico di base aristotelica, ha una famosa visione in cui Cristo loda quanto il filosofo ha saputo dire di lui («Bene dixisti de me, Thoma»).
 La campagna elettorale Usa è non solo l’evento politico per eccellenza, ma anche una gigantesca macchina comunicativa. Abbiamo chiesto ad Alberto Simoni, giornalista di Avvenire, autore di G.W. Bush e i falchi della democrazia (Falzea) e Cambio di rotta. La dottrina Bush e la crisi della supremazia americana (Lindau) e curatore del blog blogwolfie.com, da poco rientrato dal Sud Carolina, di aiutarci a capire come è cambiata e come funziona questa macchina.
La campagna elettorale Usa è non solo l’evento politico per eccellenza, ma anche una gigantesca macchina comunicativa. Abbiamo chiesto ad Alberto Simoni, giornalista di Avvenire, autore di G.W. Bush e i falchi della democrazia (Falzea) e Cambio di rotta. La dottrina Bush e la crisi della supremazia americana (Lindau) e curatore del blog blogwolfie.com, da poco rientrato dal Sud Carolina, di aiutarci a capire come è cambiata e come funziona questa macchina.
 Se ben ricordo l’incontro con
Se ben ricordo l’incontro con 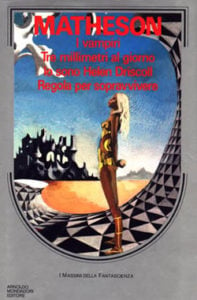 Ordinai scandendo bene le lettere del cognome e dovevo solo attendere dai tre ai cinque giorni lavorativi.
Ordinai scandendo bene le lettere del cognome e dovevo solo attendere dai tre ai cinque giorni lavorativi.